|
|
 La meccanica della morte
La meccanica della morte 
|
  Il Sostituto Procuratore.
Il Sostituto Procuratore.
Il Sostituto Procuratore è una donna.
Ha i capelli ricci biondo cenere, su un viso denso di rughe, ossuta, bassa, sarà un metro e sessanta. Ha i capelli di una ventenne sulla testa di una vecchia, e questo è disarmonico, brutto. Ributtante. Dalle dita giallastre della mano destra, so che è o è stata un'accanita fumatrice, senza filtro. Sta acquattata alla sua scrivania, e non mi guarda entrare. Il carabiniere mi fa sedere su una sedia di legno, di fronte alla scrivania, e resta dietro di me.
La stanza è piccola, polverosa, con il pavimento di legno usato, e si sente quell'odore tipico degli uffici pubblici, uguale a quello del carcere. Vorrei andare a pisciare, ma taccio, mi tengo finché posso. Sono stanco, indifferente, non m'importa nulla, di nulla, al di qua del ponte. Superato il ponte cambia la prospettiva, ogni cosa è uguale a prima, ma diversa, come m'avesse risucchiato una tromba d'aria e portato di là del mare, in una terra sconosciuta.
Alle mie spalle sta un altro carabiniere, più giovane, di fronte a un computer. Il Presidente della Repubblica mi guarda serio dal ritratto appeso al muro, assieme al crocefisso.
Dietro al magistrato c'è una fila di calendari della Benemerita, appesi a una cordicella, e mi perdo a guardarne le copertine, con impressi gli anni di edizione. 2016, 2017, 2018, 2019... che facevo nel 2019, di là del ponte? È stato l'anno che abbiamo rifatto il bagno? Irma! Che ne sarà di mia sorella? Niente, se la caverà benissimo, anche nella vergogna. Si è sempre un po' vergognata di me, ora di più, ne ha tutte le ragioni, come darle torto? Avrà problemi al lavoro?
La donna magistrato alza gli occhi, sono chiari, mi guarda. Me la immagino sotto, che miagola come fanno le donne Certo coprendole quel viso da vecchia, e anche lei...
«Toglietegli la manette», esordisce la donna, e il carabiniere traffica con i ferri, mi libera le mani.
«Vedo che non ha un avvocato, vuole nominarne uno?»
Non rispondo. Lo ha detto gentilmente, ma precisa. È una abituata a ricevere risposte, lo sento, anche se è bassa ed è una donna. Che vuoi che le dica? Non ho soldi per un avvocato, questo direi, e a che servirebbe un avvocato?
Le nuvole oggi corrono scure, fuori dalla finestra.
«Marin, vedi chi c'è d'ufficio oggi», continua la donna, e sento il carabiniere alle mie spalle che si alza ed esce. Non succede nulla per un po', solo silenzio, quella continua a leggere le sue carte, dove immagino ci sarà scritto dei miei delitti e delle mie pene.
Che le importa? Poi va a pranzo a casa sua, si lava le mani, e la coscienza. Magari ha un marito, di sicuro queste hanno un marito, e dei figli per bene, in una casa per bene, una vita per bene. E la bilancia per pesare il bene e il male. Che cazzo di mestiere!
Ho spento le luci dell'albero? Alla Irma sarà piaciuto il regalo? Che regalo che le ho fatto povera sorella mia! Mi hanno tolto le stringhe delle scarpe, e la cintura, per paura che mi suicidi. I pantaloni non mi cadono, però, per fortuna. Mi immagino di restare in mutande, davanti alla legge, con le mie gambe glabre e secche, ma non riesco a ridere, solo pena, pena di me.
Che mi ha preso?
Ora non ha senso, ora che è tutto spento, ma è stato esaltante finché è durato. Così deve essere drogarsi, immagino. Sono un uomo insignificante, anche mediocre, lo ammetto, ora mi vedo, ora mi misuro, che non val nemmeno la pena, signora magistrata, di perdere tempo con me. Ma lo so che la meccanica della giustizia una volta azionata va per conto suo, sopra a tutto e tutti: avanza, ruota, stritola, vite sogni e tempo, accomunando vittime e delinquenti.
Dicono che l'uomo abbia un innato desiderio a confessare, a narrare la propria storia. Io non ho questo desiderio, io non sento nulla, solo stanchezza, mentre il passato mastica il presente.
Non ho più nulla da perdere, poiché ho perso tutto. Non è questo il potere?
Ma insisto: si può dire che io sia un delinquente? Io sono arrivato dopo, ho solo approfittato della situazione, mi sono lasciato prendere dalla situazione, e liberato qualcosa che evidentemente c'era già dentro di me, ecco, sì, questa è la colpa. Liberare la bestia che ognuno contiene, ma che i più tengono a bada, almeno fino a che...
«Buongiorno signor giudice» entra uno, dietro di me.
«Buongiorno avvocato, si prende lei cura del signor Teso qui presente?»
Sono ancora “signor”, poi si passa al tu, tutti ti danno del “tu”, e sei solo un carcerato.
Mentre quelli parlano, mi viene a mente di quando scalavo il campanile nella chiesa deserta, nelle lunghe estati vuote della mia adolescenza, quando facevo l'esploratore.
C'era quella porta proibita, a fianco dell'altra che portava al grande organo, e l'odore di cera e incenso. Non so perché, immaginavo che ci fossero delle bare là dietro, e morti dal ghigno tremendo. Con il batticuore guardavo in su, al vuoto nero dal quale pendevano le corde delle campane, e la scala a pioli che portava al primo pianerottolo, poi al secondo un'altra, e così via fino alla cima del campanile.
Il timore era sbucare a ogni pianerottolo dove potevo scoprire non so quale orrore, ma caparbio comunque salivo.
Avrò avuto dieci anni. Solo ora mi rendo conto del pericolo, non di incontrare cadaveri ma di diventare cadavere cadendo da quelle improbabile scale a pioli, ognuna delle quali saliva per almeno sei metri, su fino alla terrazza in cima a tutto, alla quale si arrivava da una botola con il coperchio di ferro. E lì la conquista della vetta, della visione del paese dall'alto, a fianco dei campanoni che a quell'età mi sembravano enormi.
Un'emozione che faceva il paio con l'altra, di quando vagavo di notte a spiare la gente nelle loro case, attraversando i campi di grano nel buio senza nessuna paura, perché mi dicevo “il male sono io”... Risate.
Da una finestra mi piaceva spiare quella moretta che veniva d'estate, ospite dagli zii che avevano un distributore in centro al paese, l'unico distributore. Una moretta con la camicetta verde e la gonna bianca, e la frangetta. Mi piaceva molto, ancora non capivo, non sapevo di che.
Le femmine, il femminile, mi hanno sempre attratto molto, senza un nome o un perché, da quando ancora non avevo ragione.
In paese donne e sesso erano una faccenda “da grandi”, misteriosa quanto sconosciuta.
«Ci ascolta?» chiede la magistrata. La guardo.
«A verbale che l'imputato non risponde. Senta, questa cosa può essere spiacevole, o molto spiacevole, lo capisce? Glielo spieghi lei avvocato.»
E l'avvocato mi parla. Si capisce che non gliene importa molto, o nulla, ma neanche a me non importa nulla.
Che posso dire? Che posso cambiare? Nulla posso cambiare. Ciò che è stato è stato, facciamola corta. Ma lo so che c'è il rituale da rispettare, quindi non mi oppongo, ma nemmeno possono pretendere che collabori, no?
La donna, lo sento in sottofondo, sta elencando i fatti come ritiene siano avvenuti, che io qua e io là, e che allora, e che ho fatto questo e quello...
Che ne sai che ho fatto? C'eri? Lei parla, il carabiniere alle mie spalle scrive al computer, sento il tic tic tic, ogni tanto l'avvocato interviene, che dovrebbe prima parlarmi no? Sentire che ho da dire a mia difesa. Ma io non ho nulla da dire e nemmeno da difendere, e la donna, ora lo sento, è un po' seccata per il mio non collaborare, e la cosa non può farmi che piacere. No, non ho nessuna voglia di collaborare alla mia incriminazione, non ho voglia di spiegare l'inspiegabile, di cose che nemmeno io so. E poi mi stai antipatica, vecchia rinsecchita.
«Andiamo all'obitorio», dice la donna alzandosi.
«Lo ritiene necessario?» azzarda l'avvocato.
Credo sia una cosa che di solito non si fa.
«Ho bisogno di una risposta, e credo che all'obitorio ci sarà, se non è un mostro», ha detto così “un mostro”. Sono un mostro? Che ne so che si sente a essere un mostro? Forse sì.
Mio padre aveva delle mani come le mie, forse con delle dita più grosse, e fortissime. Se ti acchiappava erano dolori, ma non mi hai mai picchiato, preferiva lo facesse quell'isterica di mammà: “i figli se ne ricordano”, diceva lui, forse pensando alla sua infanzia. Ma forse no.
L'unica foto sfocata che ho visto di mio nonno e mia nonna, fatta a inizio ‘900, era l'immagine di due persone miti, serie, che non c'era molto da ridere all'epoca.
Mio nonno morì per un'appendicite. Venne il medico e sentenziò di fargli un clistere, non aveva capito di che soffrisse mio nonno, e con quel clistere l'uccise. “Che m'avete fatto figlie mie...” pare fossero state le ultime parole del nonno.
La notte dell'otto settembre del '43 mio padre faceva il soldato in una caserma a Torino, quando i tedeschi lo “rastrellarono” a sorpresa con tutta la guarnigione, e caricato su un vagone piombato lo spedirono in Germania, la Grande Germania, a lavorare in un campo di concentramento dove facevano aeroplani, forse i famosi caccia Messerschmitt.
Me lo immagino mio padre, che non è mai stato un eroe, alto, moro, con i baffetti da gagà, caricato come bestiame in viaggio verso la morte, per quel che ne sapeva. Me lo immagino che si cagava addosso, morto di fame come tutti gli altri dopo anni di guerra.
Per sua fortuna al paese faceva il falegname, e lì al campo di concentramento si arrangiò con le mogli dei militari tedeschi, a fare mobiletti, o aggiustava, segava, piallava. In cambio quelle gli lasciavano raccattare le bucce di patata, e davano qualche sigaretta da scambiare con il pane nero: piccoli tesori che erano un prolungamento di qualche giorno di vita. Così ci raccontava.
È morto prima che potessi chiedergli meglio, ma conosco quel cercare di avere un giorno in più, lo trasmetteva nel suo racconto di bucce di patate e tozzi di pane da cui togliere un centimetro di muffa. Pane e pulci, e bucce di patate.
Io sono nato dopo, molti anni dopo. Che mi avrà trasmesso? La fame?
Me lo ricordo, vicino al fornello a due fuochi, smaltato bianco, con sotto la bombola del gas che l'omino sostituiva quando finiva, collegata a un tubo blu di gomma.
Me lo ricordo che preparava il sugo, che doveva sobbollire lento per ore, “pippare”, e in quel sugo, ora lo so, annegavano tutte quelle bucce di patate trangugiate per guadagnare un giorno in più.
«Ha nulla da dichiarare in merito?» mi ha chiesto la donna, sottraendomi ai miei pensieri. Scuoto il capo negando ogni dichiarazione. Nulla da dire in merito.
Mi rimettono le manette. Mi portano lungo i corridoi dove altri uffici, altri carcerati, altri magistrati, ripercorrono delitti e pene. I carcerati mentendo negando, i magistrati cercando i chiodi per inchiodarli alle loro responsabilità, come si dice. Ognuno frugando nelle fogne dell'umana natura.
L'avvocato e la donna sono rimasti a confabulare tra loro, immagino di me, dei miei delitti.
Ne parleranno i giornali? Che diranno? Quelli ne sanno ancora meno, ma lo sanno dire bene.
Andranno a chiedere ai vicini? Ai miei compagni di scuola? Che tipo era il Gino? Che vizi aveva? Già da piccolo? “Torturava gli insetti”, potrebbe dire Sartor, terza elementare, ultimo banco sotto le finestre.
Non torturavo gli insetti, volevo solo sapere come funzionavano, come erano fatti. Li smontavo. Come funzionava il motore delle ali delle farfalle, dove erano collegate? E le bellissime libellule, che sembravano elicotteri? Sì, avevo anche fatto un mini spiedo in fil di ferro, dove rosolavo le vespe sul fuoco di un batuffolo di cotone; ma quello era colpa di Salgari e i suoi libri sui cannibali che rosolavano i cristiani. Che effetto fa? Speculazione scientifica, non crudeltà.
Ora se c'è una mosca apro la finestra per farla uscire, ho rispetto per empatia di ogni forma di vita.
E come lo spiega quel che è accaduto? Interruzione dell'empatia, o altre superiori curiosità, o vizi, o voglie. Forse sì, sono un mostro, silente. Lo sono sempre stato probabilmente, mi mancava l'occasione per manifestarmi.
Forse colpa di quella parola che mi ha ossessionato per anni, quel “callipigia”, la Venere Callipigia delle medie, lezione di storia dell'arte. La Venere dal “bel culo”. Quelle curve, quella fessura, quelle fessure, che portano, come la pista illuminata dell'aeroporto, verso il mistero femminile, nascosto, indicibile. E sì, mostro sessuomane probabilmente, fin dalla più tenera età.
Si può farmene una colpa? Uno nasce con gli occhi azzurri, un altro nasce mostro. E tra i mostri uno nasce sessuomane, fissato con quelle labbra nascoste e misteriose, senza sapere che cosa in realtà l'attiri fino a diventarne vizio.
Il furgone della penitenziaria va nel traffico di Mestre, quel coagulo indefinito, mezzo dormitorio e mezzo apparato industriale, da cui esce il Ponte della Libertà, stradone e ferrovia fino a Venezia.
Natale è passato, finite le feste, i regali, il cappone e il panettone. Non ho nemmeno mangiato il pandoro quest'anno. Sono arrivato in carcere che le feste erano già finite, e a casa, con quel trambusto, quei fatti, il pandoro è stato dimenticato. Ora ne avrei davvero voglia.
La gente mi scorre attorno, e nemmeno vede quell'uomo tra le sbarre del furgone; corrono, vanno, formiche impazzite, loro sono “di là del ponte”. C'ero anch'io, fino a una settimana fa. Solo sette giorni! Mi sembra una vita fa, e lo è.
In isolamento non si sta male, leggo, dormo, soprattutto dormo. Anche il carcere, in fondo, non è nulla di terribile. Umiliante, sì, che t'infilino un dito nel culo per vedere se hai nascosto qualcosa, qualcosa cosa? Merda, a volontà. Mi dispiace non avergli scoreggiato in faccia. E claustrofobico che ci sia la luce sempre accesa, e che di notte non ci sia nessuno in giro, chiuso nella cella, nella scatola, che sembra che le pareti si stringano...
Bisogna imporsi di non pensarci.
È stata una cosa nuova il carcere, che pare al momento non normale, ma dopo un po' lo diventa.
Anche al carcere ci si abitua, se ne scopre lo schema. Si vive di abitudini, come tutti.
Nella vita raccogli quel che semini. Non sempre, vero, ma quasi. Se sei convinto di aver successo, facile che tu abbia successo, se sei convinto di non valere nulla, nulla avrai. L'immagine che hai di te modella quel che sei, ogni giorno della tua vita.
Che ho seminato dunque nella mia vita? Ho cercato solo di galleggiare, di arrivare a fine mese, a fine anno, non ho mai avuto grandi ambizioni.
Nella via la gente scorre come un film, persone nei loro cappotti, nei loro sorrisi festivi, nelle loro vite lontane. Soprattutto tanti ragazzi.
Che ne sanno quelli? Che ne sapevo io?
I dolori dei ragazzi passano, i dolori dei vecchi sono indelebili: non hanno nulla di nuovo da sovrapporre.
Al semaforo il furgone si ferma e ho tempo di vedere bene, sul marciapiede, un gruppo di ragazzi, appunto. Tra loro ridono, nemmeno si accorgono di me che li guardo, li invidio. Non solo per oggi, li avrei invidiati anche una settimana fa. C'è una bella rossa, in un cappotto nero e una sciarpa bianca, e quella nuvola di capelli; ma il furgone si muove, e i ragazzi e l'invidia restano lì all'incrocio, in una vita che non mi appartiene più.
Mi viene a mente Lorena, quell'estate a Riccione, l'unica estate nella quale io abbia fatto “il ragazzo al mare”, con tutte le scemate che si fanno. Lorena non era rossa vera, era rossa solo di capelli, e mora per il resto. Ricordo le nostre pance sudate, bagnate, nel fervore di quel sesso ginnico che mi pareva si dovesse fare così, e lei con gli occhi chiusi che sospirava “dai... dai... dai”, imponendomi il ritmo di vogata.
Non ricordo nemmeno se mi piacesse, tanto ero intento a guardare quel miracolo che si era compiuto nella mia prima ragazza, e scopata. Che anno era? È stato un unico anno così. Poi altre due, tre donne, in tutta la vita. “Tutte le donne che ho avuto fin qui, m'hanno soltanto sbranato di più...” tutte meno l'ultima, che stiamo andando a trovare ora.
Perché tutto questo? Non lo so. Davvero.
Nel mentre era come avere un immenso potere che addirittura fischiava alle orecchie, che nessuno potesse dirti di no, lei meno di tutti.
L'obitorio è quello dell'Ospedale Maggiore. Ci si arriva per un vialetto che a primavera è in mezzo a piante e fiori, ora solo resti di neve sporca, e vegetazione annerita dall'inverno.
L'ingresso è anonimo, vuoto, senza scritte: una grande stanza chiara, ben illuminata dalla luce azzurra dei neon. Poi un'altra porta a vetri, un corridoio, e là s'inizia a sentire un odore di disinfettante, di cloro, poi altre porte, chiuse.
In fondo c'è il magistrato, la donna, già arrivata, con un paio di carabinieri e l'avvocato.
Arriva anche Gino, scortato dalle guardie carcerarie, con una che lo tiene sottobraccio, i polsi ammanettati come da regolamento.
Gino tiene gli occhi bassi, non vorrebbe essere lì, ma invece ce lo stanno portando, quasi di peso.
Lo sguardo della magistrata è duro, critico, senza sconti.
Aprono una porta, grande, ed entrano tutti in una stanza illuminata a giorno. Vi sono disseminati diversi tavoli d'acciaio sui quali giacciono forme umane coperte da lenzuoli bianchi, forme che dormono il sonno della morte. È più freddo qui dentro che fuori, e i due addetti vestono un piumino rosso sopra la divisa da infermiere; portano anche guanti pesanti, e berretti di lana. Attendono in piedi presso la parete a sinistra, che è formata da file di portelli in acciaio su tre livelli.
«La ventidue per favore», indica la magistrata, e si stringe il cappotto alla gola.
Uno dei due infermieri fa scorrere un carrello che si alza fino alla seconda fila, apre il portello, ne estrae un bozzolo bianco adagiato su una lettiga a cucchiaio, sempre d'acciaio. È la numero ventidue.
Il carrello scende all'altezza di un tavolo, e lo portano sotto le luci al centro della stanza.
La magistrata si pone a capo di quella lettiga, e fa un cenno al carabiniere che spinge Gino verso quella forma stesa sotto le luci.
«Lo riconosce questo?» gli chiede, alzando un quaderno, un suo quaderno, quello dei conti, facente funzione anche di diario.
Gino alza la testa, guarda quella donna, guarda gli infermieri, i carabinieri... Quanta gente si è mossa per lui!
|
|
|
Votazione per
|
|
WriterGoldOfficina
|
|
Biblioteca
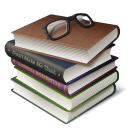
|
Acquista

|
Preferenze

|
Recensione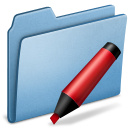
|
Contatto

|
|
|
|
|
|
|
|
Conc. Letterario
|
|
|
|
Magazine
|
|
|
|
Blog Autori
|
|
|
|
Biblioteca New
|
|
|
|
Biblioteca Gen.
|
|
|
|
Biblioteca Top
|
|
|
|
Autori
|
|
|
|
Recensioni
|
|
|
|
Inser. Estratti
|
|
|
|
@ contatti
|
|
|
Policy Privacy
|
|
 Autori di Writer Officina
Autori di Writer Officina 
|
|
|
 Ho effettuato studi artistici all'Accademia a Venezia. Ho iniziato come regista e scenografo in teatro, per passare poi alla televisione. Nel '95 cambio vita, e parto per il Cile, poi per la Cina, dove lavoro per molti anni come consulente. Ho girato gran parte del mondo, incontrando popoli e culture, fino a Ushuaia, finis terrae. D'altronde credo che prima di scrivere sia necessario vivere, conoscere, e così ho cercato di fare. Avevo sempre con me il mio taccuino, sul quale annotavo le impressioni di viaggio, e le storie dei viaggiatori. Così è nato, per esempio “Foglie nella corrente”, ma anche altri miei romanzi. Frequentando il teatro, sia prosa che lirico, mi è rimasta una visione strutturata della narrazione e del piacere di narrare, uniti al piacere di divulgare con vari strumenti le vicissitudini e la condizione umane. Ora vivo a Treviso, in una casa sul fiume, e insegno cinema e sceneggiatura Ho effettuato studi artistici all'Accademia a Venezia. Ho iniziato come regista e scenografo in teatro, per passare poi alla televisione. Nel '95 cambio vita, e parto per il Cile, poi per la Cina, dove lavoro per molti anni come consulente. Ho girato gran parte del mondo, incontrando popoli e culture, fino a Ushuaia, finis terrae. D'altronde credo che prima di scrivere sia necessario vivere, conoscere, e così ho cercato di fare. Avevo sempre con me il mio taccuino, sul quale annotavo le impressioni di viaggio, e le storie dei viaggiatori. Così è nato, per esempio “Foglie nella corrente”, ma anche altri miei romanzi. Frequentando il teatro, sia prosa che lirico, mi è rimasta una visione strutturata della narrazione e del piacere di narrare, uniti al piacere di divulgare con vari strumenti le vicissitudini e la condizione umane. Ora vivo a Treviso, in una casa sul fiume, e insegno cinema e sceneggiatura
Writer Officina: Qual è stato il momento in cui ti sei accorto di aver sviluppato la passione per la letteratura?
Raffaele Boccia: La passione c'è sempre stata. Alle elementari mi faceva compagnia un librone, che ho ancora, “L'enciclopedia della fiaba”, edizione 1949 illustrata da Aleardo Terzi. Poi alle medie, tutta la serie degli Oscar Mondadori, benefica edizione che mi permise di scoprire molti autori, il mio preferito Hemingway che mi ha insegnato a scrivere. E poi migliaia di altri libri, mondi, fino ad oggi. In realtà, ho iniziato a scrivere in modo strutturato quando frequentavo il cenacolo di Ermanno Olmi “Ipotesi Cinema”. Lì si progettavano storie, che diventavano sceneggiature. E la sceneggiatura è stata la mia prima forma di scrittura. Cosa che ha in seguito influenzato anche il mio modo di scrivere racconti e romanzi. Ma anche teatro.
Writer Officina: C'è un libro che, dopo averlo letto, ti ha lasciato addosso la voglia di seguire questa strada?
Raffaele Boccia: I 49 racconti di Hemingway. Ho sempre amato quella scrittura asciutta, senza fronzoli. In particolare gli intermezzi che ammiro molto. In effetti non ho mai voluto essere uno scrittore, e non reputo esserlo nemmeno oggi. Semplicemente mi piaceva e mi piace scrivere, lo trovo naturale come espressione. Raccontare.
Writer Officina: Dopo aver scritto il tuo primo libro, lo hai proposto a un Editore? E con quali risultati?
Raffaele Boccia: Al primo no, al terzo, ho pensato di provare, da perfetto ignorante del mondo dell'editoria. Nessuna risposta. Poi ho imparato che serve, oltre a un buon testo, tenacia fortuna marketing. Tutte attività che mi annoiano e non mi interessano. Così, per distribuire i miei libri ad amici e conoscenti, ho pubblicato su Amazon, e mi ritengo soddisfatto. Mai avuta l'ossessione di essere “pubblicato”, inoltre magrissimo il ritorno economico, e altissima la concorrenza che diviene un rumore di fondo dal quale è quasi impossibile emergere. Ci sarebbero i così detti “social”, vero, ma proprio non fanno per me.
Writer Officina: Ritieni che pubblicare su Amazon KDP possa essere una buona opportunità per uno scrittore emergente?
Raffaele Boccia: Ritengo di sì, se si ha un pubblico potenziale al quale rivolgersi. Pubblicare e basta, senza una qualche promozione, è sicuro insuccesso, inteso come mancanza di lettori. Se uno pubblica è per diffondere, avere un pubblico, a quel che scrive. Non avere pubblico è come un attore che reciti in un teatro vuoto.
Writer Officina: A quale dei tuoi libri sei più affezionato? Puoi raccontarci di cosa tratta?
Raffaele Boccia: Come si dice di solito, “non ho figli prediletti”. Ho scritto di mondi e personaggi diversissimi tra loro, pur con una matrice comune costituita dal mio vissuto. Se proprio dovessi scegliere un regalo, inizierei con “Libro dei baci perduti”, che non è un romanzo, ma un taccuino di meditazioni su amore, universo, vita e morte. Cioè quel che ho imparato vivendo. Tra i romanzi forse il primo scritto, “Rio della Misericordia”, una storia distopica di amore e morte, ambientata a Venezia. Si parla di un morbo che avvolge il mondo, e dei personaggi che cercano di sfuggirgli. Una storia d'amore con altre storie a corollario. No, non parla del Covid, è stato scritto nel 1983 come prima stesura.
Writer Officina: Quale tecnica usi per scrivere? Prepari uno schema iniziale, prendi appunti, oppure scrivi d'istinto?
Raffaele Boccia: Non uso nessuna tecnica o schema. Prendo degli appunti su un'idea iniziale, un punto della storia, e lascio decantare. Quando la storia decide di essere raccontata mi siedo e la scrivo. Nei 2-3 mesi che impiego nella stesura, vivo in simbiosi con i personaggi, li vedo agire e parlare, e semplicemente descrivo quel che vedo. In un certo modo, così si scrivono le sceneggiature, nelle quali si descrive unicamente quel che accade, con il limite di dover tralasciare quel che i personaggi pensano o sentono. I romanzi differiscono dalla sceneggiatura appunto perché non hanno questo limite.
Writer Officina: In questo periodo stai scrivendo un nuovo libro? È dello stesso genere di quello che hai già pubblicato, oppure un'idea completamente diversa?
Raffaele Boccia: Ho appunti per almeno tre-quattro nuovi romanzi, ma nessuna di queste storie ha ancora la forza immaginativa per essere scritta. Non ho fretta. Se qualcuna di esse, o un'altra, si fa avanti, la servirò con piacere. Io credo che chi scrive sia solo un tramite tra la storia che vuol essere raccontata e le parole per raccontarla.
|
|
Tutti i miei Libri
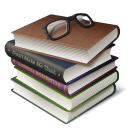
|
Profilo Facebook

|
Contatto

|
|
|
|