|
|
 Ceneri
Ceneri 
|
  Milano, lunedì 6 dicembre 1943.
Milano, lunedì 6 dicembre 1943.
Ore 7:54
“Il treno era in partenza per una destinazione a me ignota.
Avevo udito da qualche adulto che avremmo viaggiato sul famoso binario 21, quello del non ritorno.
Ero già stato dolorosamente separato da mia madre. E così tutti gli altri bambini come me, suddivisi più o meno per fasce di età.
Il nostro scaglione venne fatto, diciamo così, accomodare nell'ultimo mezzo sgangherato vagone postale, in piedi e in sovraffollamento.
Ci avevano distribuito limitate razioni di pane secco e acqua che ci saremmo dovuti far bastare per i giorni a venire, intuii.
L'alto numero di persone non consentiva, in teoria, di potersi sedere o si finiva col restare schiacciati da qualcun altro.
Ma una volta partito il treno della morte, pian pianino, cercammo un po' tutti di metterci più a nostro agio.
Viaggiammo quasi senza sosta, se non a determinate stazioni dove sbattevano dentro altri deportati.
Il vagone era in penombra, realizzato, tutt'intorno con assi di legno orizzontali affiancate l'una all'altra in colonna; non vi erano finestrini, né spiragli per guardare fuori. Le poche prese di aria, consistenti in griglie metalliche, si trovavano in alto e sulle porte scorrevoli e ci consentivano a malapena di respirare vista l'insufficienza di aperture rispetto al numero di occupanti del vagone.
Nonostante fossimo accalcati in tantissimi, il freddo si avvertiva eccome!
Non facevo altro che tremolare per la bassa temperatura, che sembrava scendere sempre di più a mano a mano che si procedeva.
Lo sferragliamento del treno era fragoroso e infernale e non mi consentiva di assopirmi durante la notte, solo di restare nel mio dormiveglia, seduto per terra, con la schiena schiacciata contro quella di una bambina e le gambe ricurve sulle quali si era adagiato un altro ragazzino.
A dispetto dell'ambiente scuro, qualcosa, forse semplice intuito, mi sussurrava che si trattasse dello quello stesso che aveva cercato di portarmi via la razione di cibo e acqua appena entrati nel vagone.
Doveva avere subito consumato la sua, in preda a una fame intensa.
Ci riprovò mentre stavamo scendendo dal treno della morte, una volta arrivati a destinazione.
Io me ne accorsi per tempo, mi voltai e cercai di riprendere seduta stante il sacchetto.
La colluttazione che ne derivò fu causa di scompiglio e rallentamento della fila.
Un paio di soldati accorsero a dividerci, gettando via il fagottino per poi trascinarci per i colletti delle camicie davanti a tutti gli altri, sotto stretta sorveglianza.
Io inciampai lungo il tragitto e caddi per terra. Ci pensò uno dei due militari delle SS a farmi tornare in piedi a calci nel culo.
Il mio antagonista mi mostrò una sadica smorfia di compiacimento.
Io, lui e alcuni altri fummo condotti direttamente in una baracca, dove c'era ad attenderci un certo dottor Josef Mengele.
Lo avevo già sentito nominare da qualche altro deportato sul camion, come “der weiße Engel”, l'angelo bianco, forse per via dell'inseparabile camice e il finto accomodante atteggiamento.
Il soldato che mi aveva preso a pedate scambiò qualche parola con lui –incomprensibile per noialtri in tedesco – quindi ci spinse al suo cospetto.
Aveva, a tutti gli effetti, un'aria all'apparenza placida e fu molto affabile con noi due in un primo momento.
Ma a scrutarne bene l'espressione sinistra, un ghigno raggiratore stampato in volto, le sopracciglia aggrottate sotto una fronte larga, sovrastata da una capigliatura pettinata all'indietro e ricolma di brillantina, si poteva benissimo immaginare che qualcosa di allarmante si celasse sotto un simulato modo di fare rassicurante.
Il suo sguardo poteva trasmettere un concetto chiaro e conciso: “Io sono il potere”.
Cominciò a passeggiare attorno a noi due, ormai forse un nucleo isolato, accomunati da un medesimo, strano destino, mentre si lisciava il mento con l'indice e il pollice della mano destra.
Ogni colpetto di tacco di stivale sul pavimento mi generava un sussulto; l'altro bambino, invece, tremava come una foglia.
Alla fine si pose ritto dinanzi a noi, e impartì un ordine ben preciso – sempre in tedesco – ai suoi subordinati.
Il ragazzino a fianco a me venne portato via, dimenandosi e in lacrime, per essere avviato, assieme ad altri, a sicura camera a gas.
Egli appariva paffutello nonché bassino rispetto a quanto lo fossi io, più alto ma estremamente magro, soprattutto in viso.
Molti anni più tardi, durante i miei studi, mi capitò di leggere diversi articoli su di un'infezione nota come “stomatite gangrenosa”; potei dedurne che Mengele mi avesse scelto per i propri esperimenti scambiatomi per un soggetto affetto da tale patologia. Aveva forse pensato, in un primo momento, che facessi già parte del lager e che quell'effetto derivasse da malnutrizione.
Di certo un errore di valutazione che mi avrebbe salvato la vita, oltre a un pizzico di fortuna.
Fui fatto spostare in un angolo più in ombra della baracca, in attesa della “selezione” di tutti gli altri.
La frase che rivolse al resto dei bambini, in un italiano stentato, fu: «Chi vuole andare a trovare la mamma, faccia un passo avanti».
I più ingenui cascarono nel trabocchetto come pere secche.
Mengele dispose che tutti i componenti del gruppetto venissero confrontati, in altezza, con una linea orizzontale, elevata esattamente di centocinquanta centimetri dal pavimento.
Quelli più bassi di tale livello seguirono a ruota il ragazzino di poco prima, gli altri vennero indirizzati verso la posizione in cui ero io.
Erano già pronte per noi delle uniformi di varie taglie, ammassate su di un tavolino traballante.”
Auschwitz, lunedì 13 dicembre 1943
Ore 10:22
“L'angelo bianco si trasformava talvolta nell'angelo della morte.
Io e alcuni altri eravamo ad aspettare da un bel po', su dei sedili sudici in sala di attesa, di essere convocati uno alla volta, o a coppie in caso di gemelli, per l'onorevole visita da parte del dottor Mengele.
Secondo incontro che non poteva significare altro se non un'ulteriore setacciatura.
Alla fine il medico venne fuori dall'ambulatorio, anche se io – e penso fosse opinione dei più – avrei preferito vi fosse rimasto rinchiuso a tempo indeterminato.
Reggeva per i capelli, con le dita della mano destra, la testa di un bambino romano, un po' come Perseo con il capo di Medusa per pietrificare il Kraken.
L'orrida visione si insinuò nella mia mente a impregnarmi l'animo. E lo avrebbe fatto in maniera indelebile.
Talvolta mi sveglio di soprassalto da incubi in cui compare puntualmente quella testa, con gli occhi sbarrati e smorti, tracce di sangue ormai essiccato dall'incavo orale al mento, il labbro inferiore penzolante in su e in giù, simile a quello di un pesce che respira sott'acqua.
In molti chiusero gli occhi per non guardare. Io non feci a tempo.
«Vi fa paura qvesta?» ci chiese il medico, divertito, mentre metteva il capo del malcapitato in mostra. «No panico! Essere bimbo morto per “noma”. Io stare soltanto inviando testa a laboratorio di SS per esame. Io voler solo gvarire qvalcvuno di voi da malattia» e si avvicinò a me, con chiara allusione, forse in preda alla fissa che fossi affetto per davvero da stomatite gangrenosa.
Venni a sapere poi, in età adulta, che le finalità degli studi del medico fossero legate alla fisima di ricercare le cause del malanno in origini genetiche o razziali.
Molto più tardi il dottore si sarebbe arreso, scartando in via definitiva tale ipotesi, dinanzi alla lampante evidenza che le cause della “noma” risiedessero in primis nell'alimentazione insufficiente e nelle invivibili condizioni igieniche del campo. I suoi colleghi medici, deportati e non, erano arrivati alla stessa evidente conclusione già molto prima di lui e senza necessità di alcun sacrificio umano – specie di bambini.
Quando rientrò in ambulatorio, un soldato condusse dentro un paio di ragazzine sedute prima di me, entrambe con gli occhi eterocromi. Si somigliavano a tal punto che avrei giurato fossero gemelle.
Una delle due si lasciò condurre all'interno senza fare storie. L'altra, colta da un attacco di panico, ancora suggestionata dalla vista della testa di poco prima, cercò di resistere, frignando, al trascinamento verso il laboratorio con tutte le forze che aveva in corpo.
Mengele venne fuori di lì alla svelta e fece cenno al soldato di lasciarla.
Si chinò, le pose le mani sulle spalle e cercò di spiegarle: «Io ti capisco, piccola, sai? Paziente che non vuole visita medica non obblicata a farla». Poi si tirò su e allargò le braccia. «Vedi, tu completamente libera!»
Senza indugiare un solo istante le aprì una porta per permetterle di passare a una camera adiacente; le fece poi presente che la sala in questione comunicava con il fabbricato dove doveva trovarsi sua mamma.
La bimba abboccò subito all'amo, in cerca di un immediato grembo rassicurante.
Rabbrividimmo tutti quando l'efferato medico si fece passare una rivoltella da una delle guardie, ma nessuno di noi fece in tempo a gridare che vedemmo, con terrore implacabile, l'ombra della bambina fatta fuori da quella di Mengele.
Alcuni schizzi di sangue macchiarono la parete a noi visibile, sulla quale venivano proiettate le ombre dalla luce interna.
Due infermieri accorsero con una barella per raccogliere il corpicino ormai inerme della fanciulla.
Il dottore raccomandò loro qualcosa, forse riguardo agli occhi, visto che puntava l'indice della sinistra verso di essi.
Io sussultai di nuovo quando si rivolse a me di scatto, invitandomi gentilmente a entrare.
Nella sala operatoria un altro paio di operatori sanitari avevano legato l'altra bimba a un lettino, col torace scoperto. Uno di loro si accinse a iniettarle una dose di fenolo nel cuore.
Sembrava, tuttavia, incapace di praticare una semplice iniezione.
A quella vista Mengele andò ancora una volta fuori dai gangheri, gli strappò la siringa di mano e ne iniettò a lui il contenuto nella gola, quindi lo spinse via affinché cadesse al tappeto in un punto della sala più lontano.
Disse qualche altra cosa in tedesco al solo assistente rimasto in vita lì dentro, oltre me e la bambina.
Quest'ultima tremava inesorabilmente e l'infermiere ancora più di lei, vista la fine del suo collega di poco prima.
Il medico riacquistò il suo atteggiamento cordiale sia verso di lui sia verso la piccola paziente, mentre le iniettava nel cuore il fenolo mortale con mano leggera, quasi carezzevole, per renderle più dolce l'imminente viaggio.
Il coma sopraggiunse ben presto.
L'operatore sanitario tirò un sospiro di sollievo – per se stesso suppongo – che mutò subito dopo in un'espressione di acuta preoccupazione quando si avvide di un particolare che a me era sfuggito in un primo momento.
Mengele gli ordinò qualcosa in tedesco e l'altro gli passò il bisturi, col quale non esitò a cavare, in un lago di sangue raccolto in un contenitore, gli occhi eterocromi alla ragazzina ormai assopita per sempre.
Io chiusi i miei, ma troppo tardi per eludere la disturbante scena in corso.
Li riaprii quando il medico in persona prese con delicatezza per mano anche me, per lasciarmi accomodare su di un secondo lettino allo scopo di visitarmi.
Mentre lo faceva, mi raccomandò, nel suo italiano stentato, di smetterla di ansimare e restare tranquillo.
Cercai di distrarmi e osservai con curiosità le parallele attività dell'infermiere.
Sembrava più nervoso di me, la qual cosa mi provocò, al contrario, ulteriore inquietudine.
«Basta tvemave!» mi inveì contro il dottore, assumendo di nuovo un bieco atteggiamento.
Solo allora capii il motivo di tanta tensione.
Quando Mengele fece cenno all'assistente di passargli una siringa con la dose di fenolo, questi esitò.
Il medico rivolse uno sguardo tagliente su di lui, nel momento in cui non si vide arrivare fra le mani quanto richiesto.
E intese, come avevo fatto io poco prima.
Le siringhe dovevano essere terminate e non ve ne sarebbero state altre disponibili nell'immediato.
Tirò un respiro profondo, come una molla in fase di carica, per poi riversare tutto la propria foga sul malcapitato infermiere che venne gonfiato di botte.
Un potente calcio nel culo lo sbatté fuori dalla porta della sala operatoria.
Il tizio venne aiutato dai due colleghi all'esterno, uno dei quali, su ordine del medico, mi invitò a scendere dal lettino a gesti – non doveva conoscere una sola parola di italiano.
«Ripvendevemo poi» mi si rivolse Mengele, quasi fossi un paziente rimasto deluso dal trattamento. Poi entrò in un bagnetto per lavarsi le mani.
L'uomo mi spinse fuori dalla camera infernale, quasi a indirizzarmi, in qualche modo, a dileguarmi.
Non fui condotto alla baracca dove ero stato fino a quella mattina.
Avevo, in effetti, sentito dell'arrivo imminente di un nuovo carico di deportati e molto probabilmente il numero di bambini nei block era in esubero.
Fui fatto entrare in un altro capanno, che doveva essere riservato agli adulti e a qualche ragazzino un po' più spilungone come me.
Le lacrime incominciarono a sgorgarmi a fiumi dagli occhi, come una specie di riflesso incondizionato. E avevo il cuore a tamburo.
In un primissimo istante restammo attoniti, nella reciproca convinzione l'uno della morte dell'altro; poi realizzai che un bel sogno era mutato in gioiosa realtà, così corsi a riabbracciare mio padre, commosso anche lui nel ritrovarci.
Restammo stretti l'uno all'altro per dieci minuti od oltre. Quasi temendo che, se uno dei due avesse mollato la presa, l'incanto sarebbe svanito nel nulla.
Il prosieguo lo conoscete.”
|
|
|
Antonio Esposito & Raffaele Formisano
|
|
Votazione per
|
|
WriterGoldOfficina
|
|
Biblioteca
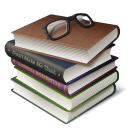
|
Acquista

|
Preferenze

|
Recensione
|
Contatto

|
|
|
|
|
|
|
|
Conc. Letterario
|
|
|
|
Magazine
|
|
|
|
Blog Autori
|
|
|
|
Biblioteca New
|
|
|
|
Biblioteca Gen.
|
|
|
|
Biblioteca Top
|
|
|
|
Autori
|
|
|
|
Recensioni
|
|
|
|
Inser. Estratti
|
|
|
|
@ contatti
|
|
|
Policy Privacy
|
|
 Autori di Writer Officina
Autori di Writer Officina 
|
|
Antonio Esposito & Raffaele Formisano
|
|
|
|
 Mi chiamo Raffaele Formisano, sono un Ingegnere Gestionale impiegato tecnico presso un'azienda ad Atripalda (AV) in cui ci si occupa di recupero di rifiuti e rottami metallici e non. Anche in campo tecnico, il mio è un ruolo creativo di gestione progettazioni di impianti per il trattamento meccanico dei rifiuti ed impianti accessori. Sono sposato con Nunzia, che è un insegnante di sostegno alla primaria, e abbiamo due bellissimi bimbi gemellini di tre anni che si chiamano Angelo Raffaele e Ciro Lorenzo. Oltre alla scrittura, sono appassionato di lettura, di cinema e di videogiochi. Ho praticato nuoto molto tempo fa. Mi chiamo Raffaele Formisano, sono un Ingegnere Gestionale impiegato tecnico presso un'azienda ad Atripalda (AV) in cui ci si occupa di recupero di rifiuti e rottami metallici e non. Anche in campo tecnico, il mio è un ruolo creativo di gestione progettazioni di impianti per il trattamento meccanico dei rifiuti ed impianti accessori. Sono sposato con Nunzia, che è un insegnante di sostegno alla primaria, e abbiamo due bellissimi bimbi gemellini di tre anni che si chiamano Angelo Raffaele e Ciro Lorenzo. Oltre alla scrittura, sono appassionato di lettura, di cinema e di videogiochi. Ho praticato nuoto molto tempo fa.
Writer Officina: Qual è stato il momento in cui ti sei accorto di aver sviluppato la passione per la letteratura?
Raffaele Formisano: Alle scuole medie, quando, in occasione di un tema di italiano avente per oggetto la descrizione di una favola, consumai ben tre quadernoni per riportare, per filo e per segno, tutto il film di Biancaneve e i Sette Nani della Disney.
Writer Officina C'è un libro che, dopo averlo letto, ti ha lasciato addosso la voglia di seguire questa strada?
Raffaele Formisano: Sicuramente il mitico CONTACT dell'immenso Carl Sagan.
Writer Officina: Dopo aver scritto il tuo primo libro, lo hai proposto a un Editore? E con quali risultati?
Raffaele Formisano: Si, certo, varie volte, e con netti rifiuti, fenomeno non infrequente per un nome del tutto sconosciuto. Ironia della sorte, conclusi il mio primo romanzo, di genere fantascienza, circa vent'anni fa e lo stesso, rimodernato, aggiornato e rivalutato nel tempo, uscirà a brevissimo con MEA EDIZIONI di Napoli. Nel mentre scrissi altri due romanzi, sempre dello stesso genere, uno nel 2009, col titolo di PROGRESSO, pubblicato da Homo Scrivens nel 2018, l'altro col titolo di IL PARADOSSO DI SCHRODINGER nel 2011 e pubblicato, sempre da Homo Scrivens, nel 2016.
Writer Officina: Ritieni che pubblicare su Amazon KDP possa essere una buona opportunità per uno scrittore emergente?
Raffaele Formisano: Non saprei. Alcuni autori, con cui ho fatto amicizia attraverso gruppi di letteratura su FB, hanno pubblicato in questa maniera e a qualcuno è andata in maniera splendida sia da un punto di vista di gradimento dell'opera che in termini economici. Vi è, tuttavia, e parlo in particolar modo persone più addentrate nel settore letterario, qualcuno che sostiene che il supporto di una casa editrice dia maggiore credibilità, spessore, prestigio e slancio all'autore. Io ho, sinora, sempre optato per questa seconda strada, sebbene, a dispetto di tanti riconoscimenti ricevuti, non sia ancora annoverato fra autori di gran fama.
Writer Officina: A quale dei tuoi libri sei più affezionato? Puoi raccontarci di cosa tratta?
Raffaele Formisano: Di sicuro IL PARADOSSO DI SCHRODINGER.
Si pensi, tanto per cominciare che il romanzo uscì due giorni dopo (il 25 ottobre 2016), il mio matrimonio e che io e mia moglie ne regalammo, in anteprima e come bomboniera di nozze, una versione a tema grafico sposalizio (copertina bianca con accorgimenti attinenti le nozze) agli invitati. In occasione del nostro viaggio di nozze, poi, in visita alla città di Vienna, ne donammo una copia alla Biblioteca della prestigiosa università viennese, dove insegno il fisico premio nobel Erwin Schrodinger. Questo è il link con la sezione italiana, con la catalogazione dell'opera http://ubdata.univie.ac.at/AC13383280. Il romanzo ha ricevuto, inoltre, diversi riconoscimenti a diversi premi letterari (Michelangelo Buonarroti 2016, Golden Books 2017, Città di Grottammare 2017, Premio Zeno 2018), fra cui miglior soggetto al festival UN LIBRO PER IL CINEMA 2019 e terzo classificato al premio LA PENNA PERFETTA 2020.
Writer Officina: Quale tecnica usi per scrivere? Prepari uno schema iniziale, prendi appunti, oppure scrivi d'istinto?
Raffaele Formisano: Essendo un ingegnere progettista, per deformazione professionale schematizzo tutto ciò che faccio, scrittura inclusa, ma solo come promemoria per stabilire ordini cronologici, richiami, intrecci e connessioni fra personaggi e situazioni. Poi, mentre scrivo, vi è spesso una deviazione e un rinnovo di idee che può nascere al momento e mi porta a revisionare in parte o completamente la scaletta.
Talvolta i miei romanzi e i miei racconti su basano su vere teorie scientifiche, ragion per cui è impensabile un mancato studio preliminare o una schematizzazione dei concetti da inserire nel testo a mezzo appunti iniziali. Scrivere di istinto, poi, definisce i caratteri dei personaggi, soprattutto se stanno ben riuscendo. Capita che essi prendano vita così bene che sono loro stessi, poi, a trascinare l'autore.
Writer Officina: In questo periodo stai scrivendo un nuovo libro? È dello stesso genere di quello che hai già pubblicato, oppure un'idea completamente diversa?
Raffaele Formisano: Come dicevo più sopra, a breve uscirà il mio terzo romanzo, sempre di genere fantascienza, ma che in realtà è il primo che ho scritto circa vent'anni fa. Sono, poi, impegnato, nella revisione di un horror assieme a un gruppo di amici scrittori con i quali abbiamo creato un cosiddetto autore collettivo dedito al genere. Lo proporremmo a breve a un editore.
Writer Officina: Perché hai scelto la fantascienza come genere primario (piuttosto che un altro genere)?
Raffaele Formisano: Sono da sempre affascinato dalla storia dell'uomo, la quale, in ogni epoca, è costantemente accompagnata dalla tecnologia del momento che ne condiziona il modus vivendi. Oggi più che mai le nostre vite sono talmente dipendenti dalla tecnologia che non riusciremmo più a farne a meno.
Basti pensare che se mi si guasta il pc in ufficio il mio lavoro si ferma. Basti pensare che se mi va in tilt lo smartphone, oggi come oggi, sono tagliato fuori dal mondo, anche in mezzo a miriadi di persone. Ciò deve far riflettere. Ciò ispira la mia domanda su quanto la tecnologia derivi dall'uomo e quanto l'uomo, a mano a mano che progredisce, dipenda da essa. Arriveremo, un giorno, ad una situazione alla Matrix?
Writer Officina: Hai fatto dei corsi?
Raffaele Formisano: Ho frequentato, per tre anni, del laboratorio di scrittura HOMO SCRIVENS presso la libreria Mondadori di Pompei (diretto dal maestro Gianluca Calvino), tra il 2015 e il 2017, entrando a far parte del collettivo di scrittura GRUPPO 9, con cui ho pubblicato i tre romanzi (editi ovviamente da Homo Scrivens) Hyde School (2015), Gli affamati (2017), Scacco al Re (2018).
Writer Officina: La scrittura ha una forte valenza terapeutica. Confermi?
Raffaele Formisano: Al mille per mille. Per me ha sempre avuto valore catartico, liberatorio e rafforzativo. La scrittura mi ha aiutato e mia aiuta a indossare le piume della Fenice, che, anche dopo essere stata bruciata, rinasce, forse più fortificata di prima. La scrittura è un pezzo di me, come un braccio o una gamba. Vive con me, morirà con me. Imprescindibilmente.
|
|
Tutti i miei Libri
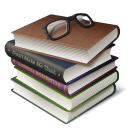
|
Profilo Facebook

|
Contatto

|
|
|
|