|
|
 Volevo vedere l'Africa
Volevo vedere l'Africa 
|
  L'orologio al polso di un compagno seduto accanto sul cassone del camion segnava dodici alle otto. L'automezzo si fermò. Con esso si arrestarono i frammenti di ricordo che fino a quel momento avevano continuato a rimbombarmi dentro. Definitivamente sveglio, tesi la mano a visiera sulla fronte per ripararmi dal sole basso della mattina che mi stilettava gli occhi.
L'orologio al polso di un compagno seduto accanto sul cassone del camion segnava dodici alle otto. L'automezzo si fermò. Con esso si arrestarono i frammenti di ricordo che fino a quel momento avevano continuato a rimbombarmi dentro. Definitivamente sveglio, tesi la mano a visiera sulla fronte per ripararmi dal sole basso della mattina che mi stilettava gli occhi.
Quando il camion arrivò all'aeroporto militare di Galatina, considerai che di lì a un pugno d'ore sarei atterrato in Libia. Mentre il camion entrava nella base militare, il sergente ci indicò il Savoia Marchetti SIAI SM82: un trimotore, in attesa sulla pista, affiancato ad altri due aerei esattamente identici fra loro. - C'imbarchiamo tra poco - disse il sergente. E tacque. Nessuno sentiva il bisogno di dire o ascoltare molte parole.
Guardai il mio aeroplano con un groppo in gola, le mani fredde: lo vidi come un pezzo di Libia, come fossi già arrivato. Accanto al trimotore attendeva sull'erba gialla anche il nostro cannone anticarro da smontare pezzo a pezzo per poterlo imbarcare assieme a noi. Per la prima volta mi parve plausibile che le nostre scarpe avrebbero marciato sulla polvere africana. La Libia mi aspettava lì, con le sue tre eliche pronte a vorticare sulla pista di decollo e il cannone, in posizione di fuoco, da smontare e caricare sull'SM82.
Noi ragazzi, con la sahariana indosso, fez nero in testa col fiocco svolazzante, zaino in spalla e fucile M38 a tracolla, scendemmo dal cassone del camion, prendemmo gli attrezzi da lavoro e ci mettemmo a scomporre il cannone per affidarne le parti agli avieri che dovevano sistemarle a bordo. Analoga cosa fecero altre due squadre anticarro come la nostra – sopraggiunte contemporaneamente a noi su altrettanti camion –, anche loro pronti a viaggiare su altri due aeroplani verso la nostra stessa destinazione.
Smontati i tre cannoni e affidati i pezzi agli avieri della base, i componenti le tre squadre si disposero ad aspettare sull'erba dell'aeroporto militare. Molti si sedettero sul prato, a pochi metri dai rispettivi velivoli che già ruggivano col motore al minimo. Pochi si mescolavano agli altri gruppi. Per ingannare l'attesa e diluire i pensieri, quasi tutti fumavano. Molti parlavano, qualcuno scherzava. Quasi nessuno rideva. Io tacevo e mi guardavo intorno. Ma non ce la facevo più ad aspettare, l'attesa mi snervava. Taciturno, camminai un poco sull'erba secca dell'aeroporto. Lasciai correre lo sguardo curioso su ogni angolo di quella base aerea, poi sul cielo azzurro sporcato soltanto da un grande bioccolo bianco. Nella nuvola lessi, come da bambino steso sui ciottoli in riva al Tinella, il contorno di un gatto che nel vento si disfaceva in un gomitolo informe. Infine, decisi di lasciare i compagni e le loro chiacchiere di donne, calcio e niente. Lesto mi avviai da solo, affardellato e col fucile in spalla, verso l'aeroplano. Un motorista e uno dei due piloti camminavano attorno al velivolo soffermandosi su alcuni particolari, controllavano, indicavano all'altro, di tanto in tanto davano una regolata a una valvola e spuntavano da un elenco su un foglio.
Mi fermai di fronte all'aereo, a quattro passi dalla carlinga. Aspirai l'ultima boccata di fumo dalla micidiale Milit pendula fra le labbra, ne gettai il mozzicone nell'erba secca della pista, lo pestai premendovi il piede girando più volte con forza. M'incamminai di nuovo e percorsi il breve tratto sull'erba giallastra verso la bestia ruggente. Quindi, salii per primo sull'SM-82 riparandomi gli occhi dalla polvere sollevata copiosa dallo scompigliante vortice delle eliche spinte dai motori che ringhiavano prepotenti come un molosso rabido e schiumante visto trattenuto al guinzaglio da un gerarca quand'ero a Roma, e ruggivano come i leoni che da bambino vedevo sui libri e sui giornalini fra una striscia del signor Bonaventura e un'altra di Bibì e Bibò. Poi, pensai che in Libia di leoni non ce ne dovevano essere, anzi certamente non ce n'erano, e andai oltre col passo e col pensiero. Il fiocco del mio fez, mosso dal turbine, sbatacchiava a destra e a sinistra come un metronomo ad accompagnare i miei lunghi passi.
Entrato nell'aeroplano, mi soffermai a guardare lo spazio semivuoto della fusoliera. Notai, stupito, che il ventre del velivolo era capiente. Una paratia orizzontale creava due piani distinti. In coda si trovavano, legati al pavimento dagli avieri, il cannone che io stesso avevo contribuito a smontare, parecchie casse di munizioni e viveri, bidoni di carburante avio e taniche di nafta.
A bordo l'armiere si stava dirigendo alla mitragliatrice, sua postazione; egli, notato il mio sguardo curioso, come per rispondere a una domanda non posta mi spiegò che l'aeroplano poteva ospitare fino a quaranta paracadutisti completamente equipaggiati, oppure notevoli quantitativi di materiale bellico o rifornimenti. Quindi continuò e ammiccando disse nella sua bella cadenza toscana, l'indice puntato sul mio fez:
- Ma te tu sai, caro bel fantaccino col fiocchetto...? -
Tacque un istante. Mi domandai che cosa mai dovessi sapere. Intanto guardavo il suo dito indice salire e scendere in tono di paternale come ai tempi della scuola quando ne combinavo qualcuna, mentre lui rifletteva sgranando gli occhi; non ebbi tempo di costruirmi una risposta e lui riprese, continuando col dito:
- Te tu sai, o bel fante infiocchettato, che questo apparecchio si chiama “marsupiale” o “canguro”? No, vero? -
Non risposi. L'armiere rise, scosse il capo e proseguì, serio:
- Questo l'è un trimotore da trasporto bello grande, che sarà pure un po' tozzo e lento, ma ha trasportato in Africa anche i nostri caccia, i biplani CR-42. -
L'armiere rimase immobile di fronte a me, le mani protese ad abbracciare idealmente con orgoglio il suo velivolo, lo sguardo ieraticamente alto. Proprio come Don Tarditi quando sollevava l'ostia consacrata; sorrisi, al pensiero del vecchio prevosto, perché quando servivo messa notavo che il discendere delle maniche della veste quando Don Tarditi elevava l'ostia alla preghiera eucaristica, rivelava l'assenza di una camicia oltre i polsini bianchi consunti: soltanto maniche rattoppate di una maglia di lana bianca, fra i polsini bianchi e la veste. E poi, mi era tornata in mente la curiosità mia e di Cornelio di capire cosa ci fosse sotto la lunga veste. Una volta, io e lui l'avevamo persino sollevata un poco da sotto, scoprendo le caviglie coperte dai mutandoni in lana, rammendati in tutta la lunghezza.
Mi scappò da ridere, anche, perché sentendo l'armiere parlare con accento toscano mi era venuta in mente una storiella raccontata da un compagno di caserma, piemontese come me, che sedutosi a tavola con tre amici in una trattoria toscana e ordinata della pasta, si era visto servire dal cameriere con un colorito - L'è questo il tavolo dei quattro pici? - . Irresistitibile, per un piemontese.
- O che tu hai da ridere, fiocchettino biondo? - mi domandò l'armiere – nel frattempo raggiunta la sua postazione –, vedendo la mia espressione divertita e lo sghignazzo.
- Niente, è che non sapevo tutte queste cose. Quesrto è il primo aereo su cui metto piede, son contento, grazie - risposi essenziale, piantato a metà della fusoliera, un residuo di sorriso sulle labbra per i quattro pici a tavola e per il vecchio prete di Neive evocatomi dalle mani protese dell'armiere.
Egli prese posto su un'alta predella che costituiva la base di una specie di garitta, la cui estremità superiore, una cupolina di vetro, fuoriusciva di un niente dalla linea della fusoliera, giusto per la testa, a formare una gobbetta all'esterno:
- Io ho fatto l'armiere su un apparecchio più piccolo e leggero di questo ma di sagoma analoga, l'era un SM-79, un bombardiere. L'era un SIAI Marchetti come questo e come l'aeroplano che a luglio si è fatto Roma-Tokyo-Roma in quattro giorni. -
Pensai che dal vetro di quella – chiamiamola – garitta opposta al senso di volo, egli poteva ben coprire tutto il campo visivo retrostante. Sistematosi in quella postazione, guardando la mitragliatrice da 12,7 e ispezionandone ogni dettaglio, l'armiere continuò, miracolosamente senza più accento per darsi un tono:
- I piloti della RAF sono strastufi di attaccare di coda i nostri SM-79 che sempre se la cavano grazie alla mitragliatrice montata sulla gobba dorsale e rivolta all'indietro, proprio come questa. -
Diede un buffetto all'arma, la brandeggiò a destra e a sinistra, poi si volse in basso verso di me per terminare la spiegazione, indicando l'insieme del velivolo:
- Gli hanno affibbiato il nomignolo di “Damned Hunchback”. -
- Che cosa? Come? - domandai io, che non avevo colto se non un confuso farfugliare, e proseguii, per dimostrare di aver seguito il filo del discorso:
- Che nome hai detto che hanno dato, in RAF, all'aereo? - .
- Damned Hunchback, non conosco la pronuncia ma so il significato e come si scrive - ripete l'armiere da dentro la sua postazione armata, la mitragliatrice puntata verso la coda, l'occhio strizzato come a voler puntare e mirare. Quindi come parlando a sé stesso tradusse subito, laconico, in un soffio di voce nuovamente vernacolare, indicando la gobba:
- Gobbo maledetto, vuol dire. Il mi' apparecchio l'è una gobba volante. -
Mi guardò, prese una penna, scrisse quel nome inglese su un foglio estratto dal taschino e lo girò verso di me indicandomi il ghirigoro. Poi, senza un cenno mi ignorò. Ricontrollò bene i comandi dell'arma ed esaminò il sistema di puntamento, gli occhi strizzati a fessura per mettere a fuoco ogni millimetrico dettaglio meccanico. Finì col dare una rapida pulita alla canna che ai miei occhi parve una pacca amichevole.
Guardai prima l'armiere, poi la sua arma tenuta salda ma con presa carezzevole, quindi apprezzai senza ulteriore commento che anche quel velivolo su cui ero appena salito era dotato – come gli SM-79 inafferrabili dalla RAF – di quel lievissimo accenno di gobba dato dalla cupoletta trasparente in cui alloggiava la mitragliatrice. La cura con cui erano tenuta gobba e mitragliatrice mi fece ben sperare.
"Un altro bel gobbo maledetto" pensai, poi aggiunsi, riferendomi all'armiere: - E con quel testone lì dentro, determinato a ricacciare indietro chiunque volesse tirarci giù dal cielo nel nostro volo verso la Libia".
Rassicurato dalle spiegazioni, dalla grinta e dalla passione del mitragliere, tuttavia ero ancora nervoso. Mi riavviai al portellone, varcato poco prima. I miei compagni si attardavano sparsi sulla pista, come se il permanere fuori dall'aeroplano potesse far tardare la partenza e prolungare quell'ultimo momento in Italia. Tornai sui miei passi e ripercorsi la fusoliera in tutta la lunghezza, dal portellone alla postazione dell'armiere subito dietro il posto di pilotaggio, e riaccarezzai con lo sguardo la gobbetta trasparente da cui spuntava la mitragliatrice dorsale.
Il pilota che prima aveva compiuto il giro d'ispezione esterno, risalito a bordo aveva preso posto accanto al secondo. Oltre ai due piloti e all'armiere, anche il marconista era seduto al suo posto. Tutti controllavano comandi e studiavano carte. L'equipaggio era al completo e pronto al decollo.
Incominciai a sentire, finalmente, il tramestio degli scarponi e il vociare dei miei compagni. Tornai sui miei passi fino alla coda, dove indugiai per guardare i pezzi del cannone anticarro e la mia attrezzatura di puntamento. Infine mi fermai nei pressi di una rientranza metallica del pavimento a metà della carlinga sul lato sinistro, mi sgravai dello zaino e del fucile M91-38 in perfetta efficienza, li collocai accanto a me dopo essermi seduto alla meno peggio, e mi disposi a guardare gli altri ragazzi che entravano per disporsi, seduti, sui due lati lunghi della carlinga.
Giacomo Lenti di Reggio Emilia, studentino di Liceo Classico fresco di esame di Stato, appassionato di storia romana e geografia, alto, biondo, salì di corsa, la Milit quasi del tutto consumata fra le dita, con l'espressione da scolaro in gita in procinto di combinarne una; si sistemò accanto a me, dopo aver posato il suo fucile a terra sopra il mio e lo zaino davanti a sé. Gli ricordai di gettare la sigaretta, e gli indicai in fondo alla fusoliera, in prossimità della coda, i bidoni di carburante avio e le taniche di nafta legate al pavimento.
Giacomo ringraziò, mi fece segno con la mano di aspettare, si alzò, tornò al portellone spalancato, spense il mozzicone schiacciandolo fra pollice, indice e medio, lo sistemò sul polpastrello del pollice e gli impresse un deciso impulso con il medio, come certo faceva da bambino con le biglie di vetro. Il mozzicone, appesantito dalla saliva e spinto dal vento favorevole, volò lontano, rimbalzando sul bavero della giacca di Antonello che attraversava la pista cinque metri più in là, il passo appesantito e la figura rimpicciolita da un enorme zaino sulle spalle. Giacomo si piantò in mezzo al portellone a guardare Antonello, la bocca spalancata, indeciso se chiedere scusa o prendere in giro il compagno fatto a segno del tiro involontario.
- Ehi, ma che bel lancio, hai buona mira, cannoniere! - rise Antonello.
- Visto che bravo? Me l'hanno insegnato al corso a Civitavecchia - scherzò Giacomo.
Risero entrambi. Mi unii anch'io, godutami da seduto la scena incorniciata dal portellone aperto come un sipario spalancato. Ridemmo tutti, sfogandoci come bambini in gita catechistica al santuario. Poi Giacomo riguadagnò il suo posto vicino a me. Fu in quel momento che Antonello si fece scuro in volto. E non per la cicca con cui Giacomo l'aveva centrato.
Antonello Monti, iscritto all'Università (a quale Facoltà non si sa) e diplomato al Conservatorio, romano, piccolino, brunetto, occhi vivaci dietro gli occhialini tondi, salì a bordo pensoso, carico di domande cui non aveva trovato risposta, e di uno zaino più gonfio degli altri perché – lo sapevano solo pochi, fidati amici – conteneva un violino in una rigida custodia nera avvolta in una vecchia coperta militare. Antonello si sedette di fronte a me, lui e lo zainone.
Salì poi Teobaldo Ruotolo di Battipaglia, per noi Teo, diploma di Avviamento come me, allevatore di bufale da due generazioni. Come me, di origine contadina: Sud e Nord coincidevano, su quell'aeroplano, per collimanti cultura contadina e diploma scolastico. Ventisei anni da poco compiuti, di robusta corporatura, pelle scura bruciata dal lavoro nei campi, quel ragazzo campano era il vecchio del gruppo, fatta eccezione per il comandante Pierucci. Teo entrò, serio, sul tremante aeroplano.
Egli confessò di avere ancora negli occhi l'immagine di sua moglie che – vestito nero ravvivato da uno scialle rosso a nascondere un incipiente ventre tondo, calze nere, occhi neri, capelli neri – era venuta la sera prima dalla Campania per salutarlo. Forse Teo avrebbe preferito non vederla, vista la pena del commiato che sapeva avrebbe reso più duro il partire: negli occhi tristi gli si leggeva il paradosso dell'addio.
Anche Teo Ruotolo sistemò zaino e fucile e si accomodò presso una centina della fusoliera, di fronte a Giacomo Lenti. Teo era triste, ma contento di partire, finalmente, per porre termine all'agonia immalinconente dell'attesa, e per concentrarsi su altro che non fosse il dover lasciare la moglie e con lei il bimbo destinato a nascere in estate.
A chiudere il gruppo salì lieve e misurato il comandante di pezzo, il sergente, intento a controllare che tutto a bordo fosse a posto, presente e ben sistemato: si chiamava Sergio Pierucci, toscano di Pienza, ventott'anni ma all'apparenza coetaneo di Teo, professore di storia e filosofia, appassionato di civiltà remote per tempi o per luogo, e di nuove culture. Prima di partire per l'Africa, il comandante Sergio si era studiato quell'angolo del mondo nei risvolti che più l'interessavano culturalmente, come se si apprestasse a compiervi un viaggio di piacere o una missione di studio. Pierucci passò in rassegna le casse di munizioni, con la mano saggiò le corde che assicuravano al pavimento le parti del cannone, e infine squadrò noi quattro, seduti in silenzio.
Infine prese posto un tenente, accanto al sergente. Il più vecchio di tutti. Sui trentacinque anni, il tenente era di quelli che non danno confidenza. Accennò un saluto, depose lo zaino e estrasse un libretto. Non disse una parola e si mise a scrivere su un foglio, tenendo saldo un libretto.
Si poteva partire. Insieme con me, seduti allineati sui due lati della carlinga, i tre miei compagni del pezzo anticarro, il sergente capopezzo, e l'ufficiale che scriveva e leggeva; in più, oltre ai due piloti e al marconista, il mitragliere dell'Aeronautica in piedi su quella sorta di cassone immediatamente dietro la cabina di pilotaggio, la testa nel piccolo alloggiamento trasparente appena fuori dalla linea della fusoliera, destinato a scrutare l'orizzonte italiano che di lì a poco si sarebbe allontanato, pronto a sparare. Guardai ancora una volta, verso la coda, il cannone anticarro smontato, le relative munizioni, gli attrezzi di puntamento e i barili di carburante avio per permettere al medesimo aereo il ritorno in Italia. Ma quella era un'altra storia, che non mi riguardava.
Il trimotore si mise a rollare sulla pista sconnessa, primo della formazione di tre velivoli che, uno in coda all'altro, ruggivano come tigri alla catena, a mano a mano che i nove motori andavano su di giri. Mollati i freni, alle nove il mio aereo balzò avanti felino.
Dopo una lunga rincorsa, i motori Alfa Romeo al massimo, l'aereo lasciò il suolo italiano riempiendo la carlinga di un urlo barbaro, guerriero, ventoso e assordante, e di una nuvola di polvere e sabbia che si mise a volare nell'aereo penetrando in ogni dove. D'istinto mi riparai il viso con la mano. Quasi tutti tossirono, alcuni si scrollarono di dosso un po' di sabbia, tutti come me portarono le mani al volto per proteggere occhi e naso. Non ebbi tempo per pensieri malinconici, perché mi dovevo tenere aggrappato con la mano sinistra a un longherone d'acciaio, mentre tentavo di controbilanciare l'accelerazione che mi spingeva a destra, con una torsione del busto ed analogo movimento del capo verso sinistra. Due fucili caddero a terra e scivolarono in coda. Sergio li abbrancò.
Presa quota, si dileguò la nuvola di sabbia e rimasero il ringhio dei pistoni, le raffiche di vento, l'ululare di una corda tesa sulle nostre teste e lo svolazzo flap flap dei baveri di sahariana sulle clavicole e dei teli di copertura dei pezzi di cannone. Un rumore ritmato, flap flap tic tac toc, simile a quello che facevo da bambino scapicollandomi in bici con una figurina Buitoni pinzata alla ruota. In più, il libretto e il foglio del tenente presero a sventolare fra le dita.
L'armiere, in piedi nella sua garitta rivolta al piano di coda dell'aereo, aveva le mani sulla mitragliatrice, gli occhi su orizzonte e nuvole a cercare caccia nemici con cui fare tiro a segno; guardava l'Italia che si allontanava in basso davanti a lui mentre l'aereo completava la cabrata per portarsi in quota. Chinatosi per raccogliere un collimatore cadutogli e rotolato in carlinga, e notato che guardavo preoccupato le due voragini sul vuoto dalle quali prima s'insinuavano nuvole di sabbia e ora entravano vento, rumore, squarci di cielo e mare e odori di carburante e olio bruciato, urlò rivolto a me:
- Mica li abbiamo dimenticati! -
- Come? - domandai, le fauci asciugate dalla tensione e dal prolungato mutismo, le orecchie assordate dal frastuono e sferzate dal bavero. Non mi aspettavo parola da nessuno, meno che meno da chi doveva sorvegliare il cielo e non la carlinga. Non ero preparato, e poi il vento si è portato via metà parole dell'armiere.
- Non li abbiamo dimenticati aperti! - strillò più forte, lento, scandendo le sillabe, guardandomi bene e indicando le due aperture. Volsi lo sguardo dove egli additava, capii che alludeva ai portelloni e a un'altra mitragliatrice in coda, ma non riuscii ad afferrare che cosa avesse strillato. L'ultima parola si perse nel vento. Sorrisi per cortesia; l'armiere, rassicurato dalla mia espressione che interpretò come assenso e intesa sulla frase detta, proseguì urlando:
- Facciamo sempre così perché ‘un se po' sapere! - e per buon peso, rimessosi in postazione e riafferrata l'arma, mimò l'atto di una raffica indicando le aperture, a intendere che dai portelloni aperti era più agevole mitragliare il nemico in caso di attacco. Aggiunse ancora, non convinto di essere stato capito:
- Quegli esosi degli inglesi t'arrivano addosso che manco te n'avvedi, quelle curregge vestite. -
Lo ringraziai con la mano, annuendo con il capo. Gli elargii un sorriso e una sigaretta; egli uscì dal suo posto, fece un passo, allungò la mano, prese la sigaretta, sollevò il pollice della mano destra, mi restituì un sorriso d'intesa e tornò in postazione. In effetti non pensavo che i due portelloni fossero stati dimenticati in quella posizione; ero però contento di scoprire che erano stati lasciati aperti per permettere una più rapida difesa in un'eventuale battaglia grazie all'uso della seconda mitragliatrice già pronta accanto a una delle due aperture.
L'aereo continuava a salire rombando barcollante tra le raffiche di vento invernale verso una guerra senza speranza in cui ancora credevo, quasi quanto volessi vedere l'Africa. Domandai l'ora. - Le nove e un quarto - disse il sergente. Le nove e un quarto del mattino di una fredda giornata di fine novembre. Sembravano trascorse quattro ore dall'arrivo quel mattino alla base aerea, non un'ora e mezza scarsa. Rimuginavo, mentre mi tenevo al longherone d'acciaio, che questo era il mio primo volo; un volo verso la mia guerra, su un'aereo gibboso come un dromedario, verso un continente mai visto. Alla trepidazione per la guerra e per l'Africa, si era aggiunta l'emozione di volare. Rotta su Arco dei Fileni in Libia, fra Tripolitania e Cirenaica, cinque ore di volo.
Nessuno parlava: proprio come il tenente sconosciuto, che sin dall'arrivo si era chiuso in un mutismo insondabile, alle prese col libretto dalle pagine scompigliate dal turbine e col foglio sbandierante su cui scriveva. Il volto inespressivo, imperturbabile, come se non gli importasse ciò che gli capitava intorno, e fuori dall'aereo. Noi quattro ragazzi e il sergente avremmo sì voluto dirci qualcosa, ma ce ne rimanemmo in silenzio, anche perché il pandemonio dei motori, assordante, onnipervasivo, invadente, non filtrato dai portelloni lasciati aperti, unito al sibilante urlo del vento e al clangore degli oggetti da esso sbatacchiati e flagellati, copriva ogni altra sonorità. Le parole avremmo dovuto scambiarcele gridando e con poche speranze di essere raccolte. L'urlio del motore scacciava e annullava i sentimenti; col suo fremere obnubilava il ragionamento, come una droga svigoriva i sensi, col vantaggio però di azzerare e ricacciare le malinconie. La furia del cuore non si allentò, per brevi tratti solo smorzata dall'incoscienza giovanile: sincrono col vento padrone della carlinga, esso palpitava a mille.
Dai due portelloni spalancati entrò un vento gelido che neanche al bricco dei Tre Cunei nelle peggiori giornate della merla. Poi il trimotore si abbassò, il freddo si fece sopportabile e il volo tranquillo, a bassa quota sul mare. Di tanto in tanto lanciavo un'occhiata alla seconda mitragliatrice, non presidiata ma pronta all'uso.
Le cose cambiarono in un istante, passate due ore dal decollo. Un grido dalla postazione dell'armiere, un celere parlottare in cabina di pilotaggio. Il motore urlò più disperato, ci sentimmo risospinti indietro, arrancanti come un ciclista della domenica dietro a Bartali su per il Col du Galibier. L'emozione diventò terrore. Raggelante. Ottundente. Accortosi di essere stato avvistato dalla ricognizione nemica, il nostro pilota aveva tirato a sé la cloche, facendo cabrare il velivolo quasi fino allo stallo. Il pilota diede manetta e portò l'allegra compagnia a volare ancora nel gelo delle nuvole, in alto, veloci, a una quota di sicurezza. Tre dei fucili collocati sul pavimento accanto agli zaini scivolarono per tutta la fusoliera e impattarono violenti contro una ruota del cannone, giù in coda. Dai portelloni di carico aperti si insinuò un vortice ghiacciato che artigliò in una morsa polare i nostri corpi avvolti nei vestiti leggeri, secondo il regime buoni per ogni fronte. Prendemmo ognuno una coperta e ce la gettammo stretta addosso, rabbrividendo e battendo i denti. I lembi delle coperte liberi al vento battevano un ritmo indiavolato. Tutti ci calcammo bene il fez in testa. "Già non abbiamo il casco noi ggff, che almeno questo fez nero serva a riparare un po' dal freddo" pensai tremante sotto la coperta, abbracciandomi stretto il torace. Mi spuntarono due lacrime e poi altre ancora, inarrestabili, come quando andavo in bici nella frescura del mattino. Mi affrettai ad alzare una mano a schermo e ad asciugarmi ciò che il vento ancora non aveva seccato, perché le lacrime non venissero male interpretate. Sorrisi, anche, guardandomi attorno.
Presa quota, per consolarci il sergente ci passò un barattolo di ciliegie sotto spirito ricevuto da casa; lo facemmo passare di mano in mano e mangiammo tremando in silenzio.
Per un po' si volò ad alta quota nel freddo, ma ancora tranquilli e in assetto orizzontale. Finché il silenzio di parole – nel battere del vento e nel frastuono dei motori – fu spezzato dalla concitazione di un nuovo scambio di battute fra il pilota e il mitragliere, rapide come in un duello fra pistoleri: il toscano dietro l'arma si era accorto di due caccia inglesi che incalzavano nel grigio denso delle nubi. La breve sparatoria verbale fu chiusa dalla voce del pilota, che rapida come la seicolpi di John Wesley Hardin ordinò al mitragliere:
- Fai, fuoco, spara! E non sprecare munizioni! -
Noi, già per nulla ciarlieri in quel freddo non solo fisico, tacemmo del tutto, sentito l'ordine rivolto all'armiere. Dalla mitragliatrice Breda che spuntava dal dorso del trimotore partirono quattro lunghe sventagliate di mitraglia in rapida successione. Seguite da altre due, poco dopo. Il pilota picchiò improvviso, fulmineo come prima a cabrare, causando la ridiscesa dei tre fucili lungo la carlinga che, scivolati in coda nella lunga salita precedente, stazionavano nei pressi del cannone. I loro proprietari li afferrarono al volo mentre scivolavano verso la cabina di pilotaggio, davanti.
Volavamo ora bassi, quasi rasenti il mare. Il mitragliere fece partire un'ultima raffica verso l'alto dove, sempre più lontani, volavano i due caccia inglesi. Infine tacque anche il mitragliare dell'arma. Emerse solo la voce del pilota che, rotta dal vento e dai motori, espresse contentezza per aver seminato i caccia senza bisogno di azionare anche le due mitragliatrici alari, o quella che minacciosa sporgeva da uno dei portelloni da cui entrava un sentore salmastro misto ai fumi grevi dei motori.
Si sentiva solo il rugghiare dei tre motori spinti al massimo, il fischio del vento nel ventre del velivolo, e il cozzare, ritmato, degli oggetti spinti dall'aria. L'armiere, poi, si volse verso di noi per urlare che si intravedevano le coste della Libia. Attraverso i portelloni non si scorgeva nulla se non le onde del mare.
Erano le 14,30 di quella domenica di fine novembre, quando atterrammo in Libia. Avevamo trascorso più di cinque ore in cielo, nel gelo, dopo la partenza da Galatina. L'aeroporto di Arco dei Fileni era affogato in un mare di luce, nonostante l'approssimarsi dell'inverno.
Afferrati zaino e fucile, mi alzai. Ero indolenzito dal prolungato immobilismo e dal freddo accumulato, le gambe molli per le vibrazioni e il freddo. Tutti tremavamo, senza sapere se per i fremiti dei motori, il vento gelato o chissà cosa. Con le braccia conserte ci comprimevamo il torace a darci calore.
Scendemmo dal portellone sulla sabbia della pista ai margini del deserto. Le eliche in movimento quasi ci scompigliarono i capelli a spazzola. Fatti pochi passi passi sulla pista e usciti dal vortice delle tre eliche, il caldo ci piombò addosso come un caftano di lana, benvenuto come un temporale d'estate. Ognuno depositò armi e zaini facendone mucchio ordinato sulla sabbia. Qualcuno indugiò a cogliere una visione d'insieme del luogo e per godere della carezza del vento caldo sulle guance e fra i capelli. Un caldo che in quei primi momenti risultò gradevole, benefico. Un caldo altrimenti opprimente a quell'ora, anche in quella stagione, alle porte dell'inverno nel mese natalizio.
Intanto, il secondo velivolo dei tre partiti da Galatina stava toccando terra. Lottando contro il riverbero lattiginoso, lo guardammo atterrare elegante sulla pista in una nube di polvere e fermarsi dopo un breve rullaggio. Ci avvicinammo e notammo un foro sul timone verticale. Dunque, non eravamo stati i soli bersagli dei caccia inglesi.
Poi, mentre anche il terzo aereo decollato da Galatina prendeva terra urlando e mulinando sabbia, tutti noi risalimmo a bordo del nostro trimotore per liberare i pezzi del cannone e le casse di munizioni, aiutati da alcuni avieri della base aerea. Scaricammo le parti del cannone sulla sabbia e, a pochi passi dall'aereo, ci mettemmo a riassemblarle. Constatammo che, poco più in là, nei pressi dell'hangar, anche i ragazzi del secondo aereo avevano finito di scaricare e si apprestavano a fare altrettanto col loro cannone, mentre quelli del terzo aereo incominciavano a scendere dal loro velivolo, le braccia conserte a non disperdere il calore corporeo, come già noi.
Quell'agitarsi delle due squadre attorno alle parti smontate della rispettiva artiglieria sulla sabbia della base aerea mi riportò a quando, bambino, con i miei amici mi attardavo a giocare sulle spiagge umide e melmose del Tinella o del Tanaro, con un po' di ramaglia e qualche ciottolo arrotondato: scene già vissute, dunque, non fosse per la differente situazione, la diversa età dei giocatori e l'arena tutt'altro che uguale.
Con i ragazzi del secondo aereo improvvisammo una sfida non dichiarata, ad assemblare meglio e più rapidi il proprio cannone. La prima battaglia in terra di Libia la consumammo così, fra noi, col nostro gioco da bambini. Terminato il lavoro, contemplammo un attimo, sudati e contenti, il nostro anticarro 47/32, detto - elefantino - . Più che una controcarro era un'antiblindo, a dire il vero; qualcuno mormorò che solo se il colpo da 47 mm arrivava sul treno di rotolamento dei cingoli, si poteva sperare di arrecare qualche danno; ma al corso non ci avevano messi in guardia su ciò: ci avevano solo insegnato che l'arma era una calibro 47, pesava 280 chili, sparava 20 colpi al minuto, con una gittata di 2.000 metri. E che era il meglio degli anticarri.
Anche i ragazzi del terzo aereo si misero d'affanno a montare il proprio cannone, fuori gara per aver incominciato dopo. Infine, quando anche loro ebbero finito, confrontammo il nostro cannone con quello delle due squadre atterrate dopo. Valutammo grossomodo i tempi. Decidemmo che non c'era vincitore. Il lavoro era servito a tutti per reimmagazzinare calore nelle membra intorpidite e per sciogliere nel lavoro le tensioni di una notte insonne e del viaggio in cielo. Il calore della fatica si sommò a quello del sole che arroventava il cielo sgombro di nuvole e l'aeroporto spoglio di alberi e ripari, sciogliendo l'inquietudine accumulata a bordo del trimotore in balia dei caccia e del vento.
Dal mucchio sulla sabbia riprendemmo zaini e fucili dove li avevamo lasciati. Assicurammo il cannone al traino di una camionetta; su un autocarro che ronfava nei pressi caricammo le cassette di munizioni, i viveri e le taniche di nafta per i mezzi. Così fecero su altri due camion gli uomini sbarcati dagli altri due trimotori.
|
|
|
Votazione per
|
|
WriterGoldOfficina
|
|
Biblioteca
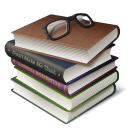
|
Acquista

|
Preferenze

|
Recensione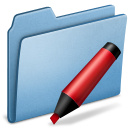
|
Contatto

|
|
|
|
|
|
|
|
Conc. Letterario
|
|
|
|
Magazine
|
|
|
|
Blog Autori
|
|
|
|
Biblioteca New
|
|
|
|
Biblioteca Gen.
|
|
|
|
Biblioteca Top
|
|
|
|
Autori
|
|
|
|
Recensioni
|
|
|
|
Inser. Estratti
|
|
|
|
@ contatti
|
|
|
Policy Privacy
|
|
 Autori di Writer Officina
Autori di Writer Officina 
|
|
|
 Albese di nascita (1960), torinese di adozione. Laureato in Lingue nel 1984 con tesi su Orwell (non su 1984), lavoro dal 1977, ho maturato svariate esperienze manageriali in molte aziende dei più disparati settori e ho tre figli. Prima di scrivere narrativa ho collaborato a un giornale locale (anni ‘80), pubblicato poesie (Diario in frammenti, 1987), scritto un capitolo per un Nobel per la Pace (Woodrow Clark, Sustainable Communities). Ho tradotto (sinora per mero piacere personale) Death of a Salesman di Arthur Miller (1992), The Tenants (1993) di Bernard Malamud, Relato de un nàufrago di Gabriel Garcia Màrquez (1995), Muesli at Midnight di Aidan Mathews (2019), An Honest Man (2020) di Ben Fergusson, The Man Who Saw Everything (2020) di Deborah Levy. Sette i romanzi pubblicati sinora (nessuno a pagamento né in autopubblicazione): Volevo vedere l'Africa (2010), All'orizzonte cantano le cascate (2013), L'alba dei miracoli (2016), Mùnscià (2017), Spegnere il buio (2019), Raccontare troppo (2019), Tu, Bianca e Johnny (2020). Svariati i racconti: in Possa il mio sangue servire (2015) di Aldo Cazzullo, nella Rivista "Pastrengo" (2018), in Piemontesi per sempre (2019) di Autori Vari, e nella rivista "Zona di disagio" (2020) Albese di nascita (1960), torinese di adozione. Laureato in Lingue nel 1984 con tesi su Orwell (non su 1984), lavoro dal 1977, ho maturato svariate esperienze manageriali in molte aziende dei più disparati settori e ho tre figli. Prima di scrivere narrativa ho collaborato a un giornale locale (anni ‘80), pubblicato poesie (Diario in frammenti, 1987), scritto un capitolo per un Nobel per la Pace (Woodrow Clark, Sustainable Communities). Ho tradotto (sinora per mero piacere personale) Death of a Salesman di Arthur Miller (1992), The Tenants (1993) di Bernard Malamud, Relato de un nàufrago di Gabriel Garcia Màrquez (1995), Muesli at Midnight di Aidan Mathews (2019), An Honest Man (2020) di Ben Fergusson, The Man Who Saw Everything (2020) di Deborah Levy. Sette i romanzi pubblicati sinora (nessuno a pagamento né in autopubblicazione): Volevo vedere l'Africa (2010), All'orizzonte cantano le cascate (2013), L'alba dei miracoli (2016), Mùnscià (2017), Spegnere il buio (2019), Raccontare troppo (2019), Tu, Bianca e Johnny (2020). Svariati i racconti: in Possa il mio sangue servire (2015) di Aldo Cazzullo, nella Rivista "Pastrengo" (2018), in Piemontesi per sempre (2019) di Autori Vari, e nella rivista "Zona di disagio" (2020)
Writer OfficinaWriter Officina: C'è un libro che, dopo averlo letto, ti ha lasciato addosso la voglia di seguire questa strada?
Teresio Asola: Ho sempre letto tantissimo, fin da ragazzo, ormai troppi anni fa. Due libri in particolare mi hanno lasciato addosso la voglia di provarci. Due libri molto diversi l'uno dall'altro. Il partigiano Johnny di Beppe Fenoglio, letto almeno sei volte nella mia vita, la prima volta alle Medie, e Relato de un nàufrago, letto in spagnolo una trentina d'anni fa e subito da me tradotto per il piacere di riscriverlo lasciandomi condurre dalla penna di Gabriel Garcia Màrquez.
Writer Officina: A quale dei tuoi libri sei più affezionato? Puoi raccontarci di cosa tratta?
Teresio Asola: Difficile dirlo. Come dire a quale dei miei tre figli sono più affezionato: verrebbe da dire a tutti allo stesso modo. Tuttavia, forse il primo, Volevo vedere l'Africa, è quello che tra tutti ancora oggi mi spiace sia andato esaurito nelle librerie troppo presto e, vendute mille copie, non sia poi stato ristampato. La storia è formidabile, forse perché ispirata alle vicende – vere – di mio padre. Un vecchio di 85 anni, malato di cancro, racconta al figlio la sua avventura giovanile: ragazzo di diciott'anni parte volontario per l'Africa nel 1942 da un paese delle Langhe, combatte in Libia e Tunisia e dopo la disfatta di Enfidaville, catturato dagli inglesi è prigioniero nei campi francesi e americani in Tunisia e Algeria. Degli americani diventa cooperatore (Italian Cooperator), ne veste l'uniforme e con loro s'imbarca per Plymouth. Dalla città inglese scende in Normandia poco dopo lo sbarco alleato, giù fino a Parigi appena liberata e a Marsiglia dove per arrotondare lavora come interprete e accompagnatore degli ufficiali americani per i bassifondi. Torna, poi, ad Alba, ma spaesato torna in Francia, dove emigra, sans-papier ante litteram, passando per sentieri di monte con passeurs del luogo. Compiuta l'esperienza di qualche anno di lavoro in ferrovia dove conosce l'intolleranza mentre incontra nuove opportunità, il giovane torna in Italia.
Un libro di guerra, di memorie, di confronto fra generazioni, di sogni realizzati a metà ma utili per maturare. Di desiderio di partire e di bisogno di un ritorno.
Writer Officina: Quale tecnica usi per scrivere? Prepari uno schema iniziale, prendi appunti, oppure scrivi d'istinto?
Teresio Asola: Prendiamo il primo romanzo di cui ho parlato prima, Volevo vedere l'Africa. Nasce da certe rivelazioni fattemi da mio padre sul letto di morte, undici anni fa: storie di guerra, battaglie, prigionia, collaborazione con gli Alleati, ritorno a casa in divisa americana di un soldato italiano e successivi spaesamento, voglia di fare e migrazione clandestina in Francia. Dopo aver intervistato mio padre mi sono messo a scrivere, senza ben sapere dove mi portasse la scrittura, riempiendo i giustificabili vuoti di memoria con l'invenzione narrativa e la ricostruzione storica, fatta attraverso ricerche d'archivio. Lo schema iniziale è stato il diario scritto da mio padre durante la prigionia in Algeria.
Anche per il secondo romanzo, All'orizzonte cantano le cascate, sono partito da un documento (un diario manoscritto di un macellaio di bordo di un veliero inglese che a inizio ‘800 faceva la spola tra Inghilterra e India), per poi dare libero sfogo alla creazione, sorretta sempre da un buon lavoro di ricerca storica. Nel terzo caso, L'alba dei miracoli, dove parlo di un bambino degli anni '60 nella città simbolo del miracolo economico, Alba, mi sono lasciato guidare da ricordi personali, oltre che da testimonianze di prima mano e da una miriade di articoli di giornali dell'epoca. Anche in questo caso, non mi sono avvalso di uno schema rigido. Lo stesso per i successivi romanzi Mùnscià, Spegnere il buio, Raccontare troppo, Tu, Bianca e Johnny. Unica regola che mi sono dato, sempre: attingere ai fatti veri della vita da riplasmare nell'invenzione narrativa, perché non c'è nulla di più fantastico e inimmaginabile della vita realmente vissuta.
Writer Officina: In questo periodo stai scrivendo un nuovo libro? È dello stesso genere di quello che hai già pubblicato, oppure un'idea completamente diversa?
Teresio Asola: Smettere di scrivere è difficile come smettere di fumare (non fumo, ma immagino le pene). Da una dozzina d'anni dedico tutto il mio tempo libero alla scrittura. Perché? Non so. Certo non per soldi. E neppure per annegare dispiaceri della vita, che non riconosco.
Di solito mi dedico a più di un libro. Mi piace accarezzare le storie, coccolarle, rifinirle, leggerle e rileggerle, scriverle e riscriverle, riporle in un cassetto e riprenderle, più e più volte. Mi è molto difficile separarmi da una storia, dai suoi affanni, dalla consuetudine di una convivenza con i personaggi e le trame e con le difficoltà, la fatica e le gioie del loro sviluppo.
Ora, per esempio, ho – pronti e finiti, per quanto si possa considerare finito un libro – tre romanzi e una raccolta di racconti, oltre a una serie di abbozzi di storie. Due parole sui libri terminati, in attesa di un editore.
Un romanzo ripercorre le vicende di un giovane che viaggia in un mondo più vasto rispetto alla ristretta visuale della sua cittadina simbolo del miracolo economico, sullo sfondo di momenti storici cruciali e di paure di inizio anni '80, non ultimi il terrorismo e le guerre in Medio Oriente. Un altro romanzo intreccia misteri di paese, intrighi di famiglia, sanguinosi fatti di cronaca, inciampi della memoria, tragedie della storia e finzioni della vita: destini incrociati fra tre luoghi piemontesi, inventati ma più che mai veri e familiari. Dove il reale può superare la fantasia. Un terzo romanzo parla di tre città, tre aziende e un giovane che volevano volare (metaforicamente e non solo). La raccolta di racconti è cucita da un filo conduttore: il lavoro manageriale in cinque diverse aziende, ognuna caratterizzata da sfide, aspirazioni e problemi propri, tra declino industriale e visioni di futuro. Ogni racconto - pur legato agli altri da un filo narrativo individuabile - ha vita e sviluppo propri, con finali talora a sorpresa.
Ora, dopo quarant'anni di lavoro manageriale a tempo pieno e tanta scrittura a tempo perso, mi piacerebbe dedicarmi a tempo pieno al fare, artigianale e operaio: scrivere e tradurre.
Prima di scrivere romanzi, da giovane ho scritto poesie, collaborato a un giornale locale e tradotto Death of a Salesman di A. Miller e Relato de un nàufrago di G. G. Màrquez. Nessuno dei due mi generò contratti, perché all'epoca, preso nel lavoro, non ne cercai.
Ora, a sessant'anni, aspiro unicamente alla riscrittura fedele in italiano di belle storie. Ambisco a realizzare scritti onesti per il piacere del lavoro ben fatto, a beneficio dei lettori. Per questo da qualche mese mi sono rimesso a tradurre. Un romanzo inedito al mese.
Ho affrontato Muesli at Midnight, di Aidan Mathews: un romanzo irlandese ostico e disorientante, ma gratificante come una scalata. Protagonisti la parola, il linguaggio, le immagini, i rapporti interpersonali, lo scavo nell'animo umano, fatto di corpo e spirito. Poesia e teatro.
Poi è stata la volta di An Honest Man di Ben Fergusson, in cui il lettore è trascinato nel vortice di un intreccio sorprendente ambientato nel 1989 a ridosso della caduta del Muro di Berlino, in compagnia di personaggi scolpiti. La narrazione è incalzante, gremita di sorprese e rivolgimenti di fronte. Un racconto di amore, tradimento, storie familiari, spionaggio, alla ricerca delle tracce geologiche della storia come delle vicende individuali.
Infine, The Man Who saw Everything di Deborah Levy. Di nuovo fantasmi e speranze della Berlino del 1989, in contrappunto con la Londra di quel periodo, proiettate poi nel 2006 funestato dalla Brexit e dalla contrapposizione tra spaesamento e certezze dell'età matura. Una narrazione commovente, inafferrabile, che parla di vecchiaia, giovinezza, amore, contrasti, inganni.
Per nessuna di queste traduzioni ho trovato un editore italiano. Il momento non è propizio. Tuttavia continuo.
Scrivere è una gran fatica, ma smettere è più dura. |
|
Tutti i miei Libri
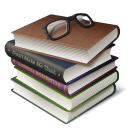
|
Profilo Facebook

|
Contatto

|
|
|
|