
|
 Writer Officina Blog
Writer Officina Blog 
|
  Manuale di pubblicazione Amazon KDP. Sempre più autori
emergenti decidono di pubblicarse il proprio libro in Self su Amazon KDP,
ma spesso vengono intimoriti dalle possibili complicazioni tecniche. Questo
articolo offre una spiegazione semplice e dettagliata delle procedure da
seguire e permette il download di alcun file di esempio, sia per il testo
già formattato che per la copertina.
Manuale di pubblicazione Amazon KDP. Sempre più autori
emergenti decidono di pubblicarse il proprio libro in Self su Amazon KDP,
ma spesso vengono intimoriti dalle possibili complicazioni tecniche. Questo
articolo offre una spiegazione semplice e dettagliata delle procedure da
seguire e permette il download di alcun file di esempio, sia per il testo
già formattato che per la copertina. |
  Self Publishing. In passato è stato il sogno nascosto
di ogni autore che, allo stesso tempo, lo considerava un ripiego. Se da
un lato poteva essere finalmente la soluzione ai propri sogni artistici,
dall'altro aveva il retrogusto di un accomodamento fatto in casa, un piacere
derivante da una sorta di onanismo disperato, atto a certificare la proprie
capacità senza la necessità di un partner, identificato nella
figura di un Editore.
Self Publishing. In passato è stato il sogno nascosto
di ogni autore che, allo stesso tempo, lo considerava un ripiego. Se da
un lato poteva essere finalmente la soluzione ai propri sogni artistici,
dall'altro aveva il retrogusto di un accomodamento fatto in casa, un piacere
derivante da una sorta di onanismo disperato, atto a certificare la proprie
capacità senza la necessità di un partner, identificato nella
figura di un Editore. |
  Scrittori si nasce. Siamo operai della parola, oratori,
arringatori di folle, tribuni dalla parlantina sciolta, con impresso nel
DNA il dono della chiacchiera e la capacità di assumere le vesti
di ignoti raccontastorie, sbucati misteriosamente dalla foresta. Siamo figli
della dialettica, fratelli dell'ignoto, noi siamo gli agricoltori delle
favole antiche e seminiamo di sogni l'altopiano della fantasia.
Scrittori si nasce. Siamo operai della parola, oratori,
arringatori di folle, tribuni dalla parlantina sciolta, con impresso nel
DNA il dono della chiacchiera e la capacità di assumere le vesti
di ignoti raccontastorie, sbucati misteriosamente dalla foresta. Siamo figli
della dialettica, fratelli dell'ignoto, noi siamo gli agricoltori delle
favole antiche e seminiamo di sogni l'altopiano della fantasia. |
|
|
|
|
|
|
Conc. Letterario
|
|
|
|
Magazine
|
|
|
|
Blog Autori
|
|
|
|
Biblioteca New
|
|
|
|
Biblioteca Gen.
|
|
|
|
Biblioteca Top
|
|
|
|
Autori
|
|
|
|
Recensioni
|
|
|
|
Inser. Estratti
|
|
|
|
@ contatti
|
|
|
Policy Privacy
|
|
 Ballata triste a due voci
Ballata triste a due voci 
|

 Giada.
Giada.
Le quattro e cinque.
Ecco, ce l'ho fatta ad arrivare in ritardo. Lo sapevo.
Eppure me l'ero imposto condizionandomi fin da stamattina: parti presto. Non correre. Impara a gestire la tua ansia.
Sì, perché a me essere in ritardo fa venire l'ansia. E adesso sono in ritardo. Il cuore mi batte a mille. Sto sudando, eppure non fa caldo. Ma nemmeno freddo, per essere settembre.
Quello che non sopporto sono le situazioni in cui ti notano tutti. In certi contesti è chiaro che ti notano, figuriamoci: tu sei la maestra, loro i genitori, questa è un'aula, tu sei da una parte della cattedra, loro dall'altra. Sono lì apposta per vivisezionarti, pronti a capire cos'hai che non va e in quale modo perverso potrai nuocere ai loro figli.
Non devo pensare a questo. Non devo pensarci, me ne devo fregare di quello che pensano loro, di come mi vedono. I genitori oggi sono una categoria esigente, i figli che hanno spesso sono unici e preziosi, principi ereditari di fuoristrada e iPhone.
Supplenza annuale. È la prima volta. Non è male, mi hanno detto. È tutto relativo, si potrebbe dire che ho già ventisette anni, e non ho concluso un granché. Sono riuscita ad avere una supplenza annuale, e questo è tutto; immagino che nell'elenco non sia da inserire il fatto che ho preso in affitto un appartamento non lontano dalla scuola con l'aiuto dei miei, e neppure che riesco a sopravvivere cucinandomi i pasti, facendo lavatrici e passando l'aspirapolvere. L'argomento università è meglio lasciarlo stare, visto che ho dato due esami e ho rinunciato. Stavo troppo male. Non ce la facevo. Non avevo abbastanza forza, non lo so, non faceva per me.
I bambini mi piacciono, i genitori meno. I bambini mi piacciono, forse perché neanche io sono mai cresciuta. Mi piace vedere le loro buffe facce, sono teneri quando ti osservano, teneri e curiosi e giudicano solo quello che vedono, ti amano o ti odiano, gli vai a genio oppure no, e te lo dicono pure, te lo dicono subito senza paura di ferirti. E dopo, sono pronti a darti un'altra possibilità.
Le quattro e dieci.
Salgo le scale in fretta e sto sudando, la stoffa chiara della camicetta la sento umida sotto le ascelle. I genitori noteranno subito gli aloni.
Percorro il corridoio largo, pareti gialle, linoleum verde scuro screziato; attraverso quadrati di sole proiettati dai finestroni e quadrati di ombra. Ecco, ci siamo: le porte dell'aula sono già chiuse, sono tutti dentro. Adesso mi tocca passare in mezzo a quegli sguardi, annaspando, con le ascelle pezzate. Respiro a fondo due volte e mi decido. Apro la porta. Sorrido. Entro.
- Scusate il ritardo - , dico maledicendomi. Arrossisco tra quella siepe d'occhi fissa su di me, un rapido calcolo mi conferma quanto anticipato dalla collega più esperta: "Vedrai, è una classe divisa a metà, da una parte i pretenziosi, dall'altra i casi sociali". Una dozzina di genitori presenti, per la precisione nove donne e tre uomini, gli altri saranno altrove, impastoiati nelle paludi della vita. Faccio la parte di quella simpatica e sicura di sé, e intanto guardo soltanto Teresa, la mia collega di vent'anni più vecchia, l'unica faccia nota tra tanti sconosciuti.
Prendo il posto vuoto accanto a lei, Teresa, che accenna un sorriso e riprende a parlare.
Mi presenta, mi sento avvampare. Fa troppo caldo qui dentro, penso, e mi produco in un sorriso tirato. Vorrei trovarmi da un'altra parte, non su un'isola deserta o roba simile, mi accontenterei di molto meno: una doccia. Ecco. Mi basterebbe essere sotto la doccia.
Mi calmo e sbircio di qua e poi di là, ci sono i miei colleghi, gli altri due, di inglese e religione, non li ho mai visti prima. Inglese allampanato e miope (anche se non sembra impacciato quanto me), religione magra come un uscio con la faccia pallidissima (dev'essere una che non arrossisce mai).
Teresa è la maestra di matematica. Io lo so che è brava e molto richiesta, sono trent'anni che insegna in questa scuola. Parla del programma e del metodo. Delle uscite previste. Dell'offerta formativa. I genitori annuiscono soddisfatti. Io lo so che è lei il vero motivo per cui questa sezione è molto ricercata; io sono il motivo per cui non lo è. La maestra di italiano, la supplente. Quella che non conosce nessuno. Sta qui solo un anno, sostituisce la maestra Paola, titolare, ora in maternità. Speriamo bene, mi sembra di sentirli, i loro pensieri. Quello che non dicono aleggia nell'aria, nei loro sguardi, nelle loro bocche storte.
Pensavo fossero arrivati tutti. Invece no, manca ancora qualcuno. La porta si apre e si richiude. Il personaggio che è entrato è diverso da tutti i presenti, non ha niente in comune con nessuno di noi.
Un ragazzo. Abbastanza alto. Ha addosso una giacca di pelle nera aperta, la maglia di un gruppo rock che non esiste più. La prima cosa che si nota sono i capelli, lunghissimi e ondulati fino a metà schiena, folti, castani, in alcuni punti striati di un biondo che, attraversato dal sole della finestra, restituisce bagliori fra il rame e l'oro. Non ci vedo troppo bene, ma il ragazzo ha lineamenti scolpiti con l'accetta, una faccia dura, occhi di un verde metallico e sopracciglia scure. Mentre si avvicina colgo una macchia blu sul suo zigomo, sembra il tatuaggio di una lacrima sul punto di cadere. E ha un piercing al naso, un anello mi sembra, a sinistra. Fa caldo, l'ho detto io. Infatti il ragazzo si leva la giacca sfoderando le braccia tatuate, sul sinistro un disegno nero finisce in una spirale avvolta intorno al polso (un drago? Da qui non si vede), sul destro anche del rosso, potrebbero essere fiori, fiori o sangue, o tutt'e due.
Non ci sono posti indietro, dove forse il ragazzo vorrebbe restare; ce n'è uno libero sul banco in seconda fila, accanto a una mamma molto truccata. Teresa gli fa segno di venire avanti, e lui obbedisce. Lo osservano, proprio come è successo a me: mi sta salvando dagli sguardi degli altri, distogliendo da me l'attenzione.
Adesso fanno a lui la radiografia. È così diverso da loro, sembra provenire da un altro pianeta con i suoi jeans tagliati al ginocchio, la pelle scoperta e chiara delle gambe nervose e le scarpe nere, da basket, con vistosi lacci bianchi.
Qualche occhio indugia su di lui troppo a lungo, ma dev'esserci abituato e non fa una piega, nemmeno si guarda intorno. È molto giovane, lo vedo. Secondo me non arriva ai vent'anni. Dev'essere il fratello di qualcuno e oggi gli è toccato venire a questa riunione, chissà perché. Magari i suoi lavorano, a volte al mondo c'è ancora qualcuno che lavora e non ce la fa a liberarsi per una riunione alle quattro. Oppure sono via, in vacanza alle Maldive. A un safari in Kenya. E invece lui è qua.
Mi tocca parlare. Credo mi tremerà la voce. Devo presentare il programma di italiano. Come si fa a sembrare convincenti, a ispirare fiducia, questo ancora non l'ho capito.
***
È passato quasi un mese dall'inizio della scuola.
I primi giorni sono stati un disastro. Un incubo. Non ero in grado di esercitare nessuna autorità.
Entravo nell'aula e i bambini si scatenavano. Uno saltava sul banco. Uno si metteva a correre. Altri due cominciavano a rubarsi le cose e a litigare, parolacce comprese. Un giorno uno ha rotto un vetro con la testa. Non si è fatto niente, per fortuna, ma poteva succedere di tutto. Un giorno, esasperata, ho sbattuto un altro fuori dalla porta. Non si trovava più, l'abbiamo scovato dopo due ore nello stanzino delle scope. La preside aveva già in mano il telefono per chiamare i carabinieri. Un disastro.
Un giorno in sala insegnanti c'era solo la Teresa, allora mi sono lasciata andare e sono scoppiata a piangere. Io mi vergogno di tutto, eppure quel pomeriggio non avevo voglia di vergognarmi con lei. Mi sono lasciata andare. Volevo mollare, e non riuscivo nemmeno a dirlo.
Lei mi ha dato il tempo. Mi ha preso un tè alla macchinetta. È stata lì ad aspettare che smettessi, che riprendessi a respirare. Non ti preoccupare, è tutto nella norma, mi ha detto. Lo sai già, tu sei giovane, e in questa classe ci sono troppi casi umani, per così dire. C'è la Diletta Corsi che è dislessica grave e avrebbe bisogno del sostegno, ma ancora non gliel'hanno dato. C'è Giulio Fantini che è caratteriale. Tenerlo fermo è un'impresa titanica, devi inchiodarlo alla sedia. C'è Piero Tramella, che l'anno scorso ha crocefisso al banco il compagno piantandogli una matita nella mano. C'è la Bianca Petrini, che ancora non sa leggere. C'è Sahid Omar Mustafa, marocchino, che l'italiano non c'è verso di farglielo imparare. E c'è Daniel Omani, albanese, che gli abbiamo trovato un coltello a serramanico in tasca. Poi ci sono i due africani, Abdou e Sekh, vengono dal Senegal e sono anche educati, però anche loro sono arrivati l'anno scorso e con l'italiano non sono messi bene. E c'è Oscar Esposito, che sua madre è morta di overdose tre anni fa. Ma tu non ti devi scomporre, mi ha detto, la vita è un carosello di casi umani e non devi lasciarti travolgere. La vita è così, è complicata, e tu devi essere più forte. Datti il tempo che serve, vedrai che ce la fai.
Mentre Teresa parlava, le facce dei bambini che nominava mi scorrevano davanti come foto a colori.
Diletta Corsi, un caschetto biondo spettinato, occhi scuri e appuntiti come quelli di un topo.
Giulio Fantini, una faccia tonda e rossa, il moccio al naso sempre e il fazzoletto mai, rutti capaci di far tremare i muri.
Piero Tramella, una testa così di ricci neri eppure non è lui l'africano, la sua specialità è bestemmiare, poveretto. Ed è sveglio, le cose le capirebbe al volo, se solo stesse fermo un secondo ad ascoltare.
Bianca Petrini, otto anni e a vista ne dimostra dodici, come cognizione non più di quattro.
Sahid, due occhi neri che bruciano, secondo me potrebbe essere in gamba, ne avrò la conferma quando smetterà di parlare in arabo.
Daniel Omani, l'albanese dotato di coltello, anche gli occhi sono affilati come lame. Mi guarda di traverso e un po' devo dirlo, a sette anni mi fa già paura.
E i due gemelli africani, Abdou e Sekh, bellissimi e apparentemente muti, due sculture d'ebano che mi fissano dal banco in seconda fila, sono arrivati a giugno e l'italiano ancora non lo sanno.
E infine, Oscar Esposito. Un bambino tranquillissimo. Occhi enormi e azzurri come laghi. Capelli da pulcino, arruffati e chiari. Educato, non alza mai la voce. Non fosse per la mamma che se n'è andata quando aveva solo quattro anni, non lo metterei fra i casi umani; ma se sei orfano è ovvio, ci finisci dentro di default. Sua madre, poi, non è morta di qualcosa di discreto, ictus o infarto, no: è morta di overdose. Tre anni fa. Era una tossica, probabilmente da prima che lui nascesse. Ora è affidato al padre, un napoletano che traffica in mozzarelle con la Germania.
Ha ragione Teresa: Oscar Esposito è il caso umano per eccellenza.
Ormai avevo smesso di singhiozzare. Teresa mi ha guardato e mi ha detto: domani vengo in classe con te, e vediamo.
Così è stato. Il giorno dopo è entrata in classe insieme a me, e i ragazzi sono stati zitti. Perfino abbastanza fermi. Ero talmente stupita che non ho ascoltato le parole di Teresa, non so nemmeno di preciso cos'ha detto. Peccato: poteva essere utile per il futuro. Perché da quel preciso momento, i ragazzi sono cambiati. Non completamente, è vero; non improvvisamente. Ma da quel momento hanno iniziato a cambiare. Gridavano meno. Si muovevano meno. Tramella non bestemmiava più. Le cose sono andate migliorando, per fortuna. Vanno ancora meglio da quando alla classe hanno assegnato un insegnante di sostegno, un calabrese di trent'anni che divide i suoi sforzi fra Diletta Corsi e Bianca Petrini, e a tempo perso prova a insegnare l'italiano agli stranieri. È uno allegro. Si chiama Alberto. A lavorare insieme mi sembra che ci troviamo bene.
Oggi piove che dio la manda, e c'è lo sciopero generale del pubblico impiego. L'autista dello scuolabus ci ha chiamato tre giorni fa e ha avvisato che sì, aderirà anche lui.
Perciò l'abbiamo fatto scrivere sul diario tre giorni fa, i genitori oggi devono organizzarsi per recuperare i figli, tutti, anche quelli che di solito cinque minuti prima della campana seguono in fila indiana il bidello, o per meglio dire il collaboratore scolastico, che li accompagna in cortile e li fa salire sul pulmino giallo.
È suonata. Scendiamo le scale. Devo sgridare Tramella perché ha il vizio di correre. Vai piano Tramella che butti per terra i compagni
Per fortuna c'è Alberto, l'insegnante di sostegno, che con le sue maniere forti lo prende per un braccio impedendogli di travolgere metà classe.
Siamo fuori. Piove a scroscio, e non fa nemmeno caldo per essere ottobre. Molti genitori sono già arrivati, è un mondo grigio, gli unici colori che vedo sono quelli vivaci degli ombrelli aperti. L'aria è umida di foglie marce, pesante da respirare.
Lascio andare uno a uno i figli man mano che vedo i genitori. È così che bisogna fare al giorno d'oggi, per essere sicuri. Che non li prenda qualche malintenzionato. O che non se ne vadano via da soli. Che non finiscano chissà dove, insomma.
Si ficcano sotto l'ombrello camminando svelti, si appendono al braccio della mamma e se ne vanno mostrandomi le schiene con gli zaini fitti di disegni e colori. Zaini e giacche sgargianti si aggiungono agli ombrelli, ma di altri colori in giro non ne vedo, è un mondo opaco e sbiadito come una vecchia foto. L'aria è bagnata. Ecco, il padre di Daniel arriva ora, parcheggia il furgoncino in doppia fila col motore acceso, ha addosso la tuta blu da lavoro e si sbraccia.
Arriva anche la mamma dei gemelli africani. Lei sì che ha addosso un vestito colorato, verde e giallo a disegni neri col turbante uguale, sembra arrivata adesso dall'Africa nera, peccato che sopra si sia infilata uno di quegli impermeabili da stadio, trasparenti, di plastica arancione.
Mi guardo intorno e non resta più nessuno, a parte Oscar Esposito. Alberto sbircia l'orologio, si sta innervosendo: - Vai pure – gli dico – Aspetto io, tu vai - .
Coglie al volo la proposta – chi non lo farebbe? – e mi ringrazia. Viene giù un'acqua del diavolo. L'autobus che lo condurrà in una frazione fuori città passa soltanto una volta ogni ora.
Ha preso in affitto lì perché le case costano meno. Come dargli torto se si mette a correre, non si sa mai che l'autobus arrivi in anticipo e lo pianti a piedi.
Guardo Oscar e lui non mi guarda, occhi azzurri sgranati persi nel vuoto a fissare la pioggia. È piccolo. D'istinto mi avvicino fino a toccarlo. Gli prendo la mano, fredda come la testa di una biscia.
- Vedrai che arrivano - , gli dico, e solo allora lui mi vede attraverso i capelli arruffati dall'umidità, mi guarda per un lungo momento, muto, poi torna a fissare la strada, sconsolato. Ha paura che si siano dimenticati, penso, e forse è vero, forse si sono dimenticati di lui.
Le quattro e tre quarti. Passano i minuti, stiracchiati come lombrichi, allo stesso modo bagnati. Le cinque meno cinque. Le cinque, Oscar non dice niente, tiene gli occhi bassi.
- Fa freddo qui, andiamo ad aspettare dentro. Proviamo a telefonare... – ecco, sto per dirlo, proviamo a telefonare a tua mamma, per miracolo mi fermo sull'orlo del precipizio – a tuo papà. - Mentre saliamo le scale lui scuote il capo: - Non c'è mio papà, è in Germania con il camion, a lavorare - .
Entriamo nell'edificio e mi segue, docile, fino in sala insegnanti.
Non c'è più nessuno. In corridoio, la bidella anziana, anzi, la collaboratrice scolastica un po' su d'età spazza svogliata il pavimento.
Oscar posa lo zaino a terra e siede alla scrivania. Resta immobile e non fiata, mortificato. Lo so come si sente: insignificante abbastanza da essere dimenticato da qualche parte come un pacco inutile.
- Preferisci il tè o la cioccolata? - gli chiedo. Frugo nella borsa a caccia di monete e mi avvicino alla macchinetta.
Cioccolata, ovviamente, e io provvedo. Poi prendo la carpetta con le schede dei ragazzi, in cerca dei numeri da chiamare.
Sono le cinque e un quarto, tra un po' chiudono la scuola. Sta' a vedere che mi tocca farmi lasciare le chiavi dalla bidella e finire di lavare il pavimento.
Esposito Oscar, eccolo qua. Ci sono due cellulari, padre e fratello. Il padre lo scarto subito e compongo il secondo numero. C'è scritto solo questa parola accanto alla fila di numeri: fratello. Nemmeno un nome.
Suona a vuoto, tanto a lungo che scatta la segreteria.
Riattacco e riprovo, e stavolta è peggio, la voce registrata mi informa che il telefono è spento o irraggiungibile.
Bene Oscar, penso. Siamo messi bene. Rabbrividisco, sta a vedere che ormai hanno spento anche il riscaldamento. Lascio andare un sospiro. Oscar beve la cioccolata bollente a piccoli sorsi.
- Ce l'ha scarico - mi dice, rassegnato. - Il telefono – ripete – ce l'ha scarico. -
- Non preoccuparti – replico poco convinta – Vedrai che adesso arriva. -
La bidella mette dentro la testa, gentile ma irremovibile nel suo camice carta da zucchero.
- Signora, io qui dovrei chiudere. -
- Vieni Oscar, usciamo. -
Non ci siamo nemmeno tolta la giacca. Ci incamminiamo senza voglia, sono le cinque e mezza suonate.
Eccoci di nuovo qui, sotto la tettoia davanti all'ingresso. La pioggia batte, metallo su metallo, neanche piovessero chiodi.
La bidella ci raggiunge per chiudere pure il cancello. Ci allontaniamo.
Oscar tira su col naso, gli guardo gli occhi, sono lucidi, seguono la piega triste delle labbra. Cerco un fazzoletto, vorrei dirgli qualcosa, ma non mi riesce. Spero non si metta a piangere: io, al suo posto, lo farei, e forse anche al mio.
Cosa facciamo, Oscar? Ci mettiamo a piangere? O resistiamo, e facciamo quelli forti? Apro l'ombrello e lo tengo per mano. Abbandoniamo la scuola, la tettoia, il cancello, la bidella mi saluta e se ne va di corsa, largo ombrello nero, rasentando il muro.
Sembra notte fonda. No, mi dico, è troppo presto; eppure è proprio così, andiamo verso la notte e non verso la luce. Piove e piove. Qualche motore ogni tanto, un autobus, una macchina. Le sei meno dieci.
- Theo! - dice Oscar, puntando l'indice verso la fine della strada.
Un ragazzo spinge uno scooter sotto l'acqua, appena giù dal marciapiede. Ci avviamo verso di lui. Oscar riprende vigore, è lui ora a guidarmi, e di questo sono contenta.
Eccolo, Theo. Be', certo, è lui, quello della riunione. L'avevo intuito, il fratello tatuato, il metallaro. Cammina sotto l'acqua come se non piovesse, una determinazione zen nello sguardo. Invece piove, l'acqua gli ha incollato virgole di capelli sulla faccia e sul giubbotto di pelle.
È fradicio, in condizioni pietose. Le scarpe di pezza investono le pozzanghere, i jeans tagliati al ginocchio sgocciolano sulle gambe nude. La maglietta, un tempo bianca, ha cambiato colore incollandosi alla pelle sotto il giubbotto. Copiosi rivoli d'acqua gli solcano la faccia grigia. Si ferma davanti a me e, senza lasciare lo scooter, mi tende la mano.
- Mi dispiace – dice soltanto – Sono rimasto a piedi con lo scooter - , e questo l'avevo capito. La mano è fredda come il ghiaccio, quasi altrettanto dura.
- Ero a casa di dio – continua tranquillo come se non si stesse bagnando, senza fretta – non potevo lasciare lo scooter, perché mi serve. Stasera devo aggiustarlo. E poi, non si sa mai che me lo freghino. -
- Non importa - gli dico, e per istinto mi viene da prendere sotto l'ombrello anche lui. Siamo tutti e tre al riparo, lui fradicio, noi umidi. Gli occhi chiarissimi di Oscar sorridono, ci guardiamo come se non sapessimo più cosa fare.
- Ce l'ha la macchina? - mi chiede Theo.
- Sì. Vi accompagno a casa. - Ma lui, il metallaro bagnato, scuote la testa facendo baluginare l'anello al naso: - No, grazie. Io devo portare a casa lo scooter, sono troppo bagnato per salire su una macchina. Per favore, può accompagnare a casa mio fratello? -
Certo che posso. Ho la macchina qui dietro. Il bambino saluta il fratello e mi segue. È allegro, come se il cosmo intero avesse riacquistato il suo naturale significato. Eccola, saliamo. È una Punto vecchia, di un insulso grigio metallizzato. Però è asciutta. Il metallaro mi ha dato le chiavi di casa, l'indirizzo e poi grazie e buonasera. È anche educato. Peccato che siano già le sei e dieci.
Dove finisce la strada, finisce anche la città, il quartiere dove abitano gli Esposito mostra palazzi anni Settanta addormentati sotto l'acqua battente, a tre chilometri dalla scuola, limite massimo raggiungibile dal pulmino del Comune.
Più in là il nulla, soltanto una distesa scolorita di campi incolti sotto la volta grigia del cielo, nemmeno buoni per giocarci a pallone.
- Ecco, gira di qua maestra - , mi dice Oscar, improvvisamente allegro. Da quando gli è apparso suo fratello, ha ritrovato il sorriso.
Una strada cieca, parcheggio selvaggio sul marciapiede sconnesso, lampioni che gettano spessi barbargli arancioni sulle pozzanghere. La casa è l'ultima in fondo, intonaco giallo ocra, mattoni a vista. Alcune finestre lasciano filtrare luci pallide, bianche e gialle.
Oscar mi chiede la chiave.
Mi giro a controllare la macchina: i fari li ho spenti, ma le due ruote sul marciapiede lasciano proprio a desiderare. Raggiungo Oscar e lo prendo sotto l'ombrello. Il cancello è aperto, e anche il portone di vetro. Saliamo in ascensore, terzo piano, via Che Guevara 9.
Sono le sei e venti, e tuttavia sul ballatoio del terzo c'è odore di minestrone. Oscar apre la porta e lascia cadere lo zaino lì appena dentro. Non si è nemmeno pulito i piedi sullo zerbino, ma è il minore dei problemi: in casa regna il caos. Ci metto un po' ad abituarmi a quella vista, a ritrovare l'orientamento. Sì, sono ordinata, è un mio problema, sulle prime non mi raccapezzo.
Si entra direttamente nel soggiorno con cucina. La prima cosa che noto sono un paio di lattine rotolate sotto il divano. La seconda è il lavandino, ingolfato di piatti da lavare macchiati di sugo. Vicino alla porta, in fondo, c'è un cumulo di vestiti contro il muro, felpe e maglie e pantaloni e calze accatastate in un disordine scientifico, in attesa che il loro destino venga definito. Di vestiti ce ne sono anche altri sulle sedie e sul divano, e qualcosa per terra qua e là, del rosso e del verde, in un disordine meno scientifico.
La giacca a vento di Oscar giace a terra, bagnata, accanto alle scarpe che spandono una piccola pozzanghera sulla marmiglia del pavimento. Raccolgo la giacca e la appendo all'attaccapanni vicino all'ingresso.
Sul pavimento, sotto il tavolo, è montata una pista elettrica per le macchinine. Una moltitudine di automobiline stanno in fila, ordinate, in attesa di salire sulla pista. Sul tavolo c'è una parata di dinosauri di plastica, dal più grande (un brachiosauro alto trenta centimetri) al più piccolo (non identificato). Sempre sul tavolo, una scuderia con cavalli affacciati alle finestre e un pick-up parcheggiato appena fuori, e davanti a una sedia vuota un libro aperto, dei quaderni, un foglio da disegno. Mi avvicino: il libro è un testo di disegno meccanico. Il ragazzo con cui stavo al liceo aveva lo stesso libro. Si vede che anche il metallaro fa l'ITIS, perito meccanico.
Penso che mangeranno la pastasciutta seduti sul divano, non ce la faranno a sgomberare tutta quella roba in tempo utile.
Oscar accende la TV, c'è un cartone animato di Spongebob; raccoglie una ciotola da terra e si siede sul divano. Mangia a manciate quel che resta di un sacchetto di patatine. Tende la ciotola verso di me: - Vuoi? -
- No, grazie - .
A questo punto, immagino che dovrei prendere la porta e uscire, salire in auto, andare verso casa. Mi riesce troppo difficile lasciare Oscar da solo. Non so perché. Capisco che ci deve già essere stato altre volte. Capisco che è abituato, e non ha paura. Sì, posso andare. Ma non ce la faccio. Mi levo la giacca e mi siedo sul divano accanto a lui, pensando che il metallaro tatuato ci metterà almeno un'altra mezzora ad arrivare, arrancando nelle pozzanghere dietro allo scooter guasto. Così mi siedo e mi metto tranquilla. Oscar ride alle battute della spugna sullo schermo, e rido anch'io. Poi faccio vagare lo sguardo.
Sulla credenza ci sono due foto. In una c'è una donna, capelli chiari e lisci, occhi grandi e malinconici. Indossa una camicetta scollata, un giubbotto di pelle del tutto identico a quello che porta il figlio, forse lo stesso. Nell'altra c'è un uomo bruno e sorridente, tiene per mano i suoi figli, Oscar molto piccolo, e l'altro, non ancora un metallaro, non ancora tatuato, un dodicenne con la faccia già dura e lo sguardo antico di un vecchio.
Il padre ride fissando l'obiettivo, una di quelle belle facce sfrontate che vengono dal sud dell'universo. Chissà cos'aveva da ridere poi, mi chiedo, e chissà dov'è adesso.
In un angolo c'è uno stereo anni Ottanta di quelli grandi e neri, con il piatto sopra e sotto il mangiacassette e la radio; lo sportello di vetro nasconde una quantità di dischi. Sarei curiosa di guardarli, prenderli in mano, vedere di cosa si tratta.
Il cartone finisce, inizia il telegiornale. Oscar si accomoda con la testa sul cuscino e chiude gli occhi. Sono le sette, e ha sonno. Sono le sette, e ho sonno anch'io. Mi rilasso, poso la testa sullo schienale del divano, allungo le gambe, travolta da un'improvvisa stanchezza. La tensione si dissolve a un tratto, alla deriva sul divano stinto, sul cuscino scucito, accanto al bambino che dorme.
Il campanello mi fa trasalire. Apro io, le chiavi le ha date a me, sono sul tavolo.
Dalla tromba delle scale sale aria umida, odorosa di pioggia. Il ragazzo avanza piano, stanchissimo, un gradino dopo l'altro. Spalle curve, faccia bianca e scavata, occhi persi, capelli e vestiti fradici. Si sfila le scarpe prima ancora di entrare e le getta fuori dalla porta, mi accorgo che trema.
Non dice niente, solleva lo sguardo su di me, non pensava che fossi ancora qui. È infastidito e stanco.
- Ho fame - dice Oscar, improvvisamente sveglissimo.
- Guarda cosa c'è nel frigo - dice il ragazzo, la voce persa da qualche parte, rauca.
Oscar apre il frigo e la visione è desolante: una bottiglia di latte mezza vuota, un cartone di succo di frutta, due arance. Una birra iniziata, tre ancora da aprire, un tubetto di conserva. Tutto qua.
- Metto su l'acqua - mentre lo dice Theo si spoglia, come se io non ci fossi. Mi convinco di essere invisibile mentre lui lascia cadere a terra nell'ordine il giubbotto (sì, credo sia lo stesso, lo indossa sua madre nella foto. A lui sta stretto, a lei di sicuro stava largo), i jeans, la maglia. A torso nudo va verso il pensile della cucina, prende una pentola, la riempie d'acqua e la mette sul fuoco. Ha addosso solo i boxer a righe bianche e nere. Bagnati, incollati alla pelle. Trema, e capisco che non potrebbe parlare nemmeno se volesse. Si gira verso di me. Ha le labbra viola, immagino sia il freddo. Ho paura che si senta male, guardo i suoi tatuaggi, spiccano sulla pelle bianca, un paio d'ali come quelle di un angelo sotto le clavicole, larghe quanto le sue spalle. Ali d'angelo senza l'angelo attaccato, chissà cosa vogliono dire, chissà perché. Però le trovo belle, sono disegnate benissimo. Divento rossa mentre esploro con un'occhiata furtiva i tatuaggi sulle braccia; sul destro un cuore rosso che sanguina e un disegno di rami e fiori; sul cuore un nome, Frieda, in un bellissimo corsivo; sul sinistro qualcosa di nero e verde, un drago stilizzato fuso con un fregio medievale, l'elsa di una spada, la spirale della coda avvolta intorno al polso. Bello. Sono incisi sulla pelle bianca di un fantasma nervoso. Mi guarda infastidito, non dovrei essere lì, spettatrice di un disordine privato.
È un attimo.
Mi volta le spalle e va verso il bagno, chiude piano la porta. Sento l'acqua della doccia scorrere.
Lo sguardo mi cade sulla faccia tonda di Oscar, i capelli chiari e aggrovigliati, da pulcino.
- Quando torna il papà? - gli chiedo.
- Non torna – dice lui scuotendo la testa – È via, a lavorare. Lontano da qua - .
Faccio segno di sì con la testa, voglio dire che sì, ho capito, e guardo ancora le due foto in cornice sulla credenza. Non sono in grado di darmi nessuna risposta. Passa un tempo lungo abbastanza da far bollire l'acqua nella pentola.
Il ragazzo esce dalla doccia, e io sono ancora lì. Non so perché non riesco a schiodarmi.
Per fortuna adesso è vestito, jeans scuri, maglietta nera. Non è più così pallido. Non trema più. Mi fa venire in mente che avrei bisogno anch'io di una bella doccia.
- Quando torna tuo padre? - gli chiedo. Non riesco a trattenermi, a farmi gli affari miei.
- Non torna – risponde Theo fra i denti – è via per lavoro. All'estero, in Germania. Ma no, forse torna. Forse alla fine della settimana - si corregge sbirciando verso di me, preoccupato di non avere dato la risposta giusta.
- Come fai domani se lo scooter non va? - gli chiedo, e anche qui capisco che non sono affari miei.
- No, ce la faccio – dice Theo, e si schiarisce la voce – Sono bravo in queste cose. Aggiusto lo scooter stanotte. Viene un mio amico ad aiutarmi, se non ce la faccio vado a scuola in autobus. Ma ce la faccio. -
Si avvicina al fornello e butta la pasta, mezzo pacchetto di fusilli già aperto. Tira fuori dal frigo il tubetto di conserva. Prende l'olio. Due piatti e due forchette. Ha i capelli a metà schiena ancora bagnati. Non si è nemmeno preso la briga di asciugarli.
Chiudo gli occhi, combatto il senso di malinconia che mi precipita addosso (è perché siamo soli tutti, penso). Lascio andare un sospiro.
- Ci vediamo domani - dico al bambino e mi decido, finalmente, a uscire dalla porta.
Theo
La maestra di Oscar ha due tette così. Non so perché, ma le ragazze della mia età le tette le hanno sempre piccole; almeno quelle con cui sono stato. Insomma, quelle che ho toccato. Che peccato, non è una cosa tanto giusta. Io due tette così me le sogno di notte, e nel sogno ci affondo la faccia dentro, le annuso e le lecco, sono uno spettacolo assoluto, è il paradiso, più o meno. Quando vedo la maestra di Oscar mi viene in mente solo quello, le sue tette. E gliele guardo. Ci riuscivo meglio alla riunione, quando tutto quello che dovevo fare era starmene lì, fermo, appunto a guardare, e poi faceva caldo e lei era tutta sudata, in agitazione perché doveva parlare, e aveva addosso una camicetta leggera che lasciava indovinare il colore del reggiseno, e potevo capire facilmente che quell'arnese non conteneva tutto, non poteva. A prescindere dal fatto che si veste come mia nonna, anzi, mia nonna era più avanti: si veste in un modo che più da maestra non si può, neanche fosse una divisa.
È stata gentile. Ha accompagnato Oscar a casa, meno male, considerato il diluvio che veniva. Avevo sperato ci fosse qualcuno con la macchina, che potessero accompagnarlo a casa. Lo scooter mi aveva lasciato a piedi, ma vaffanculo, il degno coronamento di una giornata di merda, con un tempo di merda. Così avevo dovuto farmi due chilometri sotto l'acqua, e una volta arrivato a scuola me ne mancavano ancora tre. Non potevo far camminare sotto l'acqua anche mio fratello. Così ho chiesto alla maestra se poteva accompagnarlo, e lei è stata gentile.
Poi però mi ha preso male, non so perché.
Quando sono salito in casa, fradicio e stanco morto, lei era ancora lì.
Questo non l'avevo previsto. A pensarci era logico: mio fratello è un bambino, e i bambini, suppongo, in un mondo come si deve non andrebbero lasciati mai in casa da soli. Dovevo aspettarmelo. E invece...
Ho suonato perché le chiavi le avevo date a lei, ma non so perché non mi aspettavo che fosse ancora lì. Invece mi ha aperto la porta. Allora mi sono guardato intorno e ho visto, con gli occhi nuovi di lei, tutto il disordine che c'era, il casino della nostra vita, i piatti sporchi, i vestiti per terra a mucchi, e mi sono vergognato.
Stupido che sono, a non averci pensato. Lei lo capirà, che mio padre non vive qui. Lo capirà che in casa siamo io e Oscar, e nessun altro. Forse ci è già arrivata, perché non sembra scema. Sono scemo io, che non ci avevo pensato. Era meglio se lo facevo camminare sotto l'acqua, mio fratello. La maestra non sarebbe salita in casa e non avrebbe cominciato a porsi delle domande. Che non le venga in mente di approfondire, di saperne di più. Magari di segnalare la cosa ai servizi sociali. Ma no, io sono maggiorenne, cosa vogliono da me? Non sono un bambino. Mio fratello sì che lo è, ma io so badare a lui. So fare tutto quello che serve. Noi stiamo bene da soli, non ci servono gli adulti. Non sappiamo che farcene.
Insomma, l'ho vista lì e la cosa mi ha dato il nervoso. Volevo che sparisse, ero fradicio, esausto. Avevo la bocca piena di bestemmie fin dalla mattina, quando a scuola era andata malissimo. "Theo se continui così perdi l'anno un'altra volta" (Certo, non fanno che menarla tutti, sono già stato bocciato una volta, è stato l'anno che è morta mia madre. Come se potessi dimenticarlo). E poi si erano aggiunte altre bestemmie più tardi, quando dopo i laboratori e sotto quell'acqua il motorino si era rifiutato di partire, e adesso mi tocca andare in garage ad aggiustarlo. Sarà il solito filtro dell'aria che si intasa, e bisogna smontarlo e smadonnare, oppure potrebbe essere la candela bagnata, o anche il carburatore, o checazzonesoio.
Mi ha dato il nervoso. Anche se lei ha una faccia tonda e liscia, capelli chiari, occhi grandi che non so il colore, nocciola forse. Mi guardava come se la spaventassi, è per quello che mi è venuta voglia di provocarla. E non è che ci avessi pensato, non lucidamente. Mi sono spogliato lì, davanti a lei, in sala, appena dentro, e non l'avevo deciso prima, ma non posso neanche dire che non l'ho fatto apposta, perché ero io, quello che si è spogliato, io e nessun altro, e nemmeno mi vergognavo. Ho lasciato i vestiti dove sono caduti, fradici, e in mutande me ne sono andato a fare la doccia. Dentro mi montava una rabbia antichissima che non sapevo come sfogare, e non era colpa sua, e nemmeno mia, né io né lei eravamo responsabili di tutta quella rabbia. Tremavo per il freddo e la stanchezza, in quelle condizioni potevo arrancare giusto fino alla doccia, ecco, non più in là.
L'acqua calda mi ha snebbiato il cervello. Ho capito che provocare era sbagliato, che dovevo mostrarmi gentile. Ho sperato che non tutto fosse perduto. Magari la maestra è una che alla fine si fa i cazzi suoi, ho pensato. Sono stato a lungo sotto l'acqua bollente, il vapore un fumo bianco e spesso che invadeva tutto. Ho chiuso gli occhi. Mi sono rannicchiato giù, sul piatto della doccia, e ho aspettato abbastanza a lungo perché l'acqua bollente mi scaldasse la pelle, mi entrasse nelle ossa. Sono stato sul punto di svenire e perdermi, avrei dato chissà cosa per andare via, sciogliermi e svanire nel buco nero dello scarico. Invece poi ho aperto gli occhi: ero ancora lì. Ho chiuso l'acqua e mi sono rivestito. Parte della rabbia se n'era andata, ingoiata dalla finestra socchiusa insieme al fumo bianco. Forse non tutto è perduto, ho pensato, ma sapevo già che non ce l'avrei fatta a mostrarmi affabile. Comunque non tremavo più ed ero vestito, già un bel pezzo avanti rispetto all'immagine di me che avevo dato poco prima.
- Quando torna tuo padre? - mi ha chiesto, e allora ho capito che no, non è una che si fa i cazzi suoi.
- Non torna. È via per lavoro. All'estero, in Germania - ho detto, poi ho capito che l'avevo sparata enorme.
- Forse alla fine della settimana - ho aggiunto allora, era una rettifica ufficiale. Lei mi guardava con gli occhi nocciola e con le sue enormi tette, e io non so se l'ha bevuta, se tornerà alla carica.
- Come fai domani se lo scooter non va? - mi ha chiesto ancora, e io le ho detto che l'avrei aggiustato, rassicurante, era questo che volevo essere, sicuro di me e delle mie capacità. A quel punto le ho girato le spalle e ho buttato la pasta, non la guardavo più. E lei l'ha capito, che se ne doveva andare. Ha salutato mio fratello, ha girato anche lei le spalle. È uscita piano dalla porta.
***
Fino alle tre di notte, abbiamo montato e rimontato tutto due volte, impianto elettrico e motore. Se solo non fosse così incasinato l'Habana 125, solo a smontare la batteria ti ci vuole mezz'ora, e qualunque cosa devi fare per cominciare ti tocca smontare il manubrio; roba da officina meccanica, oppure venite da me, venite da Enrico: non ci sono alternative.
Enrico è arrivato alle dieci con sei lattine di birra. Lui è bravo a scuola, non come me. Doveva finire di studiare. Sua mamma, finché non aveva finito, non lo lasciava uscire; è una prof d'inglese sua mamma, e non la freghi, non c'è verso.
La prima volta abbiamo finito di rimontare che era già l'una, controllato tutto, pulito le candele, sostituito la batteria con un'altra che avevo messo in carica: nessun segno di vita, e la birra l'abbiamo bevuta tutta. Ho tirato due madonne e sono salito in casa a controllare Oscar – dormiva – e a prendere la scorta che tengo per i momenti difficili: l'ultima birra dal frigo e la roba sufficiente per un paio di canne. Abbiamo fumato sotto il portone basculante aperto del garage, la pioggia che scrosciava sul metallo, assordante. Poi abbiamo bevuto e infine, senza parole, ci siamo messi a smontare e a rimontare. Erano le tre quando sono riuscito a mettere in moto. Ero esausto. Enrico ha mandato un messaggio a sua mamma per comunicarle che era ancora vivo, e si è avviato verso casa.
Sono salito di sopra e sono caduto sul letto grande accanto a Oscar, di traverso sopra le coperte. Non mi sono nemmeno levato gli anfibi, sono svenuto lì, collassato così com'ero. La luce arancione fuori mi investiva la faccia, luccicante di pioggia sotto le tapparelle che non mi ero preso la briga di abbassare, ma non mi importava, troppo stanco perfino per girarmi dall'altra parte.
Quando è suonata la sveglia ci avrei giurato che non erano passati più di tre minuti, e invece erano quasi quattro ore che dormivo. Quattro ore nella stessa posizione come un cadavere, e non riuscivo a muovermi, il collo indolenzito, la schiena a pezzi. Quando ho tirato su la testa, Oscar si stava già vestendo. Ce n'è voluto per tirare su anche il resto, ma alla fine ce l'ho fatta.
Quello che non riuscivo ad accettare era che dovevo andare a scuola anch'io. Un concetto abbastanza lineare, ho fatto un casino di assenze. Alla prima ora c'è la verifica di disegno meccanico, sono iscritto a scuola, il penultimo anno e blablabla, mi hanno già bocciato una volta e se continuo così lo so come andrà a finire, non è così difficile, eppure niente, il mio cervello malato si rifiuta di accettarlo come se esistesse un'alternativa, e potessi farne a meno.
Mi sono alzato tutto rotto come un vecchio di ottant'anni, mi facevano male le giunture, ho dato la colpa a tutta l'acqua che ho preso, peggio del diluvio universale. Due madonne e sono andato di là, amaro dentro la bocca e la luna storta. Pioveva ancora.
Oscar ha preso i biscotti dal sacchetto restando in piedi, ha la paranoia di arrivare tardi, l'incubo che lo scuolabus lo lasci a piedi, cose così.
Siediti, gli ho detto, mancano dieci minuti, e gli ho spalmato un po' di marmellata su un panino. Ho sollevato solo allora l'avvolgibile, pioveva. "Cazzo, ci risiamo – ho imprecato fra i denti – "Piove".
E non è che l'inizio. Dell'inverno. Della strada. Della vita. A volte vorrei davvero lasciarla vivere a qualcun altro. Mandare tutto a puttane, insomma mandare al diavolo tutto, anche quel poco che non c'è ancora andato. Poi smetto di guardare fuori dalla finestra, vedo Oscar, e capisco che non posso mandare tutto a puttane, non posso perché c'è lui. Io sono la sua famiglia. Non ha altro, e mi sa che non è messo bene, poveretto. Devo esserci per lui, non posso mollare. Perché anch'io non ho altro. Niente altro di cui m'importi un cazzo, davvero.
Il clacson. Mi sono imbottito la testa di pensieri inutili e i dieci minuti sono passati. Oscar scatta in piedi, si pulisce la bocca con il dorso della mano e si fionda giù dalle scale. Guardo nella pioggia grigia il pulmino giallo che riparte. "Scuolabus", c'è scritto sopra, in corsivo. Sono le sette e mezza.
Ce la posso fare. Di solito ho la forza di volontà di un protozoo, ma oggi non cedo. Colpo di reni, e vado a scuola. Faccio la verifica. Prendo la sufficienza. Basta metterselo in testa.
Vado di là forte del mio proposito a levarmi la felpa dei Metallica con cui ho riparato lo scooter fino alle tre (macchie di grasso? Sì, ma è nera. Mica si nota) e poi dormito fino a mattina (spiegazzata? Sì, ma è una felpa! Che cazzo volete da me?) Comunque, per il quieto vivere sfilo la felpa dei Metallica e infilo quella, grigia, dei System of a Down, ed è allora che lo vedo, mentre passo in rassegna la mia faccia pallida, i capelli imbizzarriti, le occhiaie scure, la felpa che mi sta da dio. Là in fondo, dietro le mie spalle. Nell'angolo inferiore destro dello specchio.
Lo zaino.
Il maledetto zaino di Oscar, rosso e blu, dell'Invicta, era mio.
L'ha lasciato qui. È andato a scuola senza zaino, il piccolo stordito. A questo punto cosa volete che faccia? Mi sa che era destino: io, la verifica di disegno meccanico, oggi, non la dovevo fare.
Giada
Un pianto inconsolabile. Prima singhiozzi, e adesso lacrime che scorrono sulle guance, tonde e mute, trasparenti. Gli do un quaderno che tenevo di scorta, gli dico che può tenerselo. Gli trovo una matita e una gomma, gli faccio prestare la penna rossa cancellabile. Niente da fare: Oscar piange.
È entrato in classe con il magone, si capisce, ha dimenticato a casa lo zaino. Come varca la soglia, l'albanese e Tramella cominciano a prenderlo in mezzo che di più non si può.
- Coglione – gli dice Tramella – Si può sapere cos'hai nel cervello? -
- Ma le mutande, almeno, le hai messe? – incalza l'albanese – Ce le hai sotto i pantaloni? Te le sei ricordate, le mutande? Il resto della classe ride o si fa gli affari suoi.
Sbatto fuori i due molestatori dicendo alla bidella di guardarli a vista, che quelli sono capaci di andare a fare un giro in piazza.
Torno da Oscar, gli do un fazzoletto, gli chiedo di smetterla, gli dico persino che lo zaino, oggi, non serve. Niente da fare. Le lacrime continuano a scorrere, inarrestabili. Una cosa angosciante, dal momento che il bambino non emette alcun suono, alcun rumore. Sono gli occhi che piangono, e basta. Lui vorrebbe non essere lì, questo l'ho capito.
A quel punto bussano, e la porta si apre senza darmi il tempo di dire “avanti”.
È il fratello metallaro, e chi se no? Il salvatore della patria porta sulla spalla uno zaino rosso e blu. Ha addosso il solito giubbotto di pelle, i capelli infilati nella giacca, il casco sulla testa, i pantaloni bagnati già a quell'ora del mattino. La faccia di Oscar aperta in un sorriso d'occhi azzurri brillanti mi scalda il cuore, cambiando all'improvviso la prospettiva dell'intera giornata. Il salvatore lascia lo zaino accanto a Oscar, gli scompiglia i capelli con la mano, fa un sorriso, si gira ed esce dall'aula. Nessuno ride più, o ha più voglia di sfottere. Nessuno di loro, è evidente, ha un fratello in grado di salvarli, non con quel tempismo noncurante, non con quel sorriso da eroe. Un eroe che ha aggiustato lo scooter, penso, e che nemmeno oggi arriverà puntuale a scuola. Ma che importa questo, se è in grado di salvarti la vita?
|
|
Biblioteca
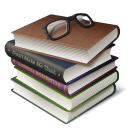
|
Acquista

|
Preferenze

|
Recensione
|
Contatto

|
|
|
|
|