
|
 Writer Officina Blog
Writer Officina Blog 
|
  Manuale di pubblicazione Amazon KDP. Sempre più autori
emergenti decidono di pubblicarse il proprio libro in Self su Amazon KDP,
ma spesso vengono intimoriti dalle possibili complicazioni tecniche. Questo
articolo offre una spiegazione semplice e dettagliata delle procedure da
seguire e permette il download di alcun file di esempio, sia per il testo
già formattato che per la copertina.
Manuale di pubblicazione Amazon KDP. Sempre più autori
emergenti decidono di pubblicarse il proprio libro in Self su Amazon KDP,
ma spesso vengono intimoriti dalle possibili complicazioni tecniche. Questo
articolo offre una spiegazione semplice e dettagliata delle procedure da
seguire e permette il download di alcun file di esempio, sia per il testo
già formattato che per la copertina. |
  Self Publishing. In passato è stato il sogno nascosto
di ogni autore che, allo stesso tempo, lo considerava un ripiego. Se da
un lato poteva essere finalmente la soluzione ai propri sogni artistici,
dall'altro aveva il retrogusto di un accomodamento fatto in casa, un piacere
derivante da una sorta di onanismo disperato, atto a certificare la proprie
capacità senza la necessità di un partner, identificato nella
figura di un Editore.
Self Publishing. In passato è stato il sogno nascosto
di ogni autore che, allo stesso tempo, lo considerava un ripiego. Se da
un lato poteva essere finalmente la soluzione ai propri sogni artistici,
dall'altro aveva il retrogusto di un accomodamento fatto in casa, un piacere
derivante da una sorta di onanismo disperato, atto a certificare la proprie
capacità senza la necessità di un partner, identificato nella
figura di un Editore. |
  Scrittori si nasce. Siamo operai della parola, oratori,
arringatori di folle, tribuni dalla parlantina sciolta, con impresso nel
DNA il dono della chiacchiera e la capacità di assumere le vesti
di ignoti raccontastorie, sbucati misteriosamente dalla foresta. Siamo figli
della dialettica, fratelli dell'ignoto, noi siamo gli agricoltori delle
favole antiche e seminiamo di sogni l'altopiano della fantasia.
Scrittori si nasce. Siamo operai della parola, oratori,
arringatori di folle, tribuni dalla parlantina sciolta, con impresso nel
DNA il dono della chiacchiera e la capacità di assumere le vesti
di ignoti raccontastorie, sbucati misteriosamente dalla foresta. Siamo figli
della dialettica, fratelli dell'ignoto, noi siamo gli agricoltori delle
favole antiche e seminiamo di sogni l'altopiano della fantasia. |
|
|
|
|
|
|
Conc. Letterario
|
|
|
|
Magazine
|
|
|
|
Blog Autori
|
|
|
|
Biblioteca New
|
|
|
|
Biblioteca Gen.
|
|
|
|
Biblioteca Top
|
|
|
|
Autori
|
|
|
|
Recensioni
|
|
|
|
Inser. Estratti
|
|
|
|
@ contatti
|
|
|
Policy Privacy
|
|
 Il Normanno
Il Normanno 
|

 Era un uomo molto intelligente ed era dotato di un'onestà mentale che riusciva a tradursi in ogni suo gesto, ma non per questo l'esercizio delle sue funzioni ne risultava impedito o limitato; la sua autorità invece in questo modo veniva natural-mente amplificata, riuscendo a procurargli la sti-ma di tutti. Non si può dire che fosse un osser-vante in fatto di religione, pur attenendosi a quel-lo che da un signore cristiano ci si aspettava. Ap-prezzava, infatti, il cibo e non disdegnava il buon vino. Riguardo all'amore ce ne occuperemo più avanti. D'altra parte, non aveva una natura violen-ta ma decisa e non aveva quasi mai bisogno di ri-correre alle maniere forti. Una vita spartana, in ac-cordo con i tempi, regnava nel Castello, che co-munque poteva, senza ombra di dubbio, essere considerato una residenza lussuosa per l'epoca e per il luogo in cui sorgeva. La sua posizione, a guardia del valico, aveva imposto di privilegiare le opere di difesa, anziché gli abbellimenti struttura-li, sia all'esterno che all'interno della costruzione. Il maniero aveva un corpo abbastanza tozzo, in cui le alte pareti di pietra grigia terminavano con-tro torrioni ciechi e alti venti metri, mentre lo stretto portale si apriva su un imponente ponte levatoio. Non era proprio una residenza che ispi-rasse pace e tranquillità.
Era un uomo molto intelligente ed era dotato di un'onestà mentale che riusciva a tradursi in ogni suo gesto, ma non per questo l'esercizio delle sue funzioni ne risultava impedito o limitato; la sua autorità invece in questo modo veniva natural-mente amplificata, riuscendo a procurargli la sti-ma di tutti. Non si può dire che fosse un osser-vante in fatto di religione, pur attenendosi a quel-lo che da un signore cristiano ci si aspettava. Ap-prezzava, infatti, il cibo e non disdegnava il buon vino. Riguardo all'amore ce ne occuperemo più avanti. D'altra parte, non aveva una natura violen-ta ma decisa e non aveva quasi mai bisogno di ri-correre alle maniere forti. Una vita spartana, in ac-cordo con i tempi, regnava nel Castello, che co-munque poteva, senza ombra di dubbio, essere considerato una residenza lussuosa per l'epoca e per il luogo in cui sorgeva. La sua posizione, a guardia del valico, aveva imposto di privilegiare le opere di difesa, anziché gli abbellimenti struttura-li, sia all'esterno che all'interno della costruzione. Il maniero aveva un corpo abbastanza tozzo, in cui le alte pareti di pietra grigia terminavano con-tro torrioni ciechi e alti venti metri, mentre lo stretto portale si apriva su un imponente ponte levatoio. Non era proprio una residenza che ispi-rasse pace e tranquillità.
Nel Castello vivevano diverse famiglie di servi, gli uomini d'arme e gli uomini fidati del signore. Intorno, quasi a ridosso del maniero, sorgeva un borgo di case arroccate sulla collina, difeso da un secondo ordine di mura che nel tempo avevano cambiato posizione e aspetto, sviluppandosi dove la natura non forniva protezioni.
La mattina il sole sorgeva proprio di fronte all'ingresso e sarebbe bastato aprire gli enormi battenti di legno e ferro e calare il ponte levatoio per far entrare la luce e risvegliare il seme di uno stimolo vitale in quel luogo così tetro e oscuro. I terrazzi, costantemente sotto guardia, permette-vano di ammirare tutta la verde valle che si apriva morbida fino al fiume, circondata da montagne imponenti, e di penetrare con lo sguardo le terre del feudo, le ricche e floride contrade dell'Irpinia fino alla Valle dell'Irno. Se Roberto di San Severi-no non lo avesse investito quel giorno del titolo di signore, affidandogli in suffeudo le sue terre, lui sarebbe ancora considerato un usurpatore, un pri-gioniero a casa sua.
Tutto ebbe però inizio molto tempo prima. Gu-glielmo era nato nel 1078 dal normanno Riccardo, signore del feudo che aveva ereditato dal padre Raone ma, per diventare potente, come e più del padre, aveva dovuto lottare e combattere e ancora non era tranquillo.
La dominazione longobarda, che aveva possedu-to in precedenza i territori del regno normanno, si era consolidata in quelle terre già da cinquecento anni, per cui non era stato facile per i “vichinghi” prendere il loro posto e, comunque, il passaggio non era avvenuto in modo né omogeneo né totale. Si può dire che i longobardi fossero stati i primi a costruire villaggi e a popolare queste zone, dopo i tentativi romani di stabilire degli insediamenti, le incursioni ostrogote e la dominazione bizantina. Ma la prima cosa che si era affermata in quelle verdi valli era il loro potere. Su cosa e su chi aveva sempre avuto poca importanza. La terra a quei tempi non era un bene indisponibile, ma comun-que rappresentava un possesso. Il padrone della terra era, contemporaneamente, padrone di tutto quello che vi viveva, compresi gli uomini e le donne che l'abitavano, ed esercitava una certa au-torità anche sui passanti, ai quali veniva chiesto di pagare il diritto di attraversamento. E questo av-veniva soprattutto in corrispondenza dei passaggi obbligati, come era quello della Terra Montis For-tis. Era avvenuto in passato e avveniva ancora in tempo di pace, mentre in guerra o durante le con-tese tra feudatari tutto era permesso, a discapito dei malcapitati che, per qualsiasi motivo, si tro-vassero ad attraversare quelle terre.
Guglielmo aveva trascorso parte della sua infan-zia al Castello: era andato a cacciare i cinghiali con il padre e con lui li aveva arrostiti al fuoco vivace di enormi braci, allestite per allietare i bei tempi della vita tranquilla e a lui, bambino, sembrava di vivere in un luogo meraviglioso. Quando Riccar-do, accompagnato dai suoi uomini, completamen-te armato, usciva dal Castello per la ricognizione delle terre del feudo, operazione che lo avrebbe tenuto fuori alcuni giorni, Guglielmo ne era orgo-glioso e avrebbe voluto seguirlo, mentre la mam-ma lo scrutava cercando di cogliere in lui lo spirito del comando. Quando si era allontanato per la guerra, aveva visto il padre preoccupato, ma fiero e la madre aveva alzato la sua mano bianca e pic-cola in un gesto di benedizione e di saluto. Passa-rono sette anni e successero tante cose.
Idelgarda era longobarda e, nonostante il loro matrimonio fosse stato, come succedeva spesso a quei tempi tra i nobili, combinato per motivi di pace, Guglielmo era convinto che i genitori si amassero davvero, anche se non li aveva mai sor-presi a scambiarsi affettuosità. Lo aveva sempre letto, però, nei loro occhi e, da fanciullo, si era cul-lato in questa certezza, che gli dava la sensazione che nulla avrebbe potuto rompere l'incantesimo. Il padre, secondo l'usanza normanna, il giorno del loro matrimonio aveva donato a Idelgarda uno scudo ed un cavallo da combattimento, segno che la loro unione doveva essere forte e totale. Avreb-bero condiviso tutto, anche la guerra. Con Gu-glielmo la madre era più affettuosa di quanto, a quei tempi, fosse in uso nell'educazione dei figli ma, soprattutto, tra loro c'era grande comprensio-ne. La sorellina, Gratilla, era un essere curioso, piccolo e grazioso, che correva ovunque senza tregua, fermandosi poi d'improvviso per racco-gliere un fiore, un grillo, per sbirciare in un'armatura o cercare di sollevare il pesante spa-done del padre. L'opposto di Guglielmo che, fin da piccolo, poteva essere considerato un bimbetto tranquillo e riflessivo, ordinato e qualche volta un po' pigro.
Purtroppo Gratilla non superò la prima infanzia, portata via da un morbo che non si poté curare. Da allora la mamma non fu più la stessa e si con-centrò su quel figlio per farne il padrone di quelle terre. Il padre, tornato dalla guerra, era triste e la notte rimaneva insonne sugli spalti a guardare il cielo, a parlare forse con il suo piccolo tesoro. Nel frattempo Guglielmo cresceva e si irrobustiva nel-le terre lontane del Nord, dove la nonna lo aveva portato una volta raggiunta l'adolescenza perché apprendesse gli antichi saperi e divenisse un guerriero.
I/XXVII
Il Morbo
Guardava lontano, l'aria era fredda. La sua men-te viaggiava oltre quella valle, tornava a percorrere quella strada che lo aveva portato fin lì, ma questa volta la percorreva al contrario. Era come fuggire da un mondo che non riconosceva. Una terra abi-tata da uomini strani, diversi, che non avevano la minima idea di cosa ci fosse al di là di quei monti. Era triste nel cuore, come un animale in gabbia, ma aveva scelto la sua strada e l'avrebbe percorsa a testa alta, ringraziando il destino che gli aveva sorriso. Era un bell'uomo, aveva i capelli del colo-re del fuoco, volitivo, sicuro di sé, deciso. E forte. Incuteva rispetto, ma anche timore, in coloro che si recavano ogni giorno da lui per rendergli omaggio o per avanzare qualche supplica. Erano uomini e donne semplici, miseri e animati solo da un guizzo furbo, che rivelava quell'istinto che aveva permesso loro di superare la fame e la mor-te. Forti nell'affrontare le perdite dei figli, non tut-ti destinati a diventare grandi, portati via da una sorte che non guardava in faccia nessuno, le don-ne sembravano sempre celare nel loro cuore qual-che segreto. Poveri di ogni istruzione, i suoi sud-diti non sembravano avere una vera consapevo-lezza della propria persona separata dal padrone e vivevano in una rassegnazione tramandata più che compresa. Lui sapeva queste cose, ma era sta-to formato al comando. Era un conquistatore. Era il Normanno!
Quella mattina era silenzio tutt'intorno. Non si sentiva l'usuale tramestio che dalle prime ore del giorno animava le stalle, mentre i servi prepara-vano le bestie per la giornata. Sembrava che tutto fosse ancora immerso nel sonno di quella notte, che calava sempre buia e inesorabile sulle mura del Castello. Era l'alba ma tutto quel silenzio gli sembrò troppo. La sua anima sola sembrava esse-re in subbuglio, mentre meditava sull'incontro che lo aspettava con Roberto di San Severino, il nor-manno feudatario di Montoro e di tutto il feudo di cui facevano parte le sue terre. Un uomo nobile, potente, istruito, ricco, valoroso e rispettato da tutti.
Si voltò risoluto e affrontò la giornata, senza riu-scire a spiegarsi perché ancora regnava nel Castel-lo quel silenzio.
Mentre imboccava la stretta scaletta di legno di quercia che portava sul camminamento interno delle mura, vide andargli incontro il fidato scudie-ro, un ragazzotto che gli stava sempre dietro e fa-ceva di tutto per mostrare la sua riconoscenza per averlo preso a servizio presso di lui. In verità il ra-gazzo si era dimostrato in più di una occasione anche piuttosto sveglio di mente.
- Cosa succede, Berto? - chiese secco ma preoccu-pato.
- Oh, signore, sembra che stamattina nessuno riesca a buttarsi giù dal letto. Sono tutti malati! - rispose il servo allarmato. Lui, il Carbone, aveva affrontato eserciti in battaglia, aveva sfidato fiere, freddo, fame ed aveva attraversato le montagne ma, in quel momento, stentò a procedere.
- Il morbo? -
Abbandonò in un attimo tutti i pensieri che lo avevano trattenuto sulla torre e fu giù, negli ap-partamenti. Effettivamente l'atmosfera era insoli-ta. La cuoca Menina, avanti negli anni e nei chili, si aggirava, sostenendosi al muro, mezza china, quasi a cercare la forza ed il vigore con cui tutte le mattine animava il lavoro delle cucine, già dal sorgere dell'alba. Un inchino faticoso, il viso mor-tificato per le condizioni in cui era costretta a pre-sentarsi di fronte al padrone.
- Che succede, Menina? -
- Non lo so mio signore ma sono senza forze e la fronte brucia. Non sono riuscita a smuovere le aiutanti di cucina, appaiono rosse come il fuoco con delle macchie sulla pelle e prostrate nel fisico. Così gli stallieri, i servi e tutti coloro che abitano il Castello. Tutti, tranne gli uomini d'arme. -
Nella sua stanza ora il Normanno poneva mano alla penna, con fare spiccio e disinvolto di chi ha una certa pratica della lingua e della diplomazia. Il primo messaggio era per i monaci dell'eremo di Monte Virgilio, che erano gli unici a conoscere i segreti della natura, delle piante medicinali e del corpo umano. Che mandassero subito qualcuno a visitare gli infermi, per capire quale contagio ave-va colpito la gente del Castello. Alla mente gli tor-navano le parole della serva: Tutti, tranne gli uo-mini d'arme.
Un altro messaggio, questa volta per il signore di San Severino. Non era possibile fargli visita con un possibile contagio in atto. Bisognava essere prudenti ma mostrarsi sinceri. Poche parole ma efficaci: Devo chiederti, mio signore, di rinviare l'incontro, a causa di una insorta malattia che po-trebbe minacciare il Castello e che per il momento richiede la mia presenza qui. Firmato: Guglielmo il Carbone.
Un ordine a tutti: - Nessun contatto con gli am-malati, fino a quando non si conosca il motivo dell'indisposizione. - I messi partirono veloci.
La paura della peste che aveva colpito nel 767 Napoli e le province interne, decimando la popo-lazione che solo da poco aveva raggiunto i mag-giori livelli storici, nonostante fosse una cosa lon-tana, aveva lasciato il suo ricordo nelle cronache che Guglielmo aveva letto presso l'Abazia di Car-bone in Lucania. Pare che da allora non si fossero più verificate epidemie di peste, ma lo stato dei malati lasciava temere che qualcosa del genere po-tesse essersi sviluppata al Castello.
- La questione va risolta subito - , esordì freddo, dando però segni di una certa inquietudine, rivol-to a Berto che non lo abbandonava mai. Passò tut-ta la mattina a verificare di persona lo stato del Castello, a contare i sani, a dispensare ordini per limitare i danni di un eventuale contagio. Quindi passò a controllare gli animali nelle stalle e verifi-cò lo stato delle vettovaglie. Da perfetto padrone di casa esigeva di essere messo al corrente di tutto ciò che accadeva nel palazzo e ne era informato puntualmente dai suoi servi.
Amava, in fondo, quel luogo. Ora lo sentiva suo più di quando gli fu consegnato dal padre Riccar-do, che lo aveva ricevuto da suo padre Raone, il quale lo aveva avuto in dono dal longobardo con-te di Avellino. Quelli sì che erano stati tempi glo-riosi per il suo popolo, dedicato completamente alla guerra e alla conquista. C'era stato un tentati-vo di appropriarsi del Castello, nel 1108, tre anni prima, da parte di soldataglie longobarde che an-cora si aggiravano nell'Italia meridionale. Con quella sortita, gli aggressori intendevano prendere il controllo della signoria, ottenendo anche ricono-scimento della Chiesa. Per mantenere il dominio delle sue terre, che gli spettavano di diritto, Gu-glielmo aveva dovuto combattere e cacciare gli in-vasori, ma era appena giunto dal Nord per pren-dere il posto del padre e non fu facile per lui ri-portare tutto all'ordine sotto la sua nobile casata. Per tutelare i propri domini, che si estendevano ben oltre ciò che si poteva ammirare dal valico su cui era posto il Castello di Monte Forte, aveva do-vuto lavorare molto ad intessere buoni rapporti con Roberto di San Severino, che nel 1109 lo aveva infine investito, nella curia del suo castello di Montoro, del titolo di signore del feudo di Monte Forte, Mercogliano e parte dell'avellinese, che comprendeva possedimenti ad Atripalda, Forino, Sarno, San Severino, Montoro e Baiano. In quella occasione Guglielmo aveva offerto un anello d'oro al proprio signore in segno di sottomissione, di-chiarandosi suo uomo ligio. Roberto, secondo un rituale consolidato, alla presenza di suo padre Ruggero, aveva pronunciato la formula di affido del feudo: - Per unum anulum aureum omne et totum illiud quod sopra dictus dominus senior Rogerius geni-tor meus antecessoribus tuis et tibi donaverat. -
Al Castello furono riorganizzate presto tutte le attività quotidiane attingendo al personale ancora sano e agli uomini d'arme, che si occuparono del riordino, dell'approvvigionamento dell'acqua dai pozzi, della mungitura delle mucche, della raccol-ta delle uova, della cura degli animali e finanche della cucina, sotto i comandi dell'energica Menina, che sembrava aver recuperato parte delle sue for-ze. I malati non erano in condizione di nutrirsi e, nel frattempo, veniva loro somministrata una ti-sana purificante, di cui rifornivano il Castello i preziosi santi monaci del Monte Virgilio.
Austeri e saggi, questi uomini di fede si erano in-sediati sul monte al seguito di un eremita che aveva fama di essere un santo. Era buono, sì, ma molti lo temevano, soprattutto gli abitanti diffi-denti di quelle terre, intrisi di una religiosità che non registrava confini ben marcati tra l'ostentazione della fede cristiana e il paganesimo dei loro avi, adoratori delle divinità dei boschi e delle acque di cui era piena la verdissima terra dei Sanniti.
Il santo viveva in una grotta e viaggiava a piedi nudi, ma arrivava dove doveva, sempre.
Un giorno era giunto al Castello ed aveva bussa-to al portone, aveva usato l'enorme battaglio di bronzo solo una volta. Ma le guardie lo avevano visto arrivare da lontano, scambiandolo per un pellegrino, colpite dal suo incedere sorprenden-temente sollecito, visto che non sembrava portare calzari. Era stato condotto da Guglielmo, che ave-va sentito parlare di lui e che, tra sé, fremeva dalla curiosità di guardarlo negli occhi. Voleva cono-scerlo e aveva mandato messaggi di invito, che fi-no allora non erano stati ascoltati.
Era un pomeriggio di primavera quello che aveva portato il monaco al Castello, era stato un momen-to importante per il Normanno, che da allora non era stato più lo stesso.
Il monte su cui fra' Guglielmo aveva stabilito il suo romitaggio era alto 1481 metri, ma il luogo che aveva scelto per adorare in solitudine Dio si tro-vava su una spianata a 1270 metri di altitudine, proprio nel punto da dove, appena vi era giunto, si erano alzate in volo delle colombe bianche che avevano rivelato a Guglielmo la presenza di una sorgente. Lì l'eremita aveva posato il suo leggero fardello. E così da allora il luogo era stato battez-zato “Ubi acqua columbi dicitur”.
Ma, prima di divenire meta dei seguaci di Cristo, in epoca pagana, quel monte aveva ospitato un importante tempio dedicato alla dea Cibéle, con-siderata dai suoi seguaci la Grande Madre che so-vrintendeva alla fertilità della terra, il cui culto era giunto a Roma dalla Grecia. Questa divinità ri-chiamava gli antichi abitanti della Campania a compiere le rituali Coribande. Le danze sacre, ac-compagnate da tamburelli e dal fragore di timpa-ni, cembali, flauti e nacchere, in alcune occasioni si trasformavano in veri e propri riti orgiastici.
Pellegrino di Cibéle fu anche il poeta Virgilio che da quel luogo pare fosse stato ispirato per la ste-sura delle Ecloghe.
Virgilio aveva coltivato in un giardino sul monte, poi chiamato Orto di Virgilio, alcune piante magi-che fatte giungere dall'Oriente, che utilizzava per onorare la dea. Di fatto quello che aveva preso il nome di Monte Partenio, in onore della dea vergi-ne (parthenos in greco) Cibéle, fu detto da allora Monte Virgilio.
In età cristiana diversi santi avevano raggiunto questo luogo: per primi San Felice e San Massimo, vescovi di Nola, recativisi per soccorrere e conso-lare i cristiani lì rifugiatisi a causa delle persecu-zioni; poi San Modestino e i suoi compagni, giunti da Antiochia e finanche San Vitaliano, vescovo di Capua, che vi costruì anche una chiesetta.
Fra' Guglielmo era nato da una nobile famiglia di Vercelli nel 1085 e aveva manifestato precocemen-te la vocazione di pellegrino. Con schiavina, cap-pello a larghe falde e piedi nudi, avendo rinuncia-to agli agi familiari, a 14 anni si diresse a Santiago de Compostela per compiere il suo primo pelle-grinaggio che durò cinque anni, in cui mangiò po-co e dormì meno. Temprò così il suo fisico per as-soggettarlo allo spirito. Poi giunse in meridione per recarsi in Terra Santa. Fu accolto a Melfi, capi-tale delle province meridionali normanne, da un tale Ruggiero, presso cui approfondì la lettura del-la Bibbia. Iniziò a fare i primi miracoli e, per allon-tanarsi dalla folla che iniziava a cercarlo dopo la guarigione di un cieco sul Monte Serico, dove si era stabilito, riprese il suo cammino per la Terra Santa. Sulla strada di Oria, nella terra di Taranto, fu aggredito da alcuni ladri che, non trovandogli addosso niente di valore, lo bastonarono. Gu-glielmo si rivolse a Giovanni da Matera per riceve-re consiglio e il fondatore del monastero di Ginosa lo dissuase dal continuare il suo viaggio. Così Gu-glielmo capì che Dio aveva scelto un'altra strada per lui e cercò un luogo per stabilirvisi da eremita. Lo trovò prima a Sasso Barisano, a Matera. Poi passò per il Gargano, l'Alta Irpinia e Atripalda, da dove scorse il Monte Partenio. Andò quindi a Sa-lerno dove acquistò una corazza di ferro che in-dossò come cilicio e tornò sui suoi passi.
All'arrivo sul monte dovette dividere quel luogo con animali feroci che però, presto e miracolosa-mente, si sottomisero all'eremita divenendo suoi aiutanti, in particolare un lupo, che lo seguiva sempre. Pian piano anche altri giovani di fede si aggregarono a lui costruendo delle capanne pres-so la sorgente e dando vita a una piccola comuni-tà. Il frate spiegò loro le proprietà di quelle piante che la tradizione voleva magiche ma che erano mediche e che servivano per curare gli ammalati e alleviarne le sofferenze. Da allora si era sparsa la voce non solo della santità dell'uomo, ma anche della bravura di quelli che venivano chiamati mo-naci medici, cui anche i poveri potevano rivolger-si. La regola di Guglielmo imponeva ai suoi con-fratelli, infatti, il lavoro, la preghiera e la carità verso i poveri.
Il Carbone, invece, aveva dentro di sé tutta la tradizione delle sue terre del Nord, tutte le leg-gende che aveva sentito raccontare dalla nonna, con cui da ragazzo era tornato alle origini. Lei gli aveva narrato di Odino, delle divinità dei boschi cui aveva giurato fedeltà; gli aveva fatto bere il nettare della terra, gli aveva insegnato la magia della natura. Gli aveva cantato l'Havamàr, con tut-te le sentenze dettate da Odino, perché assimilas-se le regole della vita quotidiana di un buon nor-manno. Ma, soprattutto, gli aveva inculcato, da saggia donna del Nord, il rispetto per tutto ciò che lo circondava. Dagli abitanti dei boschi agli ele-menti della natura, agli astri, all'acqua, agli uomi-ni. Gli aveva trasmesso, inoltre, il culto dell'amicizia e dell'onore, come non avrebbe sapu-to fare suo padre in persona. Per farlo aveva volu-to riportare Guglielmo nelle terre del Nord e lì, nei boschi della terra dei suoi padri, gli aveva parlato e gli aveva mostrato molte cose. Lì era diventato un uomo.
In quel pomeriggio di primavera si sentiva iner-me davanti al monaco che gli si era presentato di-nanzi senza preavviso ma che aveva tanto atteso. Nessuna parola, semplici gesti, garbati ma decisi, avevano fatto ritrovare entrambi seduti all'aperto, presso la fontana che il Normanno aveva fatto eri-gere vicino alla sorgente che nasceva all'interno delle mura. Si guardavano negli occhi. Scuri quelli del santo, dove non era visibile l'iride, invasa dalla pupilla ampia, disarmante come quella di un bim-bo, che tutto chiede ma tutto già possiede. Verdi, di un verde che vira continuamente nel nocciola, quelli del Normanno, pronto ad accogliere qual-siasi richiesta dell'ospite. Non c'era stata nessuna richiesta, solo un lungo sguardo, un invito a re-carsi con lui a scoprire i segreti del Monte, dove aveva trovato il rifugio di Dio. Un invito, o qualcosa di più? si era chiesto Guglielmo, ma aveva pro-messo e sarebbe andato, un giorno.
Oggi, però, aveva bisogno del santo e dei suoi confratelli, della loro scienza e delle erbe di cui so-lo loro conoscevano le doti farmacologiche e che solo loro sapevano trovare.
Qualche ora dopo, quando Guglielmo aveva ter-minato l'ispezione del Castello e aveva diffuso le disposizioni del caso, erano giunti i messi con un monaco inviato dall'eremita, giovane, sveglio e munito di tutta l'attrezzatura che doveva servirgli a fronteggiare l'emergenza. Un rapido saluto, pri-vo di cerimoniali, portò entrambi nelle stanze dei morbosi. Un'accurata visita del frate medico e la diagnosi era pronta: avvelenamento.
- Ma da cosa? - volle sapere il signore, tirando un sospiro di sollievo. - Di che si tratta? -
Il frate invitò con discrezione il nobile a seguirlo fuori, dove poté parlare senza che gli ammalati potessero sentire.
- Signore, so che voi siete persona saggia, so che fra' Guglielmo ha molta stima di voi, so che posso parlare e che mi risponderete con sincerità. - E continuò: - Vedete, l'uomo è una canna sbattuta dal vento ed è vittima delle passioni, se non gui-dato e aiutato dalla forza dello Spirito Santo e dal-la fede. Ma molte persone qualche volta vanno ol-tre e... Insomma signore, è stata un'erba. Una bacca, per la precisione, chiamata Belladonna, che crea allucinazione e che solitamente viene assunta durante i riti pagani in cui i fedeli si abbandonano all'adorazione di demoni o chissà a cos'altro, ven-dendo la propria anima. Ne avranno abusato. -
- La propria anima... - , soggiunse Guglielmo. - Ma se la maggior parte di loro non sa neanche di possedere un'anima. Come è possibile che inten-dessero venderla? Sotto i miei occhi poi? Hanno pensato di fare riti e stringere patti con un altro signore, divinità o spirito dei boschi, contravve-nendo ai miei ordini? -
Stava alzando la voce oramai e non si era accorto che la sua tensione stava per esplodere, quando si affacciò una bimba da un angolo. Aveva sentito il suo signore urlare e si era affacciata, preoccupata ma non spaventata. A quel punto lui si calmò, chiese al frate un rimedio medicinale e gli assicu-rò, ringraziandolo con reverenza, che avrebbe ri-solto la cosa. Gli chiese poi di riferire all'eremita che poteva fidarsi di lui.
Non aveva mai usato questo tono. In fondo lui era il signore. Non doveva scusarsi con nessuno. Eppure per quei frati nutriva una sorta di sogge-zione e non si spiegava bene il motivo di questo sentimento.
Il rimedio ora lo aveva e, anche se sapeva che avrebbe recato una sofferenza in più per i deboli allettati, avrebbe però risolto la malattia in breve. Doveva essere somministrato a tutti i malati un miscuglio di erbe amare macerate, alcool, latte di capra e fiele di capretto. Dovevano purificarsi, a costo di vomitare l'anima, quell'anima malata più del fisico. Così fu fatto e tutti furono presto guari-ti, anche i più piccoli, con cui si usò un po' più di delicatezza.
La punizione non si fece attendere. Non appena tutti si furono ristabiliti, iniziò l'interrogatorio. Prima le vecchie “megere”, a cui il signore guar-dava con particolare sospetto, da sempre custodi dei segreti della magia. Poi si passò alle giovani e, infine, ai bambini che non furono risparmiati dalle domande riguardo a ciò che veniva fatto dentro e fuori dal Castello senza il permesso del padrone. Bisognava assolutamente stroncare al nascere ogni forma di autonomia e di ribellione, che avrebbe minato la sicurezza del luogo, delle persone e an-che delle loro anime. |
|
Biblioteca
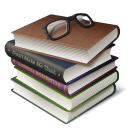
|
Acquista

|
Preferenze

|
Recensione
|
Contatto

|
|
|
|
|