
|
 Writer Officina Blog
Writer Officina Blog 
|
  Manuale di pubblicazione Amazon KDP. Sempre più autori
emergenti decidono di pubblicarse il proprio libro in Self su Amazon KDP,
ma spesso vengono intimoriti dalle possibili complicazioni tecniche. Questo
articolo offre una spiegazione semplice e dettagliata delle procedure da
seguire e permette il download di alcun file di esempio, sia per il testo
già formattato che per la copertina.
Manuale di pubblicazione Amazon KDP. Sempre più autori
emergenti decidono di pubblicarse il proprio libro in Self su Amazon KDP,
ma spesso vengono intimoriti dalle possibili complicazioni tecniche. Questo
articolo offre una spiegazione semplice e dettagliata delle procedure da
seguire e permette il download di alcun file di esempio, sia per il testo
già formattato che per la copertina. |
  Self Publishing. In passato è stato il sogno nascosto
di ogni autore che, allo stesso tempo, lo considerava un ripiego. Se da
un lato poteva essere finalmente la soluzione ai propri sogni artistici,
dall'altro aveva il retrogusto di un accomodamento fatto in casa, un piacere
derivante da una sorta di onanismo disperato, atto a certificare la proprie
capacità senza la necessità di un partner, identificato nella
figura di un Editore.
Self Publishing. In passato è stato il sogno nascosto
di ogni autore che, allo stesso tempo, lo considerava un ripiego. Se da
un lato poteva essere finalmente la soluzione ai propri sogni artistici,
dall'altro aveva il retrogusto di un accomodamento fatto in casa, un piacere
derivante da una sorta di onanismo disperato, atto a certificare la proprie
capacità senza la necessità di un partner, identificato nella
figura di un Editore. |
  Scrittori si nasce. Siamo operai della parola, oratori,
arringatori di folle, tribuni dalla parlantina sciolta, con impresso nel
DNA il dono della chiacchiera e la capacità di assumere le vesti
di ignoti raccontastorie, sbucati misteriosamente dalla foresta. Siamo figli
della dialettica, fratelli dell'ignoto, noi siamo gli agricoltori delle
favole antiche e seminiamo di sogni l'altopiano della fantasia.
Scrittori si nasce. Siamo operai della parola, oratori,
arringatori di folle, tribuni dalla parlantina sciolta, con impresso nel
DNA il dono della chiacchiera e la capacità di assumere le vesti
di ignoti raccontastorie, sbucati misteriosamente dalla foresta. Siamo figli
della dialettica, fratelli dell'ignoto, noi siamo gli agricoltori delle
favole antiche e seminiamo di sogni l'altopiano della fantasia. |
|
|
|
|
|
|
Conc. Letterario
|
|
|
|
Magazine
|
|
|
|
Blog Autori
|
|
|
|
Biblioteca New
|
|
|
|
Biblioteca Gen.
|
|
|
|
Biblioteca Top
|
|
|
|
Autori
|
|
|
|
Recensioni
|
|
|
|
Inser. Estratti
|
|
|
|
@ contatti
|
|
|
Policy Privacy
|
|
 L'angelo incompiuto
L'angelo incompiuto 
|

 - In Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. -
- In Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. -
- Amen. -
- Gratia Domini nostri Iesu Christi, et caritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis. -
- Et cum Spirito tuo - risposero in coro i fedeli nella piccola chiesa di Lucignano, una costruzione che risaliva a poche decine di anni prima, con l'unico vanto di avere uno dei campanili più alti della zona di Montespertoli.
Don Savino, con le mani alzate in segno di pace, era rivolto verso coloro che affollavano la cappella disadorna: le donne, con i loro abiti di lana dura e una pezzola sul capo in segno di rispetto per il luogo, e gli uomini, con addosso camicie pulite ma lise, sotto gilet scuri o giacche sformate, come il paio di pantaloni buoni che indossavano solo la domenica.
Un Cristo crocifisso su una tavola di legno sopra l'altare era l'unico segno che ricordava a tutti la sacralità del posto; in alto, su entrambi i lati lunghi, piccole finestre di forma rotonda decorate con vetri colorati raffiguravano in maniera rozza alcuni santi; la luce filtrava attraverso quella specie di mosaici e tingeva l'aria di colori che cambiavano a seconda dell'inclinazione e dell'intensità del sole: in quella domenica mattina di metà luglio del 1944, l'azzurro dei cieli che circondavano i santi irradiava una luce spirituale sui volti accaldati dei parrocchiani.
Leda indossava un vestito nero e dritto, che non lasciava intravedere le forme abbozzate del suo giovane corpo; i capelli neri toccavano appena le spalle ed erano coperti dal velo bianco ricamato che sua madre le aveva cucito per la prima comunione. Teneva le mani giunte vicino alla bocca. Di tanto in tanto si copriva il viso, con le dita delle mani sugli occhi, e poi si girava di scatto guardando alla sua destra, verso l'altra fila di panche, dove puntualmente incrociava lo sguardo di Guglielmo; lui le sorrideva, e di rimando le faceva delle smorfie alle quali lei non sapeva resistere, tanto che doveva impegnarsi a trattenere il riso che saliva su.
Guglielmo, biondo e dal viso effemminato, era cresciuto con Leda. Avevano giocato insieme fin da quando erano piccoli e i loro corpi erano andati avanti a sbalzi, come succede tra un ragazzo e una ragazza, ma poi la mente di Leda si era fermata, durante il primo anno di scuola, e lei si era ritrovata come sospesa, tra un corpo che cresceva e un animo che era rimasto puro, senza pensieri oscurati da sentimenti che appartengono al mondo degli adulti, incapace di giudicare le cose e le persone con lo sguardo intorbidito dall'età.
Quel giorno, la baronessa Clelia non badava alle occhiate che suo figlio e Leda si scambiavano di continuo. Era inginocchiata al centro della prima panca, quella davanti all'altare, riservata al barone e alla sua famiglia. Il corpo, ancora giovane e snello, era in una posa rigida, altera, mentre il suo viso ovale poggiava sulle dita delle mani giunte. Gli occhi celesti fissavano irrequieti il crocifisso, quasi si aspettasse che da un momento all'altro potesse parlarle: sapeva di aver peccato, anche se non provava vergogna o rimorso. Le sarebbero bastate tre parole, quelle che di solito il prete pronuncia alla fine della confessione, ma forse neanche con quelle si sarebbe sentita in pace.
Lei e Guglielmo erano gli unici a sfoggiare dei vestiti dal taglio elegante, che incutevano più rispetto che invidia ai contadini stipati nella chiesetta, i quali si sentivano al pari dei proprietari delle case che era stato concesso loro di abitare e dei poderi che dovevano coltivare con sudore e abnegazione, solamente durante la funzione religiosa. La fede e la fiducia che nutrivano in Dio, capace di togliere e dare solo per metterli alla prova, che giudica tutti per i peccati commessi e non per le ricchezze accumulate, li spingeva a credere che almeno di fronte al suo sguardo, almeno lì, nella Sua Casa, essi fossero uguali ai Baroni Baldinotti, nonostante il loro aspetto dicesse il contrario.
Giuliana teneva il viso affondato nelle mani, pregava con gli occhi chiusi e non si curava di sua figlia Leda. Tra un'Ave Maria e un Pater Noster, che ripeteva dentro di sé con ossessione, infilava sempre un pensiero per Primo: Oh, Signore, fammelo tornare a casa sano e salvo. Dio ti prego. Chiedo troppo? Te lo chiede una mamma, come Maria. Ma io non voglio vederlo crocifisso come te, scusa Signore. Ti prego tutti i giorni, tutte le sere prima di andare a dormire. Se è un miracolo quello che ti sto chiedendo, allora ascolta le parole disperate di questa madre che ha bisogno del tuo miracolo. Fammelo tornare a casa sano e salvo, Dio ti prego.
Univa le mani secche come per ricevere il sacramento, poi serrava le dita facendosi quasi male alle nocche, come se la forza che trasmetteva al suo corpo potesse dare una spinta più decisa verso l'alto alle sue preghiere di madre afflitta e sfinita.
Don Savino si rivolse ai fedeli allargando le braccia, alzò la mano destra e impartì la benedizione, subito dopo le persone iniziarono a uscire per cercare un soffio di vento che alleggerisse il caldo patito dentro la chiesa.
Una volta fuori, Giuliana prese a braccetto Leda, tirandola da una parte, mentre lei cercava con gli occhi Guglielmo, intento a salutare compostamente i contadini che ossequiavano sua madre.
- Mamma, rimaniamo ancora un po' con Guglielmo. -
- No, dobbiamo andare a casa a governare le bestie. -
- Pensi che se ne avrà a male se non lo saluto? -
- Lo hai già salutato prima di entrare in chiesa, e durante la messa non avete fatto altro che ridere. No, non se ne avrà a male, ti conosce, sa come sei. -
- Dopo voglio andare a giocare con lui alla villa, va bene mamma? - domandò Leda, con un sorriso largo e gli occhi sgranati.
Giuliana non rispose, mise un braccio sulle spalle di sua figlia e prese a camminare svelta lungo la strada polverosa che portava verso la loro casa. Leda iniziò a saltellare su un piede solo, come se avesse davanti a sé i riquadri del gioco della campana. Ogni tanto si voltava a cercare lo sguardo ormai lontano di Guglielmo, mentre Giuliana continuava a ripeterle, invano, di non alzare tutta quella polvere che avrebbe finito per rovinare le uniche scarpe buone che aveva. Tra un saltello e l'altro, come se dovesse concentrarsi bene solo su una cosa per volta, Leda recitava alcune strofe della sua poesia preferita, che a suo modo trovava familiare, come se parlasse dei luoghi in cui viveva.
- La nebbia a gl'irti colli piovigginando sale, e sotto il maestrale urla e biancheggia il mar... quattro, cinque, sei... - poi riprendeva fiato e continuava con la poesia: - ma per le vie del borgo dal ribollir de' tini va l'aspro odor de i vini... sette, otto e nove... -
Giuliana guardava davanti a sé, i suoi pensieri si mescolavano a quella voce che canticchiava spensierata.
- Mamma, cos'è il maestrale? - chiese Leda guardando sua madre, che camminava a testa alta.
- Te l'ho spiegato, amore - rispose premurosa Giuliana. - È un vento che viene dal mare - guardò la figlia che continuava a saltellare sulla campana che solo lei vedeva. - Ti ricordi quando il babbo ti ha raccontato di aver visto il mare? -
- Sì, mamma. Diceva che era come stare di fronte al fiume Pesa, però era grande, grande e largo, da qui fino a Firenze, e non si vedeva mai la fine. Che paura stare lì, mamma, sai che rumore farebbe la corrente di quel fiume così grande? -
Giuliana sorrise a quell'idea, ma neanche lei aveva mai ammirato un fiume più largo dell'Arno, che aveva visto quella volta in cui suo padre l'aveva portata a Firenze per il matrimonio di una loro parente. Era accaduto tanti anni prima, e lei era poco più grande di Leda, ma ricordava bene quei palazzi antichi ed enormi, fatti con grandi blocchi di pietra, quelle strade larghe e coperte di lastre grigie, le donne vestite come la baronessa, eleganti e di bell'aspetto, che passeggiavano senza fretta e chiacchieravano tra loro a bassa voce.
Quel ricordo la intristì. Chissà come sarebbe stata la sua vita in una città. Ma poi si chiese cosa avrebbe fatto, lei, figlia di contadini, in mezzo a tutti quei palazzi e a quelle signore. No, disse tra sé, lei stava bene lì, in campagna, dov'era cresciuta, dove aveva trovato marito e aveva partorito i suoi figli. Era contenta di quello che aveva, anche se questa guerra maledetta sembrava avesse rotto un incantesimo e ora aveva troppi pensieri che le ronzavano nella testa da mattina a sera.
Leda continuava a canticchiare altre rime che aveva appreso alle elementari dove, nonostante non riuscisse a capire ogni cosa, aveva imparato a leggere e scrivere, mandando a memoria tutto il libro delle poesie di Carducci e di Pascoli, un regalo della sua maestra, la signorina Gualtieri, che in quegli anni l'aveva seguita con amore.
“... è una bambina innocente e pura, come un cielo d'estate”, aveva detto ai suoi genitori, “dovete amarla e dovete esserne fieri. Nostro Signore le ha concesso in dono una mente speciale, una memoria prodigiosa. Abbiatene cura.”
Il cervello di Leda era come un grande armadio pieno di cassetti, alcuni dei quali però faticavano ad aprirsi, altri invece strabuzzavano di immagini, parole, ricordi. Ma solo cose buone, trasparenti e limpide come l'acqua di una sorgente; non c'era posto per i pensieri cattivi, le malignità o gli inganni. Era per questo che tutti la amavano e la proteggevano, rispettando il suo candore unico, che nessuno osava deridere.
Clelia e Guglielmo salirono sul calesse condotto da Osvaldo, l'anziano stalliere da sempre al servizio della famiglia Baldinotti. Il cavallo si mosse con indolenza appena sentì lo schiocco della frusta in aria.
La baronessa si assestò i capelli biondi raccolti a crocchia e rivolse un sorriso stanco a suo figlio. Il sole era già alto e spandeva su quel pezzo di campagna una luce bruciante. Clelia aprì l'ombrellino di lino bianco per ripararsi gli occhi e proteggere la pelle del suo viso candido. La strada, davanti a lei, correva dritta e bianca, dividendo in due il paesaggio: sulla destra i campi gialli di grano digradavano verso il fiume, per poi lasciare il posto a ordinati filari di viti dalle foglie larghe e verdi; sulla sinistra il ciglio d'erba secca si inerpicava su per una morbida pendenza punteggiata da ulivi dai rami nodosi, fino a incontrare gli alberi del bosco da cui proveniva lo stridio monotono delle cicale.
Leda sentì il rumore del calesse che arrivava da dietro, lasciò perdere il suo gioco illusorio e si voltò.: - Guglielmo! Guglielmo! - urlò felice.
Il ragazzo le sorrise quando il calesse le passò accanto e la salutò con un cenno della mano, la baronessa si sporse appena in avanti e disse qualcosa a Osvaldo, il quale fece scoccare la frusta; il cavallo ebbe un sussulto e in pochi attimi si lasciò dietro Leda e sua madre, che vennero avvolte da un velo bianco e sottile di polvere.
Come ogni domenica, all'ora della Santa Messa, Gino se ne stava nella sua stalla a curare le bestie, due buoi e una mucca che nessuno osava toccare poiché, di fatto, erano proprietà del barone. Al contempo, si prendeva cura degli attrezzi: ripuliva la macchina per fare il segato, affilava il pennato, sistemava il carro e l'aratro, riparava le ceste, controllava la tenuta delle scale di legno che servivano per arrivare in cima al pagliaio o per battere le olive.
Da quando era tornato dalla Grande Guerra, era entrato in chiesa solo per sposarsi e per i sacramenti dei suoi figli.
“Per non far sparlare la gente” aveva detto a sua moglie Giuliana.
Quale Dio poteva permettere le carneficine alle quali aveva assistito? E perché non io? Quando ci pensava, sentiva montare dentro un senso di vergogna per non essere là, su quelle montagne, a marcire insieme ai corpi dei suoi amici straziati dalle bombe e dalle mitraglie. Camminava, lavorava, pensava, alle volte gioiva, ma la sua anima, lassù, si era spaccata per sempre a causa dell'incredulità e della nausea provocata dal sangue e dalle sofferenze che aveva visto. Un pezzo era ancora lì, accanto ai suoi compagni di battaglia.
Dov'era, in quegli anni di orrore, quel Dio di cui gli avevano parlato i suoi genitori e il prete di Montespertoli, grassoccio e pasticcione, che pareva più un signorotto che un servo di Cristo?
Perché era rimasto cieco e sordo alle preghiere che la notte prima di ogni assalto giungevano dai ragazzi che credevano in Lui, così come avevano insegnato loro da bambini?
Aveva smesso di cercare le risposte a quelle domande l'alba di un giorno piovoso, quando il suo reparto, stanco e decimato, era stato di nuovo mandato all'assalto di una collina i cui pendii erano lastricati dai corpi dei suoi commilitoni. Aveva guardato il giovane tenente: con una mano tremante impugnava la pistola, mentre con voce che voleva far sembrare ferma ordinava la carica ai suoi uomini, molti dei quali erano più vecchi di lui.
Erano usciti urlando, per scacciare la paura; dopo poche decine di metri una granata era scoppiata di fronte a loro e Gino era stato investito da una ventata piena di terra e viscere. Riaperti gli occhi, accanto alla sua mano destra aveva visto la testa senza berretto del tenente e, a qualche metro di distanza, l'uniforme con le stellette che racchiudeva il corpo del giovane ufficiale: l'esplosione gli aveva strappato la testa e aveva dilaniato il resto, facendo uscire l'intestino e le budella dalla schiena e spargendole sulla giacca e sul viso di Gino che era invece rimasto illeso.
Era rimasto immobile, steso sulla terra bagnata, ricoperto di sangue che non era il suo, ma di cui sentiva il sapore metallico in bocca. Gli occhi che fissavano il cielo grigio, le rade gocce di pioggia che gli battevano addosso, ritmiche e consolatrici. Le lacrime avevano iniziato a scorrere, ostinate, segnale di una debolezza a cui non voleva cedere, ma che alla fine lo aveva sopraffatto. Serrata la mascella, aveva indurito ancora di più lo sguardo verso l'Onnipotente, che si era nascosto dietro le nuvole del colore del piombo delle mitraglie. Lui, che li aveva abbandonati prendendosi le loro vite.
Dio se ne era andato dalla sua vita quella mattina piovosa, anche se nei giorni di sconforto sentiva ancora il bisogno di qualcosa che andasse oltre ciò che riusciva a vedere, a toccare, annusare, per cercare di alleviare il senso di smarrimento e ritrovare la strada della fiducia.
L'unico ricordo di quel periodo che lo confortava era il cameratismo, quella complicità nelle piccole cose, quella voglia di non abbandonarsi l'un l'altro, tra ragazzi improvvisamente diventati soldati; uomini già padri o figli non ancora svezzati che venivano da tutta Italia, e che neppure si capivano quando parlavano tra loro. Ma poi, immancabilmente, il riaffiorare di quei volti gli provocava una fitta a quel che era rimasto della sua anima, ancora debole. Adesso, persino uccidere un animale gli suscitava un senso di inadeguatezza e ogni volta doveva rammentarsi che era costretto, che lo faceva per dare sostentamento alla sua famiglia; solo in quel modo riusciva a superare quell'esitazione, che inevitabilmente risvegliava ricordi che gli aggrovigliavano lo stomaco.
Seduto su un vecchio tino fuori dalla stalla, stava affilando le falci, quando sentì il rumore di un'automobile: era una Balilla che arrivava dalla strada maestra. Con la coda dell'occhio, vide scendere un ufficiale e due miliziani in camicia nera. Ansimando sotto il sole, gli uomini salirono su per la viottola che conduceva di fronte a casa sua.
Gino udì i loro passi avvicinarsi, ma non alzò lo sguardo, anzi, continuò a lisciare le lame con la pietra. Poi si sentì chiamare. Si girò e vide l'ufficiale sbuffare, le gambe larghe e i piedi ben piantati a terra, le mani sui fianchi. Con la faccia storta e gli occhi pungenti, quella figura smilza senza la divisa avrebbe potuto benissimo essere scambiata per un povero contadino come tanti.
- Buongiorno - fece Gino.
- Si dice: “buongiorno signor capitano” - ringhiò uno dei due miliziani, un tipo magro, giovane, con dei baffetti appena pronunciati.
Gino si alzò e lo guardò con le sue iridi celesti che sembravano d'acciaio, per via dell'ombra procurata dal cappello di paglia calato sulla testa. Osservò tutti e tre, senza una smorfia, senza dire una parola, poi riportò lo sguardo sui piccoli occhi dell'ufficiale.
- Va bene Iannuzzi, lascia stare le precisazioni. Villani sa con chi sta parlando - disse Annicò, con quel suo accento siciliano, agitando una mano verso il soldato. Fece scorrere qualche attimo, fissò il contadino di fronte a lui, poi aggiunse: - Ne è passato di tempo, eh? - abbozzò un mezzo sorriso - Qualche giorno fa ho letto un cognome nell'elenco dei giovani partiti per la guerra: Villani. Sapevo che eri di queste parti, allora mi sono detto: non sarà mica il figlio del Villani? Il mio vecchio commilitone nel campo di addestramento degli Arditi, lassù a Sdricca? - sogghignò ancora. - Avevo ragione, ora mi è tutto chiaro. Ed eccoci qui, dopo tanti anni. -
- Vedo che hai fatto carriera... adesso sei capitano - .
- Sai, ognuno ha una strada. La mia l'ho trovata senza fatica, continuando a fare quello per cui sono stato addestrato, e devo dire che non mi sono trovato male. E invece tu, cosa hai combinato dopo che il reparto è stato sciolto? -
- Trincea. Come prima. -
- Già. Assalti alla baionetta, morti dappertutto. Niente più operazioni speciali, ombre dietro le linee nemiche, senza rumori, adrenalina al massimo, coltello pronto. Ci penso spesso, sai. -
Gino lo guardava in silenzio. Quei ricordi gli mettevano i brividi, nonostante il caldo di quella mattina.
- Come mai da queste parti, capitano? Sono mesi che sei comandante della Milizia di questa zona e sono sicuro che sapessi da tempo dove trovarmi. Ma ti fai vivo solo adesso. Cos'è? T'è venuta tutta insieme la voglia di rivedere un vecchio compagno d'armi o c'è altro? - .
- Giusto. Basta con il passato, inganna e distorce il presente. - L'ufficiale si tolse il cappello a visiera e si asciugò il sudore sulla fronte con il dorso della mano. - Sappiamo che qualche tuo amico contadino aiuta i partigiani e nasconde dei renitenti alla leva, dei codardi che si rifiutano di combattere per la Patria. Sai che intendo? -
- E perché vieni a dirlo a me, capitano? E di domenica poi - .
- Diciamo che questa è una visita di cortesia a una persona che ha combattuto insieme a me e che ha dimostrato coraggio. In giro si dice che sei uno che parla poco, ma che quando parli tutti ti ascoltano. È questo che mi arriva alle orecchie sul tuo conto. Capisci ora perché sono qui? Non voglio che nessuno dei tuoi amici si faccia del male. -
- La gente qui ha paura, capitano. Pensano solo a lavorare duro nei campi, stanno chiusi in casa e si fanno gli affari loro. Non vogliono mettersi contro il Partito Fascista o i tedeschi e... -
- È un avvertimento, Villani. Fai girare la voce. Non proteggete questi infami o saremo costretti a fucilare chi li aiuta, anche se danno loro solo un pezzo di pane. È chiaro? - Poi abbozzò un sorriso beffardo. - E tuo figlio? Lui sì che sta facendo il suo dovere. -
- Non so niente. Non ho più avuto sue notizie dopo l'Armistizio dell'8 settembre del '43 - la voce di Gino si fece monotona e il suo pensiero volò verso Primo, il figlio maggiore, partito militare due anni prima. Erano passati quasi nove mesi da quando avevano ricevuto la sua ultima lettera; si trovava in un paese che anche lui, quando aveva combattuto la sua guerra, aveva sentito nominare: allora la chiamavano semplicemente la terra degli slavi, mentre Primo accennava alla Jugoslavia, come se fosse una nazione. Scriveva che era in buona salute e di non preoccuparsi, poiché non correva gravi pericoli. Poche righe che non erano bastate a rassicurare né lui né tantomeno la madre, che continuava a macerarsi dentro dall'angoscia.
- Tu hai combattuto in maniera onorevole. Spero che tuo figlio faccia altrettanto - chiosò Annicò, poi girò sui tacchi e se ne andò, seguito dai suoi.
Il terzo miliziano, quello che non aveva mai parlato, sui venticinque anni e dalla faccia un po' smunta, si attardò un attimo, poi si voltò, senza essere visto dagli altri, giusto il tempo di fare un sorriso cordiale e un cenno di saluto con la testa verso Gino.
Era il figlio del Salvini, un mezzadro che aveva la casa a poche centinaia di metri da lì; Gino lo conosceva da quando era nato, l'aveva tenuto a battesimo e spesso quel ragazzo che adesso indossava la camicia nera aveva giocato con Primo proprio nell'aia di casa sua.
Quel sorriso, pensò Gino, nascondeva il rimpianto per un tempo che se ne era andato e non sarebbe più tornato. Un sorriso di scuse imbarazzate, di chi aveva scelto una parte che fatalmente lo aveva messo contro alcuni dei suoi vecchi amici, adesso partigiani, e loro contro di lui. Non più compagni di giochi, ma nemici travolti da eventi più grandi di loro e pronti a darsi battaglia. Fino a che punto, si domandò Gino, quei ragazzi sarebbero stati capaci di odiarsi e poi uccidersi? O avevano indossato solo delle maschere, effimere, ma tragiche, che solo il destino avrebbe sfilato loro al momento opportuno, per rivelare la vera identità di ciò che erano, riportandoli alle grasse risate, alle grida sguaiate e ad accapigliarsi per un niente. Chissà se si sarebbero riconosciuti quando si sarebbero ritrovati uno di fronte all'altro, pronti a morire per la propria causa, giusta o sbagliata che fosse.
Rientrò nella stalla, passando dalla luce abbacinante del sole al buio della stanza senza finestre, e per qualche attimo rimase cieco e frastornato. La visita di Annicò lo aveva sorpreso. Il capo della Milizia si era preso la briga di andare a trovarlo personalmente per affidargli un messaggio molto chiaro. Ma entrambi, sia il contadino che il capitano, sapevano bene che ormai il corso della guerra era segnato. Un gesto di riguardo verso di lui e la comunità in cui viveva, ma che a Gino era parso più come un ultimo e tardivo tentativo di mostrare la faccia benevola del fascismo, prima che gli eventi travolgessero tutti.
|
|
Biblioteca
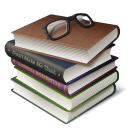
|
Acquista

|
Preferenze

|
Recensione
|
Contatto

|
|
|
|
|