
|
 Writer Officina Blog
Writer Officina Blog 
|
  Manuale di pubblicazione Amazon KDP. Sempre più autori
emergenti decidono di pubblicarse il proprio libro in Self su Amazon KDP,
ma spesso vengono intimoriti dalle possibili complicazioni tecniche. Questo
articolo offre una spiegazione semplice e dettagliata delle procedure da
seguire e permette il download di alcun file di esempio, sia per il testo
già formattato che per la copertina.
Manuale di pubblicazione Amazon KDP. Sempre più autori
emergenti decidono di pubblicarse il proprio libro in Self su Amazon KDP,
ma spesso vengono intimoriti dalle possibili complicazioni tecniche. Questo
articolo offre una spiegazione semplice e dettagliata delle procedure da
seguire e permette il download di alcun file di esempio, sia per il testo
già formattato che per la copertina. |
  Self Publishing. In passato è stato il sogno nascosto
di ogni autore che, allo stesso tempo, lo considerava un ripiego. Se da
un lato poteva essere finalmente la soluzione ai propri sogni artistici,
dall'altro aveva il retrogusto di un accomodamento fatto in casa, un piacere
derivante da una sorta di onanismo disperato, atto a certificare la proprie
capacità senza la necessità di un partner, identificato nella
figura di un Editore.
Self Publishing. In passato è stato il sogno nascosto
di ogni autore che, allo stesso tempo, lo considerava un ripiego. Se da
un lato poteva essere finalmente la soluzione ai propri sogni artistici,
dall'altro aveva il retrogusto di un accomodamento fatto in casa, un piacere
derivante da una sorta di onanismo disperato, atto a certificare la proprie
capacità senza la necessità di un partner, identificato nella
figura di un Editore. |
  Scrittori si nasce. Siamo operai della parola, oratori,
arringatori di folle, tribuni dalla parlantina sciolta, con impresso nel
DNA il dono della chiacchiera e la capacità di assumere le vesti
di ignoti raccontastorie, sbucati misteriosamente dalla foresta. Siamo figli
della dialettica, fratelli dell'ignoto, noi siamo gli agricoltori delle
favole antiche e seminiamo di sogni l'altopiano della fantasia.
Scrittori si nasce. Siamo operai della parola, oratori,
arringatori di folle, tribuni dalla parlantina sciolta, con impresso nel
DNA il dono della chiacchiera e la capacità di assumere le vesti
di ignoti raccontastorie, sbucati misteriosamente dalla foresta. Siamo figli
della dialettica, fratelli dell'ignoto, noi siamo gli agricoltori delle
favole antiche e seminiamo di sogni l'altopiano della fantasia. |
|
|
|
|
|
|
Conc. Letterario
|
|
|
|
Magazine
|
|
|
|
Blog Autori
|
|
|
|
Biblioteca New
|
|
|
|
Biblioteca Gen.
|
|
|
|
Biblioteca Top
|
|
|
|
Autori
|
|
|
|
Recensioni
|
|
|
|
Inser. Estratti
|
|
|
|
@ contatti
|
|
|
Policy Privacy
|
|
 Colpevole - ti porterò all'inferno
Colpevole - ti porterò all'inferno 
|

 Alta, magra, corti capelli color del rame. L'aspetto era quello di una signora di mezza età come tante, ma gli occhi nel viso scavato apparivano duri e severi. Come il suo cuore. Guidava lungo la strada al limitare dei campi incolti della periferia, tra anonimi casermoni e vecchie fattorie in disuso. Era l'imbrunire di una frizzante sera d'aprile e Isabella Antinori stava tornando a casa. Alla nuova casa. La vecchia ormai si affacciava a tratti, da dietro le palpebre chiuse, solo quando i ricordi tornavano a pungere. Accadeva di rado, tuttavia. La consapevolezza di aver compiuto il suo dovere fino in fondo era d'aiuto.
Alta, magra, corti capelli color del rame. L'aspetto era quello di una signora di mezza età come tante, ma gli occhi nel viso scavato apparivano duri e severi. Come il suo cuore. Guidava lungo la strada al limitare dei campi incolti della periferia, tra anonimi casermoni e vecchie fattorie in disuso. Era l'imbrunire di una frizzante sera d'aprile e Isabella Antinori stava tornando a casa. Alla nuova casa. La vecchia ormai si affacciava a tratti, da dietro le palpebre chiuse, solo quando i ricordi tornavano a pungere. Accadeva di rado, tuttavia. La consapevolezza di aver compiuto il suo dovere fino in fondo era d'aiuto.
Si era rifugiata tra i monti dell'Appennino Lucano. Abbastanza lontana dalla città dove aveva vissuto per sentirsi al sicuro, ma non tanto da non potervi tornare quando il desiderio di rivedere la tomba di Danilo diventava affanno.
Un berretto in testa, una parrucca nera lunga a sufficienza da coprirle le orecchie, e lenti a contatto colorate. Bastava questo, insieme alla sua prudenza. Non andava a passeggio per le vie cittadine. Portodimare veniva solo sfiorata. La sua auto assecondava la curva delle colline che la circondavano, senza entrare in città a meno che non fosse indispensabile.
Dopo un rapido saluto al mare, si dirigeva verso il Nido dell'Aquila.
La Basilicata era una regione che conosceva bene e quando si era trattato di decidere dove nascondersi, non aveva avuto incertezze. Le montagne lucane, selvagge e boscose, l'avevano sempre affascinata. Negli ultimi due anni aveva organizzato un piccolo laboratorio, come una volta, riallacciando così i rapporti lavorativi con aziende di elettronica e ingegneria biochimica. Sotto mentite spoglie, era tornata a guadagnarsi da vivere grazie alle proprie capacità.
Andava veloce come un flusso di pensieri, lo sguardo apparentemente distratto. Dopo una curva, senza preavviso, un'ombra sbucò di corsa dalla semioscurità. Pareva volersi scagliare contro la macchina. I fari ne illuminarono la figura intera: occhi sgranati, mani aperte e braccia tese in avanti a implorarla di fermarsi, labbra socchiuse in una muta preghiera.
Fu solo grazie alla sua prontezza di riflessi se non la prese in pieno. Sterzò bruscamente a sinistra, e pur senza riuscire a evitarla del tutto, la toccò appena. Lo specchietto retrovisore le sfiorò il fianco, poi per l'urto si ripiegò su sé stesso. Una rapida controsterzata per rimettersi in carreggiata, un repentino colpo di freni e l'auto si fermò con le gomme che protestavano.
La ragazza era caduta per terra, dolorante ma miracolosamente illesa, a parte qualche graffio di poco conto. Gli unici traumi li avevano sofferti la minigonna e i tacchi a spillo.
«Ma che diavolo fai, sei impazzita?» la apostrofò scendendo dalla macchina.
Entrare in contatto con le autorità per via di un incidente stradale era davvero l'ultima cosa di cui aveva bisogno.
«Aiutami...» sibilò lei mentre si rialzava in fretta, lanciando occhiate ansiose alle spalle.
Forse qualcuno la inseguiva.
«Fammi salire in macchina, per favore! Io... io devo allontanarmi da qui» proseguì con lieve accento straniero.
Lei ci rifletté giusto una manciata di secondi. Non voleva prender su quella ragazza, aveva già abbastanza casini per conto proprio. Che fosse spaventata era evidente, che il pericolo fosse reale... chissà. Non poteva averne la certezza, non si vedeva nessuno, e magari rischiava di raccattare una tossica, una che per due soldi le avrebbe puntato contro un coltello o qualcosa di peggio.
Però era così giovane. Come Danilo.
Danilo, suo figlio, che non aveva trovato nessuno a cui chiedere aiuto.
Impiegò poco a decidere. Non poteva lasciarla lì per terra. Non poteva voltarle le spalle. Le porse la mano perché vi si aggrappasse.
«Monta, sbrigati!» le disse brusca.
La ragazza si affrettò a entrare. Isabella girò davanti al cofano, fece altrettanto e subito ripartì.
Percorsero alcuni chilometri in silenzio.
Era strano avere qualcuno accanto a lei.
La borsa, abitualmente poggiata sul sedile di destra, socchiusa per potervi infilare la mano a tirar fuori le sigarette, stava adesso per terra, vicino alle gambe escoriate della sua ospite. Quando la strada lo consentiva, le lanciava un'occhiata veloce. Trascorsi i primi minuti, dopo aver realizzato che nessuno sembrava inseguirle, la ragazza si era rilassata. Aveva appoggiato la fronte al finestrino, volgendo gli occhi all'oscurità incombente.
Guardava senza vedere.
«Dove devi andare?»
La domanda di Isabella le provocò un leggero sobbalzo. Per un momento sembrò lontana, troppo lontana per essere raggiunta.
Poi rispose con un filo di tristezza nella voce.
«Io... non lo so. Fin dove puoi portarmi?» Isabella si strinse nelle spalle.
«Dove vuoi. Non ho grandi impegni.»
Era sola, infatti, ormai da molto tempo. Non aveva nessuno a cui badare o al quale rendere conto. Poteva permettersi di fare la buona samaritana. Entro certi limiti, ovvio. Non l'avrebbe di sicuro accompagnata in questura. Un lampo ironico le stirò le labbra, al pensiero.
La ragazza non rispose. Silenziose, le lacrime presero a scorrerle sulle guance.
Isabella nel frattempo aveva distolto gli occhi dalla striscia d'asfalto.
«Sei nei guai?» le chiese a bassa voce.
Lei annuì. Poi, resasi conto che la sua ospite non poteva vederla, rispose in un soffio.
«Sì.»
«Problemi con la legge? Rischiamo di incontrare un posto di blocco?»
«No» disse, guardandola leggermente sconcertata. «Certo che no.»
«Qualcuno ti insegue?»
«Sì, forse. Non ne sono sicura.»
«Vogliono farti del male?»
«Se mi prendono, sì.»
«Hai un posto dove andare?»
Sembrava un interrogatorio, realizzò mentre le sparava contro quella serie di domande.
Lei non sembrò percepirlo così.
«Non più» rispose tirando su col naso. «Mi spiace» aggiunse smorzando la voce, come se si vergognasse di non avere una casa. Come se fosse colpa sua.
«Tranquilla. Apri il cassetto portaoggetti. Sì, quello. Ci sono salviette imbevute e fazzoletti di carta. Usali entrambi.»
«Grazie. Sei gentile.»
Un leggero sorriso si aprì sul volto della ragazza, quasi con timidezza. Isabella non lo vide, e tuttavia lo sentì. L'atmosfera si era improvvisamente addolcita.
«Tampona anche quei graffi» le disse dopo aver notato i palmi delle mani escoriati. «Mi rincresce, ma sei sbucata all'improvviso e non sono riuscita a evitarti. Per fortuna ti ho solo colpita di striscio. Come ti chiami?»
«Dana.»
«Dana, e poi?»
«Vytvitskyy. È difficile da pronunciare per voi italiani.»
«Facile non è» concordò Isabella. «Quanti anni hai?»
«Venticinque.»
Venticinque, come suo figlio. Ed era sola. Come lo era stato lui. E come lui aveva bisogno d'aiuto.
Non aveva potuto essergli vicino, allora, cinque anni prima. Forse, se Danilo fosse stato aiutato, adesso lui avrebbe avuto trentuno anni, e lei un nipotino o magari anche due, chissà.
Il destino gioca strani scherzi, a volte.
La osservò per un attimo mentre, con una smorfia di dolore, la ragazza premeva il fazzoletto sulla pelle escoriata.
Qualcosa, forse un sentimento materno sopito eppur presente nonostante il trascorrere degli anni, le imponeva di non commettere l'errore compiuto a suo tempo da chi, potendo aiutare un innocente, aveva preferito voltarsi dall'altra parte. Nessuno aveva offerto sostegno e fiducia a suo figlio. Ma lei forse poteva offrirli a quella ragazza terrorizzata, ferita e senza un posto dove andare, quasi a riprendere in mano il filo di una vita interrotta tanto tempo prima. Gli anni di Danilo potevano tornare a scorrere attraverso questa ragazza, in qualche modo.
La decisione fu presa in fretta.
«Andiamo a casa mia, così ti disinfetti quei graffi. E se ti va... puoi anche fermarti, stanotte. Lo spazio c'è.»
Pre-trattamento
Si risvegliò al buio, con un mal di testa lancinante e un orrendo sapore metallico in bocca.
Era sdraiato a pancia in giù sopra un oggetto che aveva tutta l'aria di essere un vecchio materasso usato. Puzzava di qualcosa che cercò in tutti i modi di ignorare. Ancora stordito tentò di liberarsi gli occhi.
Era sicuro di essere stato bendato, ma non aveva nulla sul volto. Anche con gli occhi spalancati c'era solo oscurità.
Sentiva un dolore martellante alle tempie e un senso di oppressione alla nuca. Il minimo movimento della testa gli procurava una esplosione di dolore. Ondate successive che si accavallavano una sulla coda dell'altra, sempre più violente. A tutto questo si aggiungeva un senso di nausea, esasperato dal persistente tanfo di urina vecchia mista a muffa proveniente dal materasso. Il fetore era tale da provocargli dei conati di vomito. Cercò inutilmente di trattenersi, era consapevole che lo sforzo avrebbe scatenato una reazione impossibile da sostenere, ma non vi riuscì. Sempre nel buio più totale si sollevò leggermente su un fianco, si sporse per non vomitarsi addosso e rimise. Urlò per il dolore indicibile che sembrava volergli spaccare la testa.
«Sto morendo» fu l'ultimo pensiero cosciente. Poi svenne. Il sollievo tuttavia non durò a lungo. Le fitte agirono presto come una boccetta di sali, e lo riportarono alla realtà con uno strappo.
Non si era mai sentito così male, così infelice e così solo.
Giacque a lungo supino, aspettando che il mal di testa e la nausea si calmassero, mentre il freddo si impadroniva di lui. Intuì che quella reazione così esagerata doveva essere colpa della roba usata per farlo addormentare, ma non aveva soluzioni. L'unica era attendere che ne passassero gli effetti.
Avrebbe voluto riflettere, capire, ma in quel momento ragionare era uno sforzo troppo grande, un'impresa superiore alle sue forze. Impossibile.
Si arrese e lasciò che il sonno gli calasse nuovamente addosso, in maniera più naturale.
Dormì. Quanto a lungo, non seppe.
Questa volta fu il freddo a tirarlo fuori dal sollievo dell'incoscienza. Il ritorno alla realtà gli riportò la paura per ciò che gli stava capitando, ma anche la consapevolezza di non avere più quella tremenda emicrania. Un minimo di fortuna, in quell'incubo.
La scomparsa del dolore era l'unica nota positiva della sua situazione. Aveva una paura fottuta. Non sapeva dov'era né perché fosse stato rapito. E non vedeva nulla, se non le lucciole create dalla mente per sopperire al buio assoluto.
Aveva una sola certezza. Il sequestro non era avvenuto per soldi. Se fosse stato quello il motivo, avrebbe avuto a che fare con dei perfetti idioti. Nonostante la tragica situazione, gli salì sulle labbra un sorrisetto sarcastico. Poteva dare loro solo debiti: quelli sì, quanti ne volevano.
Era solo e nessuno l'avrebbe aiutato. Ignorava quanto tempo fosse passato, ma non doveva essere trascorsa più di mezza giornata dal rapimento, almeno a giudicare dalla barba che sentiva ricrescergli ispida sulle guance. Tarda mattina della domenica, dunque, al massimo le prime ore del pomeriggio. E fino a martedì non avrebbe dovuto presentarsi a scuola per il consiglio docenti. La preside avrebbe aspettato almeno il mercoledì prima di cominciare a chiamarlo. Giovedì sarebbe passato in attesa che lui si facesse vivo e forse venerdì avrebbero denunciato la sua scomparsa. Un'eternità.
All'improvviso si ricordò del cellulare. In realtà, lo adoperava poco. Non aveva amici né parenti a parte il cugino e con lui si sentiva di rado. Più che altro lo teneva per motivi di lavoro. Chiunque si fosse trovato nella necessità di contattarlo, un collega, la preside, l'addetto di segreteria, poteva raggiungerlo telefonicamente.
Si rizzò a sedere e si tastò ogni tasca alla ricerca del suo smartphone, sperando che i rapitori non ci avessero già pensato. Se ci fosse stato campo avrebbe potuto chiedere aiuto. Ma gli sarebbe stato utile comunque, almeno per guardarsi intorno. Non l'aveva mai accesa, però sapeva che c'era una potente torcia incorporata.
Già, peccato che non avesse più il cellulare. Non rammentava nulla al riguardo, dovevano averglielo tolto dopo averlo messo KO col cloroformio o quello che era. Il solo pensiero della sostanza usata per addormentarlo gli fece tornare in gola il disgustoso sapore metallico, ma riuscì a reprimere il conato che gli si era affacciato sullo stomaco. Aveva sete. E anche freddo. Nonostante il giubbino che indossava, era gelato. Dopotutto si trattava di un indumento leggero. Era pensato per ripararsi dal vento di terra che spesso rinfrescava le notti d'estate, non per quella ghiacciaia. Ma dove diavolo l'avevano portato? Come poteva essere così bassa la temperatura a luglio? E per quale motivo tenerlo così al freddo e al buio? E quanti giorni sarebbero trascorsi prima che qualcuno si accorgesse della sua scomparsa? E...
Preda dei dubbi e di un'inquietudine crescente, d'un tratto si ritrovò a urlare, quasi senza accorgersene.
«Ehi! Ehi! Aiuto!»
La voce gli uscì gracchiante facendogli dolere la gola irritata. Scese carponi dal materasso e si alzò in piedi come per imprimere maggiore forza alle sue urla.
«Ehi, voi!» gridò di nuovo con più decisione. «Sono qua!
C'è nessuno? Aiuto!»
Non rispose nessuno, e nessuno accorse. Nemmeno per intimargli il silenzio.
Tacque con la stessa velocità con cui aveva cominciato a gridare. Rimase in piedi, immobile, in preda a una profonda angoscia. Che qualcuno avesse deciso che quel luogo oscuro sarebbe stato la sua tomba? Ma chi? E soprattutto, perché?
D'accordo, azioni cattive ne aveva commesse tante, ma...
L'unica davvero malvagia, quella a cui avrebbe dovuto pensare per prima, chissà perché non gli venne in mente. E questa sua dimenticanza costituiva forse una colpa ancor più grave della colpa stessa.
Dopo qualche minuto si riscosse, trovando una piccola speranza nel ricordare il volto del suo sequestratore celato dal passamontagna. Se i rapitori avessero voluto ucciderlo, non avrebbero nascosto i loro lineamenti.
Si rimise seduto sul materasso, le mani sotto le ascelle in cerca di calore, rannicchiato su sé stesso, tremante, ma non riuscì a resistere a lungo. Stando fermo il freddo diventava insopportabile, doveva muoversi, fare qualcosa. Una qualsiasi, non aveva importanza.
Nuovamente in piedi, allungò le braccia davanti a sé e avanzò alla cieca, a piccoli passi. Quasi non sollevava i piedi dal pavimento per paura di inciampare in un ostacolo.
Pavimento? Eppure non sembrava il pavimento di una stanza quello che sentiva sotto le suole leggere delle scarpe. Si chinò sulle ginocchia e poggiò una mano sul terreno. Non avvertì il freddo della ceramica sotto le dita, ma qualcosa che sembrava polvere. O forse, pietra? Batté più volte il palmo della mano al suolo. Terra. Era un pavimento di terra battuta. Una grotta, allora? Ma sì, era stato portato in una caverna!
Ecco il perché di tutto quel freddo, si disse. E del silenzio, anche. Un silenzio pesante, che gli gravava sulle spalle come una coperta intessuta di sassi. Nessuno mai avrebbe udito le sue implorazioni di aiuto, laggiù.
Quanto poteva essere profonda, una grotta?
«Okay, meglio non pensarci», fu la conclusione a cui giunse. Meglio continuare la cieca esplorazione della sua prigione. Magari avrebbe trovato qualcosa di utile. Gli avevano tolto la vista, ma aveva altri sensi sui quali contare. Il tatto, in primis.
Riprese lentamente ad avanzare fino a toccare una parete di fronte a lui. Non era di mattoni o cemento, sembrava fatta di roccia o di lastroni sagomati in modo irregolare, e questo gli confermò l'idea di trovarsi in una grotta o in una cantina. Tenendo la parete alla sua sinistra proseguì sfiorandola con la mano. Aveva stabilito di arrivare all'angolo e da lì cominciare a contare i passi che lo avrebbero portato all'angolo successivo, per accertare la lunghezza della parete, proseguendo poi fino a tracciare idealmente il perimetro del locale.
Toccando sempre il muro andò avanti nel buio. E avanti.
E avanti.
Quanto diavolo era grande l'ambiente in cui si muoveva, se ancora non aveva trovato il primo angolo? Possibile che fosse un solo lungo corridoio? E se avesse incontrato una biforcazione, se si fosse inoltrato per chilometri, smarrendosi per sempre nell'oscurità? Nelle grotte può accadere.
A quel pensiero la pelle gli si accapponò e sentì il cuore mancare un paio di battiti con un risucchio d'aria nei polmoni. Tossì, più per una reazione nervosa che per un vero bisogno. Girò su sé stesso e tornò indietro, questa volta con la mano destra a sfiorare la parete.
Quel materasso puzzolente che aveva abbandonato gli sembrava ora l'unico rifugio possibile, ma come avrebbe fatto a ritrovarlo? Quando se l'era lasciato alle spalle non aveva contato i passi che lo separavano dal muro e ora non aveva il coraggio di abbandonare quello stesso muro che si era trasformato nel suo unico punto di riferimento. Vagare a vuoto nelle tenebre senza più nemmeno il conforto della parete a dargli certezze lo terrorizzava.
Doveva per forza andare avanti. O meglio, indietro.
E proseguì senza poter valutare il tratto percorso. A un certo punto aveva smesso i passettini abbandonandosi a un'andatura quasi normale, mantenendo sempre il contatto con la parete.
Improvvisamente le sue dita sfiorarono un materiale diverso. La pietra aveva ceduto il posto al legno. Si fermò, tastandolo per capire cosa fosse, anche se l'aveva già intuito.
Era una porta. Squadrata, di legno ruvido, poco più alta di lui e due volte larga. Non c'era maniglia, solo il buco della serratura. Niente cardini, erano dall'altro lato. Al centro, più o meno all'altezza del volto, c'era un buco rettangolare grande quanto le sue mani affiancate. Provò a infilarcene una, ma le dita batterono contro una superficie di metallo. Per un attimo rimase sconcertato, senza capire, ma in breve realizzò. Era la porta di una cella, la sua cella, e quella piccola cavità doveva essere uno spioncino! Prima o poi qualcuno l'avrebbe aperto, allora.
Pensò che adesso avrebbe potuto oltrepassare la porta nel tentativo di circumnavigare la camera e ritrovarla alla fine del giro, giusto per capire meglio dove fosse, ma la paura che aveva provato prima, quando si era reso conto che stava camminando troppo e che forse si era perduto nei cunicoli sotterranei, gli impedì di proseguire oltre.
Mentalmente esausto, non trovò la forza di lasciare l'ingresso della sua prigione, e si lasciò scivolare al suolo lì dov'era, le spalle contro il legno, rinunciando all'unico conforto che i rapitori gli avevano dato.
Aveva tentato di preparare il programma delle lezioni che avrebbe tenuto il prossimo anno scolastico, ma distratto dal pensiero del suo destino non riuscì a produrre nulla che vi assomigliasse, e la cosa finì per abbatterlo ulteriormente. Iniziò allora a canticchiare per tenersi compagnia, ma dopo le prime strofe gli venne meno la voce.
Spalle alla porta, la testa appoggiata al legno, le braccia raccolte intorno alle gambe, non poteva fare altro che attendere. Qualcuno sarebbe arrivato, qualcuno gli avrebbe detto perché era là.
Sperava che accendessero la luce, che gli dessero qualcosa da bere, e magari una coperta. Aveva freddo. A tratti un tremito gli correva lungo il corpo. Non avrebbe saputo dire però se per il freddo o per la paura che, anch'essa, si insinuava nelle ossa. Stava lì, immobile, abbattuto, quando sentì dei passi attutiti provenienti dall'esterno avvicinarsi gradualmente. Di scatto si alzò in piedi e cominciò a gridare, battendo con la mano aperta sul vecchio legno della porta.
Una luce improvvisa lo accecò inondando la cella. Non riuscì a vedere chi c'era dall'altro lato, sentì solo il cigolio del metallo e un rumore di qualcosa che cadeva a terra un attimo prima che lo spioncino venisse nuovamente richiuso. Senza una parola.
La paura riprese pieno possesso dei suoi pensieri. Se non volevano ucciderlo, allora che volevano da lui? Perché quel silenzio?
Con la mano sugli occhi per schermarli dalla luce, si guardò intorno. Finalmente poteva vedere dove si trovava. Afferrò l'involto da terra, ma non lo aprì. A giudicare dalla forma conteneva anche una bottiglia, ma la sete poteva aspettare. Aveva necessità di conoscere i confini della sua prigione più di qualsiasi altra cosa.
Il ragionamento di prima era stato corretto. Si trovava in una specie di grotta circolare, ma non così grande come gli era sembrata al buio. La luce rivelava le sue ridotte dimen- sioni. Probabilmente quando temeva di essersi perso aveva ancora le percezioni alterate dal cloroformio inalato, oltre che dal buio.
Ecco lì anche il suo giaciglio, poco discosto dalla parete, vicino alla chiazza di vomito ormai asciutta. Si affrettò a trascinarlo lontano da quel ributtante residuo. Lungo il lato corto era posta una coperta ripiegata, che al buio non aveva potuto scorgere. La dispiegò e se l'appoggiò sulle spalle come fosse un mantello.
Probabilmente nel suo cieco procedere aveva quasi completato il mezzo giro della camera, arrendendosi prima di arrivare nelle vicinanze dell'uscio. Forse era tornato indietro proprio all'altezza di quel cunicolo che adesso notava in fondo alla stanza.
Si avvicinò per meglio capire cosa fosse. Era una piccola rientranza nel muro, bassa e stretta. Lui ci entrava di giusta misura. Alla fine c'era un buco nel terreno, largo una ventina di centimetri e forse trenta di profondità. Non ci mise molto a capire che era il suo bagno. Quando ne realizzò il significato gli sfuggì un singhiozzo, poi si costrinse a usarlo. Ne aveva bisogno.
Si era appena seduto sul materasso e stava aprendo il sacchetto che gli avevano dato, quando la luce si spense.
Non lo sapeva ancora, ma l'avrebbe ben presto imparato, che la luce lì dentro era un bene prezioso, tanto importante quanto di breve durata.
Dado e bullone
Chi perde un genitore è orfano, chi perde il coniuge è vedovo. Esiste una parola per ogni lutto, ma non quella per una madre a cui muore il figlio.
Eppure non esiste pena più grande. E non finisce mai.
Non passa giorno senza che il pensiero fugga, almeno una volta, a chi doveva sopravviverti e non l'ha fatto.
C'è sempre un'ombra dietro di te, un irreale fruscio che ti spinge a voltarti all'improvviso, nell'assurda speranza che muovendoti abbastanza in fretta tu riesca a cogliere... chissà. Qualcosa, qualcuno. Un fantasma, una vibrazione nell'aria. Come onde mute che smuovono il tempo.
Per un attimo, anche un attimo solo.
Fu questa condizione senza nome che la spinse a mettersi in gioco per una perfetta sconosciuta. Forse poteva colmare il vuoto che l'opprimeva.
Non era la solitudine a pesarle, l'aveva scelta e le stava bene, ma soffriva l'inutilità di quelle giornate senza senso. O meglio, senza impegni. Giorni senza, e basta. Non aver nessuno cui pensare era la sua condanna e la sua pena.
Il tempo lenisce il dolore, dicono. Sarà così. Ma il vuoto resta, e si trasforma in voragine in cui la mente, lentamente, cade.
La ragazza era in cerca d'aiuto, lei era in cerca di qualcosa che desse un significato alla sua vita, di qualcuno per cui spendersi. Erano come un bullone e il suo dado: dovevano solo incontrarsi per avvitare le loro vite.
Dana, che aveva accettato l'invito per disperazione, perché non aveva altro luogo in cui rifugiarsi, convinta di fermarsi solo qualche giorno, giusto il tempo di riprendersi e riflettere, era ormai di casa. Non un'estranea, non un'ospite. Un'amica. Quasi una figlia.
Isabella l'aveva condotta lì per offrirle cibo e conforto, perché c'era quella ferita nel suo cuore che attendeva solo di essere ricucita. E la ferita nel cuore di Dana non era da meno. Passò del tempo. Impararono a conoscersi, a volersi bene, a fidarsi. Così diverse, così simili... anche se ancora non lo sapevano.
Non lo avrebbero ignorato a lungo, tuttavia.
Isabella non la forzò. Intuiva che c'era qualcosa dietro le lacrime che scendevano senza apparente ragione, dietro l'improvviso incupirsi degli occhi. Ma non si può costringere qualcuno ad aprirti il cuore. Ci vuole tempo. E pazienza. E dolcezza. Ci vogliono comprensione, attenzione, sorrisi. Occorre che la convivenza si trasformi in amicizia, e l'amicizia in affettuosa complicità.
«Parlami di tuo figlio, Isa» le chiese la ragazza un pomeriggio di fine maggio, al tramonto, in uno di quei momenti in cui la pace donata dalla montagna è così intensa che pare ci si possa nuotare dentro. E morirvi, perfino.
Era già passato un mese dal loro scontro e le due donne stavano stringendo un legame sempre più forte.
Il riflesso del sole calante attraversava le nuvole trasformandole in batuffoli rosa arancio e donava una sfumatura rossa all'intero orizzonte irto di abeti.
Rughe di dolore e di rimpianto ricamarono il volto di Isabella. I suoi occhi si voltarono verso nord, come se volessero valicare quelle cime per raggiungerne un'altra. Una in cui c'era un altopiano a mezzaluna su una valle scoscesa. E una piccola urna di legno e metallo.
«Di Danilo? Cosa vorresti sapere?»
«Tutto quello che vuoi. Tutto quello che puoi.»
Era il momento che Isabella inconsciamente stava aspettando. Lo sapeva che sarebbe toccato a lei, aprirsi. Doveva far vedere le sue ferite, rendersi vulnerabile, perché Dana si spogliasse della sua corazza.
Si alzò dalla panca su cui erano sedute, una accanto all'altra, ed entrò in casa. Dopo pochi minuti tornò da lei. Aveva in mano un piccolo album di fotografie, come si usavano una volta. Era l'unica cosa che aveva salvato della sua vita precedente.
«È una lunga storia, mia cara...»
«Io non ho da fare.»
E poi, in un altro pomeriggio di quiete, venne il momento della scelta di Dana. Una decisione spontanea, come era giusto che fosse.
Isabella aveva preparato il tè e, da consuetudine, gliel'aveva porto con un sorriso silenzioso. Lei, seduta al vecchio tavolo da cucina intenta a sfogliare un quotidiano di qualche giorno prima, alzò lo sguardo dalle pagine e lo ricambiò.
Forse fu questo. Oppure fu la carezza che, mentre metteva la tazza sulla tovaglietta, sfuggì di mano a Isabella per poggiarsi delicatamente sui suoi capelli biondi. La ragazza intuì che in quel momento lei stava accarezzando entrambi i suoi figli, quello già morto e quella ancora in vita.
E così iniziò a parlare, gli occhi fissi sul liquido ambrato che si andava pian piano raffreddando, il barattolo della marmellata rimasto chiuso.
Solo al termine del lungo racconto sollevò il volto e scrutò l'amica, seduta di fronte a lei. Ignorava quale sarebbe stata la sua reazione e temeva che la giudicasse male. Ci teneva, al suo parere.
Isabella rimase in silenzio. C'era molto da pensare. Mentre rifletteva allungò una mano, questa volta consapevolmente, a carezzarle le sue contratte in pugno, e allentarne così la stretta. Poi parlò, con voce bassa e pacata.
Le disse che le dispiaceva, che capiva perfettamente i suoi sentimenti.
Le disse di tener duro, perché c'era ancora speranza. Le disse che l'avrebbe aiutata.
Non specificò in quale modo, ma aveva sfidato le regole del sentire comune già una volta, e non aveva timore di riprovarci.
Nei giorni successivi la mente di Isabella fu occupata da cupe, vecchie riflessioni sull'animo umano. Cosa spingesse le persone a comportarsi in maniera tanto infame era qualcosa che non riusciva a capire. Un tarlo, la malvagità di certi individui, che finiva puntualmente per sfiancarla.
Però sapeva che non poteva chiudere occhi e cuore, semmai doveva far tacere la voce della ragione che le gridava di non schierarsi ancora una volta contro la Legge, ma di rispettare i ruoli e la prassi, di assecondare stupide norme create ad hoc per garantire a una manica di vigliacchi, e ai loro lacchè, di sopraffare il prossimo. Non poteva tollerare che nessuno facesse niente, in una attesa senza speranza.
Riprovò una rabbia antica, quella stessa che le aveva fatto tirar calci contro ogni sasso che le appariva davanti, sin da quando era bambina. Fu allora che decise di accantonare le riflessioni. Tanto non ne sarebbe venuta a capo. Occorreva agire.
E riuscire a ottenere giustizia, e rendere alla ragazza ciò che le spettava, divenne il suo imperativo.
Ci meditò su per giorni interi, cercando di capire come procedere. Non poteva fare tutto da sola, di questo era sicura. Dana la osservò spesso, durante quei lunghi silenzi, e impiegò poco per capire che qualcosa frullava nella testa dell'amica. Ciò nonostante, Isabella decise di scoprire le sue carte solo quando, finalmente, le riuscì di abbozzare a grandi linee un piano.
In un primo momento la ragazza rifiutò. Da una parte non si sentiva in grado, dall'altra non voleva accettare che la donna che l'aveva accolta amorevolmente in casa sua rischiasse tanto per lei.
Isabella non le fece pressioni. Il suo piano prevedeva una forza d'animo e una determinazione non indifferenti, ma era certa che Dana le avrebbe trovate. Le occorreva soltanto un po' di tempo. Mentalmente, però, già andava definendo i par- ticolari con la solita, scientifica precisione. Comprò una serratura nuova, una piccola lastra di metallo e cardini. Comprò una pala, e telecamere a infrarossi. Costruì alcuni piccoli aggeggi nel suo laboratorio.
E aspettò.
|
|
Biblioteca
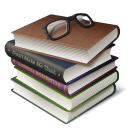
|
Acquista

|
Preferenze

|
Recensione
|
Contatto

|
|
|
|
|