
|
 Writer Officina Blog
Writer Officina Blog 
|
  Manuale di pubblicazione Amazon KDP. Sempre più autori
emergenti decidono di pubblicarse il proprio libro in Self su Amazon KDP,
ma spesso vengono intimoriti dalle possibili complicazioni tecniche. Questo
articolo offre una spiegazione semplice e dettagliata delle procedure da
seguire e permette il download di alcun file di esempio, sia per il testo
già formattato che per la copertina.
Manuale di pubblicazione Amazon KDP. Sempre più autori
emergenti decidono di pubblicarse il proprio libro in Self su Amazon KDP,
ma spesso vengono intimoriti dalle possibili complicazioni tecniche. Questo
articolo offre una spiegazione semplice e dettagliata delle procedure da
seguire e permette il download di alcun file di esempio, sia per il testo
già formattato che per la copertina. |
  Self Publishing. In passato è stato il sogno nascosto
di ogni autore che, allo stesso tempo, lo considerava un ripiego. Se da
un lato poteva essere finalmente la soluzione ai propri sogni artistici,
dall'altro aveva il retrogusto di un accomodamento fatto in casa, un piacere
derivante da una sorta di onanismo disperato, atto a certificare la proprie
capacità senza la necessità di un partner, identificato nella
figura di un Editore.
Self Publishing. In passato è stato il sogno nascosto
di ogni autore che, allo stesso tempo, lo considerava un ripiego. Se da
un lato poteva essere finalmente la soluzione ai propri sogni artistici,
dall'altro aveva il retrogusto di un accomodamento fatto in casa, un piacere
derivante da una sorta di onanismo disperato, atto a certificare la proprie
capacità senza la necessità di un partner, identificato nella
figura di un Editore. |
  Scrittori si nasce. Siamo operai della parola, oratori,
arringatori di folle, tribuni dalla parlantina sciolta, con impresso nel
DNA il dono della chiacchiera e la capacità di assumere le vesti
di ignoti raccontastorie, sbucati misteriosamente dalla foresta. Siamo figli
della dialettica, fratelli dell'ignoto, noi siamo gli agricoltori delle
favole antiche e seminiamo di sogni l'altopiano della fantasia.
Scrittori si nasce. Siamo operai della parola, oratori,
arringatori di folle, tribuni dalla parlantina sciolta, con impresso nel
DNA il dono della chiacchiera e la capacità di assumere le vesti
di ignoti raccontastorie, sbucati misteriosamente dalla foresta. Siamo figli
della dialettica, fratelli dell'ignoto, noi siamo gli agricoltori delle
favole antiche e seminiamo di sogni l'altopiano della fantasia. |
|
|
|
|
|
|
Conc. Letterario
|
|
|
|
Magazine
|
|
|
|
Blog Autori
|
|
|
|
Biblioteca New
|
|
|
|
Biblioteca Gen.
|
|
|
|
Biblioteca Top
|
|
|
|
Autori
|
|
|
|
Recensioni
|
|
|
|
Inser. Estratti
|
|
|
|
@ contatti
|
|
|
Policy Privacy
|
|
 La luce che resta
La luce che resta 
|

 Un riflesso nella mia ipocrisia.
Un riflesso nella mia ipocrisia.
Il giorno che mi ha spezzato
Non fu un grido, né il dolore acuto che squarcia l'aria. Fu qualcosa di molto più profondo, più subdolo. Fu il silenzio. Quello che si insinua tra i muri e ti si attacca sotto la pelle. Ti trova quando meno te lo aspetti. Poi si siede accanto a te, senza più andarsene. Una crepa invisibile, un'eco che nessuno sente, ma tu sì. Sempre.
Quel giorno non lo dimentico. Non per ciò che accadde, ma per ciò che non accadde più. Mai più.
Avevo sette anni. Disegnavo sul pavimento della cucina, il mento appoggiato sulle ginocchia, un pennarello blu stretto nella mano. Provavo a disegnare una porta che si aprisse da sola, come quelle che si vedono nei sogni. Ogni volta che tracciavo la maniglia, però, diventava un punto interrogativo.
Come se quella porta volesse dirmi qualcosa che non capivo.
La casa era impregnata di odori tiepidi e stanchi: quello pungente della zuppa riscaldata troppo, la plastica dei giocattoli dimenticati sul tappeto, il profumo sbiadito del maglione di mia madre che sapeva di detersivo e lontananza. Quegli odori mi avvolgevano come una coltre sottile e densa. Un velo che non riuscivo a sollevare.
Il frigorifero emetteva un ronzio basso, costante, un respiro artificiale, un sussurro metallico che riempiva il silenzio. Sul tavolo, tre piatti aspettavano di essere usati, ma uno restava sempre lucido, immacolato. Lo guardavo come si guarda una porta chiusa a chiave. Sapevo che non si sarebbe mai aperta. Quel piatto vuoto era un vuoto più grande di qualsiasi cosa avessi mai provato. Dentro di me cresceva qualcosa che non aveva ancora un nome. Solo un peso greve e silenzioso.
Mia madre era seduta davanti alla finestra. La luce del pomeriggio le tagliava il viso in due, creando un confine netto tra chiarore e ombra. Sembrava scolpita nella sua assenza. Un monumento immobile alla sua perdita. Stringeva la tazza di ceramica con entrambe le mani. I suoi occhi fissavano il vetro, ma non il mondo fuori. Era persa in un luogo lontano. Un luogo dove io non potevo seguirla.
“Mamma, guarda. Ho fatto un disegno.” La voce mi uscì flebile, quasi un sussurro. Come se avessi paura che anche quella parola potesse spezzarsi nel silenzio.
Lei non rispose. Non si voltò. Restò immobile, come se il suo corpo fosse lì, ma la sua anima fosse svanita. Il tempo sembrò fermarsi in quella cucina piena di ombre.
“Mamma?” riprovai, un po' più forte. Nessun suono. Solo il ronzio del frigorifero, quel suono metallico che riempiva ogni spazio.
Il cuore mi batteva forte. Così forte che lo sentivo pulsare nelle tempie, nelle orecchie. Come se stesse per scoppiare. Un nodo gelido mi serrò lo stomaco, e la gola si chiuse in una morsa che mi impediva di parlare. Le mani divennero appiccicose. Tremavo leggermente. Come se tutto il mio corpo fosse un fragile cristallo pronto a frantumarsi.
La paura si insinuò dentro di me. Silenziosa e rapida. Mi bloccai. Le gambe non riuscivano a muoversi. Il respiro si fece corto e affannoso. Quel silenzio era un'ombra che si allungava. Una presenza invisibile che mi stringeva il petto.
Sul foglio giacevano linee storte: una casa con un tetto pendente, un bambino senza volto, un uccello blu con una chiave di ferro nel becco, pronto a volare via. Quei segni erano il mio tentativo di dare forma a ciò che non riuscivo a dire. Un linguaggio muto che parlava di solitudine e speranza insieme.
E se fossi io il motivo? Se fosse colpa mia che papà non tornava più? Se fosse colpa mia se la mamma non mi guardava più? Quelle domande bruciavano dentro, invisibili come la crepa nel cuore. Non avevo il coraggio di pronunciarle, ma mi tormentavano in silenzio. Come spine nascoste.
Mi rannicchiai sotto il termosifone spento. Il metallo freddo contro la schiena. Quel freddo era l'unica cosa reale in quel momento. Un contrasto netto con il calore incerto delle emozioni che mi travolgevano. Nascosi il foglio sotto il cuscino del divano. Un segreto prezioso. Un rifugio fragile da proteggere.
Il mio sguardo cadde su una piccola crepa nel muro. Impercettibile, ma lì. Come me. Invisibile agli altri, ma presente. Quella crepa sembrava crescere piano, allungarsi come un respiro lento e silenzioso.
Chiusi gli occhi e aspettai che accadesse qualcosa. Che la porta del disegno si aprisse da sola. Che l'uccello lasciasse cadere la chiave tra le mie mani. Che le linee blu del foglio si illuminassero, e mia madre tornasse finalmente a vedermi.
Ma niente accadde. Solo il silenzio che si faceva più denso, più pesante.
La televisione, accesa su un canale sbagliato, mandava pubblicità con voci stanche, sature di promesse vuote e sorrisi finti. Quelle parole senza senso mi sfioravano come onde leggere su una spiaggia deserta, senza lasciare traccia.
E il frigorifero continuava a ronzare. Il suo respiro metallico e implacabile. Come un cuore meccanico che non si ferma mai.
Quel giorno finì così. Con la porta del soggiorno socchiusa. Un piccolo varco che lasciava entrare un filo di luce tiepida, ma troppo debole per scaldare davvero.
E rimase così. Socchiusa. Per sempre.
La scena muta.
Era l'ultimo giorno della quinta elementare. Il cortile della scuola era un caos di sedie pieghevoli, genitori in attesa, bambini agitati con costumi buffi e magliette colorate. L'entusiasmo rimbalzava ovunque: tra le voci alte, i palloncini legati ai cancelli, le bolle di sapone che galleggiavano leggere prima di svanire nel nulla. E io, come sempre, ne restavo ai margini, un'ombra appena accennata.
Il giorno dello “spettacolo di fine anno”. I bambini ridevano, le maestre cercavano di mettere ordine con quei sorrisi stirati, quelli che si indossano solo nei giorni importanti, quando si deve fingere che tutto sia semplice e allegro. Ognuno aveva qualcosa da mostrare. Chi cantava. Chi ballava. Chi raccontava barzellette. Io, seduto in terza fila, stringevo le mani sudate sui jeans. Il cuore mi batteva così forte che temevo potesse sfondare il petto. Il respiro mi si fece corto, come se l'aria non bastasse più. Le gambe, improvvisamente leggere, mi sembravano sul punto di spezzarsi.
Andrea e Mattia si erano avvicinati quella mattina. Di solito mi ignoravano. A volte ridevano di me. Ma quella volta no. “Luca! Abbiamo avuto un'idea geniale!” mi dissero, con un'energia che mi sorprese. “Facciamo i versi degli animali! Tu sei bravissimo a imitare il gallo, dai, sarà uno spasso!
Ci iscriviamo insieme!”
Per un attimo, qualcosa si accese dentro. Una fiamma piccola ma viva, un calore inaspettato. Non solo volevano parlarmi; volevano esibirsi con me.
Scrissi i nostri nomi nella lista con la mano tremante. Il pennarello scivolava sulle lettere, ma avevo un mezzo sorriso che non riuscivo a nascondere. Dentro, il cuore sembrava saltare più in alto della paura. Forse, quel giorno, sarei stato davvero parte di qualcosa.
Arrivò il nostro turno. “Prossimo: Andrea, Mattia e Luca – imitazione dei versi degli animali.”
Mi alzai, il fiato sospeso, e cercai i loro volti tra le file, tra le teste dei genitori in piedi, dietro le tende del palco. Niente. Nessuna traccia. Il mio sguardo saettò, disperato, ma si scontrò solo con l'assenza.
La maestra mi fece cenno. “Dai, Luca, tocca a voi.”
Lo stomaco mi si chiuse in una morsa gelida. Salii sul palco. Solo.
Davanti a me, decine di visi. Cellulari alzati per filmare, occhi distratti, qualche bambino già pronto a ridere. L'aria mi sembrò improvvisamente più pesante, densa, quasi irrespirabile. Il sole mi scaldava la nuca, ma non bastava a sciogliere il gelo che avevo dentro. Il microfono gracchiò con un colpo secco, un suono che mi fece sobbalzare e amplificò il mio imbarazzo.
Feci il verso della mucca. Poi quello della gallina. Poi quello del pappagallo.
Una risata. Poi un'altra. Non erano risate buone. Erano quelle che graffiano l'anima. Quelle che ti spogliano di ogni difesa, lasciandoti nudo.
E lì, dietro un albero ai margini del cortile, li vidi. Andrea e Mattia. Con le mani sulla bocca, stringendo gli occhi per non ridere troppo forte. Era tutto uno scherzo. Una trappola crudele.
Il petto mi si svuotò. La luce puntata addosso sembrava bruciare la pelle. Eppure, in qualche modo, non crollai. Portai a termine l'esibizione come se stessi difendendo l'ultima, minuscola briciola di dignità che mi era rimasta.
Scesi dal palco con le orecchie che bruciavano, le gambe molli, lo stomaco raggomitolato come un pugno. Mi sedetti. Nessuno mi guardò. Nessuno parlò. Il mio mondo era tornato il solito.
Quella sera, in macchina, non si parlò dello spettacolo. Mia madre guidava in silenzio, forse convinta che fosse andato tutto bene, o troppo persa nei suoi pensieri per notare il mio tormento. Io fissavo il finestrino, i palazzi che scorrevano veloci, le luci gialle dei semafori che sembravano chiudersi una dopo l'altra, sigillando la giornata. Non volevo che lei mi vedesse. Non volevo nemmeno che mi pensasse, per non essere un ulteriore peso.
Lei non fece domande. E io, come sempre, non dissi nulla.
Quella vergogna accecante, quel desiderio bruciante di sparire, non era una novità assoluta. L'avevo già provata, sentita bruciare sulla pelle, solo pochi giorni prima.
Era mercoledì. Educazione fisica. L'odore acre di gomma e sudore della palestra, la luce fredda del neon che disegnava ombre lunghe, il rimbombo dei passi sul pavimento. Indossavo la maglietta bianca della scuola, troppo stretta. Quando correvo, si sollevava, lasciando intravedere la pancia.
“Dai, muoviti più veloce, palloncino!” “Sta per decollare l'airbag!” “Se corri più forte, forse la terra trema!”
Risate. Tante. Anche quelle di chi non diceva niente, ma rideva. Anche quelle fanno male.
Carlo mi diede una spinta sulla schiena. Inciampai. Ma non caddi. Mi girai. Lo guardai negli occhi. Ma non dissi nulla. La pelle mi pizzicava. Il viso mi bruciava. Dentro, qualcosa si era rotto. Ma in silenzio. Come vetro che si incrina piano, senza un suono.
Quella sensazione... La vergogna che ti accende la faccia. La voglia di sparire, di affondare nel terreno. La certezza che nessuno interverrà mai. Era diventata parte di me. Il mio zaino invisibile. Lo portavo ovunque, anche quando non lo vedeva nessuno, ma il suo peso era costante.
Tornai a casa più stanco del solito, con un peso invisibile sulle spalle. Zia Linda aveva lasciato il pranzo sulla tavola. Pasta al forno con le polpette. Il mio piatto preferito.
Mangiai in silenzio. Il profumo mi era familiare, avvolgente. Ma non bastava a scaldarmi, a sciogliere il nodo nel mio stomaco.
Poi mi sedetti accanto alla finestra. Il cortile era vuoto. Gli alberi sembravano immobili, in attesa. Restai lì a lungo, come se stessi aspettando qualcosa, una rivelazione, un messaggio che non arrivava mai.
Ma nessuno venne a cercarmi. Nessuno mi chiese come fosse andata.
A volte mi chiedevo se fosse colpa mia. Se avessi fatto qualcosa per meritare tutto questo, se fossi io a provocare quella crudeltà.
Mi guardavo allo specchio e cercavo disperatamente di cambiare il mio viso solo con gli occhi. Chiudevo forte le palpebre, fino a sentire un piccolo dolore, come se riaprendole potessi essere diverso. Più magro. Più simpatico. Più forte.
Ma ogni volta, ritrovavo lo stesso bambino. Con il magone nella gola, la paura negli occhi, e quella sensazione di invisibilità che lo avvolgeva.
La scuola era diventata un campo minato. Ogni giorno era una sfida sottile: evitare gli sguardi, non rispondere alle prese in giro, sperare di non essere scelto come bersaglio. Ma più cercavo di sparire, più sembravo attirare l'attenzione sbagliata.
Eppure, a casa, nessuno sapeva nulla. Perché io non parlavo. Perché volevo proteggere chi mi amava, da quel dolore, da quella verità. Anche se non mi capiva davvero.
Forse, crescendo, avrei dovuto imparare a chiedere aiuto. Ma in quel momento, ero solo un bambino.
Un bambino che stava imparando a nascondersi persino da sé, dietro a un muro di silenzio.
Le cose che non tornano
Quell'estate faceva un caldo torrido. Non il tipo di calore che ti invita al mare, ma quello che ti toglie la voglia di mangiare, di parlare, persino di pensare. Un'afa opprimente che si attaccava alla pelle come un velo umido e immobile. Le giornate si trascinavano, lunghe e lente, sotto un sole implacabile che trasformava ogni movimento in fatica.
Mamma e papà avevano preso in affitto la solita casa vicino al mare. Una routine rassicurante, ogni agosto. Dicevano che mi avrebbe fatto bene respirare aria nuova, che il profumo salmastro e la brezza marina avrebbero lavato via le scorie dell'anno scolastico. Lo dicevano con una contentezza forzata, quasi teatrale. Non sapevo se ci credevano davvero, o se era solo un modo per ignorare il silenzio che si era ormai depositato tra noi, come polvere su mobili lasciati troppo a lungo.
Avevano ragione. In un certo senso, avevano ragione.
Un giorno, inaspettatamente, arrivarono anche gli zii. E con loro, mia cugina Rossana. Non la vedevo da tre anni. L'ultima volta era stata solo un pomeriggio, un ricordo sbiadito. Questa volta, sarebbero rimasti per tutto il mese. La notizia mi colse di sorpresa.
Quando la rividi, un'ondata di panico mi travolse. Era come incontrare una sconosciuta con un nome familiare. Non ricordavo il suo viso, né la sua voce, e figuriamoci cosa dirle. La bocca mi si seccò, il cuore prese a battere in gola, come un tamburo impazzito. Temevo il suo sguardo. Temevo il confronto. Temevo l'ennesima conferma di essere sbagliato.
E invece, lei era rimasta incredibilmente la stessa. Solare, gentile. Con una risata cristallina che si espandeva nell'aria senza mai suonare stridula. Una risata che — lo capii subito — non sarebbe mai stata usata per ferire. Mi parlò con una naturalezza disarmante, come se ci fossimo visti la settimana prima. Come se gli anni non fossero passati. Come se non vedesse affatto il muro invisibile che avevo costruito attorno a me.
Io rispondevo a monosillabi. Le parole mi si rompevano in gola. Ma qualcosa, dentro, cominciò a muoversi. Una crepa, appena visibile. Un'incrinatura lieve.
All'inizio restavo sulle mie. Mi muovevo in silenzio, attento a non disturbare. Un'ombra sullo sfondo. Osservavo da lontano, pronto a sparire al minimo cenno d'attenzione. Ma poi... poi smisi di difendermi. Rossana non mi attaccava. Non giudicava, nemmeno con gli occhi. Mi coinvolgeva in giochi semplici, in chiacchiere leggere: sull'onda che si infrangeva, sulle forme delle nuvole.
Pomeriggi sotto l'ombrellone, a parlare del nulla. Eppure, quel nulla aveva peso, aveva dolcezza.
Una volta, seduti sulla sabbia tiepida, con l'acqua che ci lambiva i piedi, mi disse ridendo, gli occhi persi nel mare:
“Se potessi volare, andremmo lontano, vero?”
E per un istante la vidi davvero librarsi in aria, leggera, felice.
“Sì,” le risposi, stupito dalla mia stessa voce. “E non ci fermeremmo mai.”
Parlavamo di fantasie, ma ogni parola era una carezza. Un piccolo rifugio, dove la solitudine pesava meno.
E io... parlavo. Poco, ma parlavo. Ogni frase era un piccolo atto di coraggio, un varco nel silenzio.
Iniziammo anche a ridere. Una risata vera, che mi scuoteva il petto. La sera prendevamo il gelato sotto le stelle, con le luci del lungomare che tremolavano come piccole promesse. Giocavamo a carte sul balcone, illuminati dalla luna, mentre gli adulti chiacchieravano nel soggiorno, immersi nel loro silenzio distante.
Quel mese fu una tregua. Un'oasi nel deserto della mia quotidianità. Una pausa dal sentirmi sbagliato, invisibile, fuori posto. Come se, per una volta, il mondo non mi chiedesse di essere altro. Come se mi fosse concesso, anche solo per qualche settimana, essere semplicemente Luca.
Non durò, certo. L'estate finì in fretta, con l'odore d'autunno nell'aria. Rossana tornò nella sua città, nella sua vita piena e luminosa. E io, con un sospiro non più disperato, tornai nella mia. Nella routine.
Nelle insidie.
Ma qualcosa era rimasto. Non solo un ricordo. Una scintilla. Un residuo di calore inaspettato. Avevo assaggiato la sensazione di essere visto, accettato per ciò che ero. Senza doversi nascondere. E non mi faceva paura. Mi faceva bene. Scioglieva, piano, il ghiaccio attorno al cuore.
Forse per questo, quando cominciò la prima media, qualcosa in me era cambiato. Non un terremoto.
Un lieve spostamento, quasi impercettibile.
Mi misero in una classe tranquilla. Un ambiente ovattato, senza urla né gare per farsi notare.
Sembrava che il solito copione della mia vita stesse per ripetersi. Ma non successe.
Lorenzo — capelli spettinati, occhi furbi, zaino coperto di adesivi sbiaditi — si sedette accanto a me.
Senza presentazioni, si voltò e disse:
“Secondo te quanto duriamo prima che ci danno compiti?”
Risi. D'istinto. Una risata vera, senza pensarci. E lui rise con me. Aveva un sorriso contagioso, pieno.
In poco tempo diventammo amici. Di quelli veri. Con cui condividi i compiti impossibili, le figurine, le merende, e perfino le paure. Lorenzo non rideva mai di me. Mi ascoltava davvero, con occhi limpidi. E io facevo lo stesso con lui.
Certo, in classe c'era sempre chi non perdeva occasione per una battutina. Le risatine non mancavano mai, come un sottofondo stonato.
Ma stavolta... non ero solo. La solitudine non era più un muro invalicabile. Avevo Lorenzo al mio fianco. Un alleato.
Ero ancora fragile. E incerto. Le vecchie paure tornavano, a volte. Ma qualcosa era cambiato. Per la prima volta, non mi sentivo un errore da correggere. Un difetto da nascondere.
E dentro di me pensavo che forse — solo forse — quell'estate con Rossana era servita davvero a qualcosa. Aveva piantato un seme minuscolo, ma vitale, nel terreno arido della mia anima.
|
|
Biblioteca
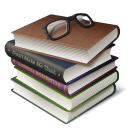
|
Acquista

|
Preferenze

|
Recensione
|
Contatto

|
|
|
|
|