
|
 Writer Officina Blog
Writer Officina Blog 
|
  Manuale di pubblicazione Amazon KDP. Sempre più autori
emergenti decidono di pubblicarse il proprio libro in Self su Amazon KDP,
ma spesso vengono intimoriti dalle possibili complicazioni tecniche. Questo
articolo offre una spiegazione semplice e dettagliata delle procedure da
seguire e permette il download di alcun file di esempio, sia per il testo
già formattato che per la copertina.
Manuale di pubblicazione Amazon KDP. Sempre più autori
emergenti decidono di pubblicarse il proprio libro in Self su Amazon KDP,
ma spesso vengono intimoriti dalle possibili complicazioni tecniche. Questo
articolo offre una spiegazione semplice e dettagliata delle procedure da
seguire e permette il download di alcun file di esempio, sia per il testo
già formattato che per la copertina. |
  Self Publishing. In passato è stato il sogno nascosto
di ogni autore che, allo stesso tempo, lo considerava un ripiego. Se da
un lato poteva essere finalmente la soluzione ai propri sogni artistici,
dall'altro aveva il retrogusto di un accomodamento fatto in casa, un piacere
derivante da una sorta di onanismo disperato, atto a certificare la proprie
capacità senza la necessità di un partner, identificato nella
figura di un Editore.
Self Publishing. In passato è stato il sogno nascosto
di ogni autore che, allo stesso tempo, lo considerava un ripiego. Se da
un lato poteva essere finalmente la soluzione ai propri sogni artistici,
dall'altro aveva il retrogusto di un accomodamento fatto in casa, un piacere
derivante da una sorta di onanismo disperato, atto a certificare la proprie
capacità senza la necessità di un partner, identificato nella
figura di un Editore. |
  Scrittori si nasce. Siamo operai della parola, oratori,
arringatori di folle, tribuni dalla parlantina sciolta, con impresso nel
DNA il dono della chiacchiera e la capacità di assumere le vesti
di ignoti raccontastorie, sbucati misteriosamente dalla foresta. Siamo figli
della dialettica, fratelli dell'ignoto, noi siamo gli agricoltori delle
favole antiche e seminiamo di sogni l'altopiano della fantasia.
Scrittori si nasce. Siamo operai della parola, oratori,
arringatori di folle, tribuni dalla parlantina sciolta, con impresso nel
DNA il dono della chiacchiera e la capacità di assumere le vesti
di ignoti raccontastorie, sbucati misteriosamente dalla foresta. Siamo figli
della dialettica, fratelli dell'ignoto, noi siamo gli agricoltori delle
favole antiche e seminiamo di sogni l'altopiano della fantasia. |
|
|
|
|
|
|
Conc. Letterario
|
|
|
|
Magazine
|
|
|
|
Blog Autori
|
|
|
|
Biblioteca New
|
|
|
|
Biblioteca Gen.
|
|
|
|
Biblioteca Top
|
|
|
|
Autori
|
|
|
|
Recensioni
|
|
|
|
Inser. Estratti
|
|
|
|
@ contatti
|
|
|
Policy Privacy
|
|
 Viale Thanatos
Viale Thanatos 
|

 Diego Anh.
Diego Anh.
Quando chiudo gli occhi, vedo ancora le luci oblique di certi pomeriggi e sento la voce di mia madre. Non so se siano ricordi veri o solo immagini di fotografie viste da bambino, echi lontani. So che c'era odore di benzina e che qualcuno piangeva. Forse ero io.
Arrivai in Italia poco prima di compiere sette anni. Mio padre era vietnamita, mia madre italiana, ma di loro non possiedo nemmeno una fotografia; mi rimane soltanto il secondo nome che mi diedero, Anh, affiancato a Diego, scelto dai miei genitori adottivi. Un nome doppio che mi porto addosso come un passaporto stampato sulla pelle, che decisero di lasciarmi, come un monile esotico da conservare in una bacheca. Anh in vietnamita significa luce o splendore, ed è usato per augurare intelligenza, o un futuro radioso.
«Così non dimentichi da dove vieni», dicevano. Mezzo nome che mi lega a un Paese che non conosco e mi ricorda una lingua che da tempo non sento più parlare, unito al cognome trevigiano dei miei genitori adottivi, i coniugi Pavan.
Io sono Diego Anh Pavan. Nato ad Hanoi, la città “tra i fiumi”, sospesa tra il Fiume Rosso e il Nhi Ha. Mia madre biologica, in una lettera scritta con inchiostro azzurro, diceva che l'aria lì sapeva di zenzero fresco, di motorini sfiatati e di fiori di loto sfatti dalla pioggia. Io, però, non ricordo quasi nulla. Non l'odore della pioggia sui tetti, non il suono degli aquiloni di carta nel cielo, solo — forse — la voce di chi un tempo mi cantava la ninna nanna.
Ero un pacco da spedire, con occhi a mandorla e mani serrate a pugno. Non parlavo, non piangevo. Mi misero su un aereo, poi su un altro. Gli adulti si passavano moduli da firmare sopra la mia testa, come se fossi mercanzia con l'etichetta sbiadita. Mi accolsero a Treviso, in una casa silenziosa, profumata di carta e legno antico. I miei genitori adottivi erano due insegnanti, metodici e gentili, che parlavano poco tra loro e molto con i libri. Non avevano figli. Avevano enciclopedie, orari, dizionari rilegati, tazze di tè dimenticate nei corridoi e sogni in ordine alfabetico.
Ma io non capivo da dove venivo, né a chi appartenessi veramente. Crescevo in una terra che non mi assomigliava, tra volti pallidi, giochi che non capivo e un dialetto veneto che all'inizio mi pareva una lingua straniera, abbastanza diversa dall'italiano che parlava mia madre.
A scuola mi guardavano come si osserva un insetto raro sotto vetro. I compagni mi fissavano con quella curiosità crudele che solo i bambini possiedono. Mi chiamavano “cinese”, ma io con la Cina non c'entravo nulla. Si tiravano indietro gli angoli degli occhi con le dita, ridendo. Io non rispondevo. Tornavo a casa e scrivevo numeri sui vetri appannati. I numeri mi davano la misura del mondo, mi rassicuravano, era l'unico linguaggio che non mentiva.
Ben presto tutti si accorsero che la mia mente divorava la logica. A otto anni risolvevo equazioni come se fossero indovinelli, a nove costruivo diagrammi sulle pareti con post-it gialli, a dodici calcolavo a mente le orbite dei pianeti e fantasticavo sui buchi neri come se fossero stanze in cui nascondermi.
«È un genio», dicevano gli amici dei miei genitori, tutti insegnanti, con quel tono di meraviglia che sa d'esibizione. A me davano pacche sulle spalle e occhiate di approvazione, ma era come se parlassero di qualcun altro. Per loro ero una storia da raccontare: l'esperimento riuscito, l'orfano prodigio, l'adozione illuminata.
Col tempo, il silenzio in casa si fece più gelido e profondo. I miei genitori adottivi smisero di toccarsi, di guardarsi, di stare insieme. Litigavano a bassa voce, come frane sotterranee, dietro porte chiuse che rimbombavano come fucilate. Alla fine arrivò il divorzio, e gli equilibri della mia vita saltarono di nuovo: ritornai a essere una specie di pacco postale, sospeso a metà, senza sapere chi fossi, troppo italiano per i vietnamiti, troppo vietnamita per gli italiani.
L'adolescenza fu biblioteche e numeri. Almeno i numeri avevano regole che nessuno cambiava. Nessuno mi inseguiva tra le pagine di Feynman o Dirac, nessuno sorrideva se capivo al primo colpo. Studiavo con sete di sapere, memorizzando formule come se fossero pezzi di me da ricomporre. Al liceo, divenni “l'animale esotico” più straordinario che gli insegnanti di fisica e matematica avessero mai avuto. Alla fine di ogni anno, mi assegnavano pomposamente il ‘dieci', sottolineando di non aver mai avuto uno studente così in tutta la loro carriera, e pronosticavano che sarei diventato un Galileo o un Newton.
Giunsi all'Università di Padova — Fisica, naturalmente — e per un attimo tutto sembrò possibile. Avevo una mente lucida, mani nervose e un desiderio cieco di affermarmi, di diventare qualcuno non definito dalle proprie origini.
Mi montai la testa e mi fissai un obiettivo ossessivo: volevo scrivere la teoria del tutto, unificare relatività generale e meccanica quantistica, che credevo di conoscere a fondo dopo qualche anno di studio. Ambivo a realizzare il sogno più alto di Einstein. Ero tremendamente presuntuoso, e questo mi portò a scontrarmi con i limiti della conoscenza umana, a capire che alcune verità sfuggono persino ai geni.
Studiavo giorno e notte, scarabocchiavo formule e mappe concettuali su quaderni, tovaglioli, persino sui vetri. Eseguivo calcoli mentali assurdi, ma non ottenni nulla di nuovo. Il fallimento fu totale e dolorosamente silenzioso. Dopo due anni di università, avevo accumulato solo pagine di calcoli inutili. E quando ne fui consapevole, ricordai la frase che ripeteva uno dei miei professori:
«Alcuni problemi irrisolti esistono per ricordarci che non siamo dèi.»
Ero dotato, certo, ma non un genio, o almeno, non abbastanza. La soluzione di un problema così complesso richiedeva un salto concettuale impossibile per questa epoca.
L'università non era come il liceo, dove stavo una spanna sopra tutti e mettevo in difficoltà persino i docenti. All'università ero sì un passo avanti ai compagni, più veloce e intuitivo, ma con i professori non avevo chance.
Il fallimento e lo sforzo immane mi provocarono un crollo emotivo. Dopo una sfilza di trenta e lode, affrontai un esame in condizioni disastrose e ottenni la prima bocciatura della mia vita. Mi sentii umiliato, come se stessi sprofondando sotto terra: avrei voluto scalare l'Everest e mi fermavo a malapena in cima a una collina.
Ero divorato da una sensazione di spreco e alienazione. Capii che forse non sarei mai arrivato a nulla di veramente nuovo e decisi di mettere in pausa la mia vita. Mi avvicinai alla vita notturna, conobbi l'alcol, o forse fu lui a riconoscere me. Prima birre con i compagni di studio, poi superalcolici in solitaria. Una sbronza dopo l'altra, come buchi neri in miniatura che mi risucchiavano le giornate e l'idea stessa del futuro. Fu l'epilogo della mia vita da fisico.
Se avessi continuato, sarei diventato un ricercatore svogliato o un docente con la cravatta macchiata di caffè, sempre con le stesse dispense da fotocopiare, ma cercavo un posto nel mondo dove smettere di sentirmi di passaggio.
A tutto questo si aggiunse una forte delusione amorosa, perché proprio in quel periodo persi la testa per una donna — ne parlerò più avanti — e quello contribuì a darmi il colpo di grazia. La natura mi aveva dotato di ottime capacità analitiche ma anche di una grande fragilità emotiva.
Lasciai l'università senza nemmeno comunicarlo ai miei genitori adottivi, che ormai si erano separati da tempo e avevano intrapreso ognuno la propria strada, formando nuove famiglie con i figli dei nuovi partner. All'inizio dei miei studi mi versavano regolarmente qualcosa sul conto e ogni tanto mi telefonavano; poi, col tempo, smisero di fare entrambe le cose. Dovetti inventarmi modi per sopravvivere, ma evitai lavori regolari con orari fissi che in quel periodo non avrei sopportato.
Inizialmente, per guadagnarmi da vivere, mi iscrissi a tutte le gare di matematica e fisica che assegnavano premi in denaro ai vincitori. In questo modo riuscii a racimolare qualche migliaio di euro. Era qualcosa, soprattutto sul piano della soddisfazione personale, ma troppo poco rispetto alle mie reali necessità.
Non avevo più nessuno a cui rendere conto, ero completamente libero: potevo fare qualsiasi cosa, anche autodistruggermi. Finii nel sottobosco padovano, frequentai i centri sociali e attraverso loro trovai posti precari dove dormire: mi svegliavo tardi, riposavo su materassi sfondati, con coinquilini di cui ignoravo persino il nome, mentre il mondo mi scivolava addosso come la pioggia su un impermeabile rotto.
Diventai un giovane alcolista solitario e invisibile, che galleggiava in giorni tutti uguali, con vestiti che profumavano di fumo e sudore antico, e uno stomaco svuotato di tutto, tranne che della nausea. Ogni sera promettevo a me stesso che sarebbe stata l'ultima bottiglia, e ogni mattina dimenticavo la promessa.
Qualche tempo dopo abbandonai Padova. Con i pochi soldi rimasti comprai un vecchio Fiat 238, così malconcio che il venditore lo chiamava "il Ragno": fumo nero filtrava da ogni fessura, come zampe di nebbia. Una vera carcassa ma con un motore da 1,2 litri che batteva inarrestabile. Lo foderai all'interno incollandoci spessi fogli di polistirolo e ci installai anche un WC chimico. Imparai il linguaggio di quell'anima testarda: i suoi borbottii, i suoi sussulti. Divenne un'estensione del mio corpo, ogni vibrazione un battito nel mio polso. Diventammo amici e, a poco a poco, cessò di essere un mezzo e divenne un luogo. Quella scatola di metallo, che parcheggiavo lungo gli argini dei fiumi o in riva al mare, si trasformò nella mia casa itinerante, un rifugio nomade che racchiudeva tutto il mio mondo. In un lento, ipnotico, andirivieni quel furgone-casa mi accompagnò per migliaia di chilometri. Divorai l'orizzonte del litorale veneto, per poi inseguire il vento più aspro e selvaggio della costa friulana, in un viaggio senza meta, dove l'unico vero obiettivo era il movimento stesso.
Dovevo dirvi qualcosa di me, prima di calarvi nelle tenebre di questa storia, alla quale sono legato da un filo che il tempo non spezzerà mai. È una di quelle storie di cronaca nera che macchiano per sempre, che rimangono nascoste tra le pieghe dei ritagli di giornale, ingialliti dal tempo, accaduta nella periferia di Milano, in una notte in cui il caldo appiccicoso incollava i vestiti alla pelle. È una storia sporca come le chiazze d'olio sull'asfalto di quella strada dove avvenne. Accaduta in uno di quei quartieri che la città dimentica: palazzine anni Settanta con le ringhiere arrugginite, parcheggi sterrati invasi da erbacce, e un viale troppo largo per essere un semplice stradone, troppo stretto per essere una tangenziale.
I residenti lo avevano soprannominato “il tratto maledetto” o Viale Thanatos.
Thanatos, dio della morte silenziosa. Non quella urlata, drammatica, teatrale — ma quella che arriva senza bussare, che ti tocca la spalla mentre stai guardando il cielo e ti dice: “È ora.”
Lì, negli anni, si erano accumulati incidenti come foglie morte in autunno: motociclisti sfracellati contro i lampioni, pedoni sbalzati in mezzo alla carreggiata, auto finite nei giardinetti con i paraurti conficcati nei tronchi dei platani. Nessuno sapeva bene perché: forse una curva disegnata male, forse la cattiva illuminazione, forse solo la malasorte che si era innamorata di quel pezzo di asfalto, o forse semplicemente l'uso smodato di alcolici e droghe delle ultime generazioni che a volte credono di volare come uccelli.
Ci fu la strage di un'intera famiglia di Lignano Sabbiadoro.
Camminavano lungo il marciapiede, stretti l'uno all'altro, come se il mondo fuori fosse troppo grande per loro. La madre sorrideva a qualcosa che il marito le aveva appena sussurrato, mentre le due figlie restavano un passo indietro. Ignari. Felici. Morti, prima ancora di rendersene conto.
L'auto piombò su di loro a fari spenti, senza preavviso. Si udì per una frazione di secondo il lamento stridulo degli pneumatici in curva — un urlo simile a quello di una bestia squartata — e poi l'impatto. Li spazzò via, scagliandoli in aria come fantocci lanciati da una catapulta. I corpi rotolarono sull'asfalto come sacchi vuoti, mentre il motore rombava via, divorando metri, secondi, vite.
Il tratto dove la famiglia di Lignano Sabbiadoro perse la vita divenne un piccolo santuario laico. Fiori di plastica sbiaditi dal sole, lumini spenti dalla pioggia, biglietti scritti a mano con frasi come “Non dimentichiamo” o “Perché voi sì e loro no?” Qualcuno inchiodò una croce di legno al tronco del platano più vicino all'impatto, un altro lasciò una scarpa da bambina, rossa, ancora leggermente sporca di fango.
La città ha provato a dimenticare — ha allargato il marciapiede, ha aggiunto un semaforo, presto pianterà nuove siepi per “proteggere” i pedoni — ma il viale ricorda. L'asfalto ricorda. E chi ci passa di notte, a volte, giura di sentire ancora quel lamento di gomma strappata all'aria, quell'urlo che non aveva niente di umano, che doveva essere il suono stesso della morte in arrivo.
A bordo c'erano quattro giovani che preferirono la fuga al soccorso. Lasciarono che l'asfalto si tingesse di rosso, premendo l'acceleratore invece del freno, e svanirono divorati dal buio della notte. Io in quel luogo non c'ero, eppure so cose che non sono mai finite su alcun verbale. Conosco i loro nomi. So cosa bevvero quella sera, cosa si dissero prima di dissolversi nel nulla. Ho scoperto molto delle loro vite. Vi racconterò ogni cosa, meticolosamente. Sarà come ricomporre un puzzle: sistemerò ogni tessera al suo posto, finché l'immagine non sarà completamente chiara.
Io non dimentico, non posso.
|
|
Biblioteca
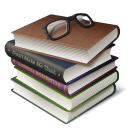
|
Acquista

|
Preferenze

|
Recensione
|
Contatto

|
|
|
|
|