
|
 Writer Officina Blog
Writer Officina Blog 
|
  Manuale di pubblicazione Amazon KDP. Sempre più autori
emergenti decidono di pubblicarse il proprio libro in Self su Amazon KDP,
ma spesso vengono intimoriti dalle possibili complicazioni tecniche. Questo
articolo offre una spiegazione semplice e dettagliata delle procedure da
seguire e permette il download di alcun file di esempio, sia per il testo
già formattato che per la copertina.
Manuale di pubblicazione Amazon KDP. Sempre più autori
emergenti decidono di pubblicarse il proprio libro in Self su Amazon KDP,
ma spesso vengono intimoriti dalle possibili complicazioni tecniche. Questo
articolo offre una spiegazione semplice e dettagliata delle procedure da
seguire e permette il download di alcun file di esempio, sia per il testo
già formattato che per la copertina. |
  Self Publishing. In passato è stato il sogno nascosto
di ogni autore che, allo stesso tempo, lo considerava un ripiego. Se da
un lato poteva essere finalmente la soluzione ai propri sogni artistici,
dall'altro aveva il retrogusto di un accomodamento fatto in casa, un piacere
derivante da una sorta di onanismo disperato, atto a certificare la proprie
capacità senza la necessità di un partner, identificato nella
figura di un Editore.
Self Publishing. In passato è stato il sogno nascosto
di ogni autore che, allo stesso tempo, lo considerava un ripiego. Se da
un lato poteva essere finalmente la soluzione ai propri sogni artistici,
dall'altro aveva il retrogusto di un accomodamento fatto in casa, un piacere
derivante da una sorta di onanismo disperato, atto a certificare la proprie
capacità senza la necessità di un partner, identificato nella
figura di un Editore. |
  Scrittori si nasce. Siamo operai della parola, oratori,
arringatori di folle, tribuni dalla parlantina sciolta, con impresso nel
DNA il dono della chiacchiera e la capacità di assumere le vesti
di ignoti raccontastorie, sbucati misteriosamente dalla foresta. Siamo figli
della dialettica, fratelli dell'ignoto, noi siamo gli agricoltori delle
favole antiche e seminiamo di sogni l'altopiano della fantasia.
Scrittori si nasce. Siamo operai della parola, oratori,
arringatori di folle, tribuni dalla parlantina sciolta, con impresso nel
DNA il dono della chiacchiera e la capacità di assumere le vesti
di ignoti raccontastorie, sbucati misteriosamente dalla foresta. Siamo figli
della dialettica, fratelli dell'ignoto, noi siamo gli agricoltori delle
favole antiche e seminiamo di sogni l'altopiano della fantasia. |
|
|
|
|
|
|
Conc. Letterario
|
|
|
|
Magazine
|
|
|
|
Blog Autori
|
|
|
|
Biblioteca New
|
|
|
|
Biblioteca Gen.
|
|
|
|
Biblioteca Top
|
|
|
|
Autori
|
|
|
|
Recensioni
|
|
|
|
Inser. Estratti
|
|
|
|
@ contatti
|
|
|
Policy Privacy
|
|
 Il riflesso della Chimera
Il riflesso della Chimera 
|

 La scena si era allargata, si disperdeva in mezzo al vasto spazio lu-minoso del Musée d'Orsay. Passavo di sala in sala, mi facevo largo tra la gente che si accalcava davanti alle opere dei grandi maestri di Francia, cercando qualcosa che non sapevo ancora di dover trovare.
La scena si era allargata, si disperdeva in mezzo al vasto spazio lu-minoso del Musée d'Orsay. Passavo di sala in sala, mi facevo largo tra la gente che si accalcava davanti alle opere dei grandi maestri di Francia, cercando qualcosa che non sapevo ancora di dover trovare.
Era domenica, avevo bisogno di restare solo, senza vedere nessuno, senza Séline, senza ascoltare Gilbert o Maryse.
Non riuscivo a smettere di pensare a quel viso, Nicole era partita per Bruxelles e da settimane non ne sapevo più nulla. La immaginavo tra quadri e gallerie, e forse era stato quello il motivo che mi aveva spinto ad andare lì. Avrei venduto l'anima per essere alla “Gare” con lei, ma come sapete al diavolo l'anima non la si vende, si finisce piut-tosto per regalargliela.
Dopo l'incontro in Boulevard Saint-Michel, non ero riuscito a tro-vare altre scuse per potermi allontanare, e non l'avevo più rivista.
Camminavo lentamente, osservando impressionisti e post-impressionisti; sedendomi ogni tanto su una di quelle panchette in finta pelle per i visitatori.
Era assurdo, ogni volta che mi soffermavo su un'opera, e cercavo di decifrarne il senso, era come se cercassi tracce di lei.
Aveva preso quel treno per Bruxelles, ed io non me l'ero sentita di indagare oltre. Mi bruciavano dentro domande che forse non avrei dovuto farmi.
Con chi sarebbe stata? Dove avrebbe alloggiato? Come avrebbe pas-sato tutti quei giorni? Non avevo voluto sottoporla a un interrogato-rio, non mi era mai piaciuto farlo con nessuno, figurarsi con lei.
Nicole te lo sbatteva in faccia, come una sberla: vedeva diverso, an-dava dritta a spiegarti perché piaceva a lei, non il soggetto dell'opera in sé; né le parole degli altri. Quali parole avrebbe usato di fronte ai quadri di Cézanne?
Era così se stessa quando si faceva trasportare dai nostri discorsi, aveva davvero uno sguardo unico, personale.
E dire che di persone che si vantavano della propria cultura ne ve-devo sovente: erano coloro che se ne andavano in giro con i loro ve-stiti ricercati, dicendo: «A noi piace questo, a noi piace quello; secon-do noi è vero, secondo noi è falso.» Nascondevano la propria visione dietro la sicurezza dell'élite a cui appartenevano. Lei non aveva biso-gno dell'approvazione degli altri, non cercava consensi o conferme, non usava quel “noi” collettivo.
Forse fu questo ad attrarmi fin dall'inizio: la sua capacità di met-termi in discussione, di sfidarmi, di spingermi oltre le certezze.
Lei non aveva paura delle opinioni diverse, non vedeva l'ora di af-frontarle. Con tutto quello che aveva passato, poteva aver paura di una sola cosa; ma quando arrivai a comprenderlo sarebbe stato tardi.
Avrei trovato solamente il mare.
Un'unica, iconica onda dipinta da Courbet nella sua potenza, con pennellate spesse e dense; un'onda travolgente, colta nell'istante esat-to in cui si infrange contro la spiaggia. Il mare è così vicino che sem-bra fuoriuscire dalla tela stessa, irrompendo nella sala.
Rimasi a lungo ad ammirare la lucentezza tetra che emanava, le nuvole, il cielo ridotto a piccoli lembi lacerati; le onde erano lette-ralmente placche di colore bianco. Mi ricordava le mareggiate di li-beccio ad Antibes, quando da bambino restavo con il mio amico a osservare le onde, giocando con i sassi.
A tredici anni, con lui, avvenne la scoperta delle ragazze (ci accor-gemmo improvvisamente che facevano parte del pianeta) e si parlava di tette, a quindici inaugurammo il periodo delle bevute in spiaggia, a diciassette confezionammo il nostro primo spinello durante una gita scolastica.
Nello stesso anno, approfittando di un fine settimana in cui i suoi genitori erano via, organizzammo una festa. Gilbert fece sesso per la prima volta, con una ragazza di Nizza; ne parlò per tre mesi.
Lo invidiai da morire, quindi venne anche il mio turno; capitò con una ragazza venuta da Reims nel nord della Francia.
Non avevamo visto nulla del mondo, e avevamo visto poco perfino della Francia; era il mare a portare loro da noi, tra quella luce della Riviera che ammaliava gli artisti, e ci andava bene così. Non avevamo la minima idea dei due uomini che eravamo destinati a essere.
Gilbert era già a Parigi quando arrivai, si era sistemato in uno di quei casermoni in Rue Gagnée. Non era il massimo, i soldi erano po-chi; ci adattammo.
Rimasi da lui per un anno mentre mettevo le mie radici in città, e se non eravamo ancora come fratelli, lo diventammo allora.
Lui diede retta a suo padre e si iscrisse a ingegneria; si laureò sei mesi dopo di me, nonostante avesse iniziato un anno prima.
Io non diedi retta a mio padre e a mia zia, né a mia madre; sostene-vano che stavo solo sprecando soldi, e che era inutile, che sarebbe stato meglio rimanere al negozio. A venticinque anni mi laureai in lettere antiche con il massimo dei voti e una lode.
Lui ed io non eravamo uguali, anche se ci conoscevamo da sempre, crescendo le nostre divergenze erano diventate un punto di confron-to, ma non ci reputavamo né superiori né inferiori l'uno all'altro; erano i miei genitori che facevano paragoni continui. Avevano passa-to decenni a farlo e non scesero dal pulpito neppure il giorno della mia laurea.
A Parigi mi ero “dato da fare” nel senso che con enfasi mio padre attribuiva al termine, però era lui quello che davvero “studiava”; co-me se potesse sapere qualcosa, avendo abbandonato la scuola per de-dicarsi al commercio di vini.
Forse, realizzò veramente cosa stessi facendo il giorno in cui attra-versò Place de la Sorbonne, per partecipare alla cerimonia di laurea.
Celebrammo insieme in un bel ristorante sulla collina di Mont-martre, oltre a Séline e ai miei genitori, non mancava nessuno dei nostri amici. Tra i diversi brindisi, mia zia chiese a Gilbert perché non avesse ancora concluso i suoi studi.
Mio padre fu subito pronto a difenderlo: «Lui studia ingegneria, è un'altra cosa.»
Loro avevano sempre una risposta pronta per tutto; non gli impor-tava che fossi realizzato, felice, o che semplicemente mi piacesse quello di cui mi occupavo. Non aveva importanza ciò che studiavo o la sensazione fantastica che mi attraversava al termine delle lezioni con i ragazzi. Consideravano solamente l'anno in cui avrei iniziato una carriera, raggiunto una posizione sociale, cominciato a versare dei contributi per la pensione.
Contava il giorno in cui avrei messo su famiglia, il giorno in cui avrei dato figli a Séline, nipotini per loro; con cui ricominciare da ca-po, in un infinito giro di giostra. Indossavano tutti la loro miglior ma-schera di scimmia: senza ascoltare, senza parlare, senza vedere.
La realtà dei fatti non si era piegata alle loro previsioni, ad Antibes avevano cercato di capirci qualcosa, si domandavano perché non fa-cessi ritorno.
Non mi ero laureato? Perché mi ostinavo a rimanere a Parigi?
Che novità era?
La novità era che Xavier Bouchard si era ritrovato a lavorare con la più vasta collezione di arte asiatica presente in occidente.
Il Musée Guimet ospitava oltre 45.000 reperti provenienti da India, Cina, Tibet, Giappone e dall'intero Sudest asiatico.
Émile Guimet aveva iniziato collezionando oggetti legati alle cre-denze e ai miti religiosi dell'umanità; nondimeno il suo museo “delle religioni” non ebbe successo: la borghesia benpensante dell'epoca lo considerò innanzitutto un museo “delle superstizioni”.
La parte ironica fu che, di quelle casse che arrivavano, il Louvre non volesse neppure saperne. Solo con l'Esposizione Universale del 1889 capirono il valore inestimabile della collezione; nel giro di poco il Guimet fu elevato al rango di museo nazionale e i manufatti defini-tivamente trasferiti da Lione a Parigi.
Si raggiunse un'intesa politica di massima con i ministeri coinvolti: gli oggetti relativi all'Egitto e all'arte classica greco-romana furono allocati al Louvre, mentre l'arte asiatica fu destinata al nuovo edificio in Place d'Iéna. Émile Guimet lo aveva fatto costruire sull'esatta copia di quello precedente a Lione.
La collezione originale si arricchì grazie a donazioni, lasciti e ai numerosi reperti “trovati” dagli esploratori francesi come Delaporte o Malraux nelle loro “escursioni” in Indocina. Era sufficiente che gli oggetti emanassero un vago sentore d'Oriente per essere destinati lì.
Come ogni fine settimana la “Gare” si riempì presto di visitatori, iniziai a dirigermi verso le scale al fondo dell'edificio, volevo man-giare qualcosa e fare una pausa al café che avevano aperto da poco al piano superiore.
Dall'alto la visuale che si ammirava era unica: ogni volta che entra-vo al Musée d'Orsay rimanevo impressionato da come una vecchia stazione ferroviaria (abbandonata, destinata alla demolizione) fosse diventata uno dei musei più moderni della città.
L'illuminazione della “Gare” era studiata in modo meraviglioso: combinava le luci artificiali dirette sui dipinti con la luce naturale che si diffondeva dalle enormi vetrate, riflettendosi sulle pietre chia-re dei rivestimenti.
Sotto la cupola neoclassica del Musée Guimet regnavano invece lu-ci fioche, polvere, corridoi stretti, ombre spesse tra teche espositive in vetro e legno scuro.
Era un edificio del tutto diverso, progettato alla fine del secolo scorso per custodire i suoi tesori, non per farli dialogare con il pub-blico; i progetti in ballo per il restauro imminente erano ambiziosi.
Sarei stato nel bel mezzo di un cambiamento epocale.
Ricordo che stavo per andarmene, non avevo pianificato di visitare quella sala.
Le donne dipinte da Gauguin emanavano una sorta di quiete pri-mitiva, ma non c'era vera gioia in loro, erano racchiuse in un silenzio ambiguo, come intrappolate nei labirinti dei propri pensieri.
Le foreste e le piante di Rousseau erano invece un concentrato di energia e colori vibranti. Mi fermai di fronte a quel dipinto: "L'incantatrice di serpenti".
Ero assorbito dalle tonalità intense e distinte di verdi e di gialli del-la vegetazione, risucchiato dagli occhi della figura al centro della composizione. Una figura completamente nera, nera come la pece, che al tempo stesso non vedi, ma che capisci essere il centro di tutto.
Poi i colori smisero di essere colori, diventarono altro; il verde smise di essere verde, il giallo smise di essere giallo.
Qualunque cosa stessi cercando era lì, davanti a me.
La foresta verde bruciava.
~
Non pensare e corri, Syd. Adesso corri e basta.
I pantaloni strusciavano tra le sterpi e le foglie marce, gli stivali sprofondavano improvvisi nel fango. Non potevo distrarmi.
Correre e tenere lo sguardo a terra per non inciampare. Correre e guardare dove mettevo i piedi, solo quello. Potevo farcela, dovevo arrivarci prima di loro.
Non pensare al villaggio adesso, muovi quel culo!
L'aria densa mi riempiva i polmoni, ero in un bagno di sudore, gli occhi bruciavano di sale e la vista si offuscava; rischiavo di inciampa-re in una radice.
Se non ti fottono loro, ti fotte Taylor. E se nessuno ti fotte, c'è l'ergastolo.
Lo zaino iniziava a tagliarmi le spalle, avrei voluto fermarmi e get-tarlo, bere un sorso d'acqua.
I muscoli delle braccia urlavano per la fatica di sostenerne il peso correndo. Ma non potevo lasciarla cadere.
Tu sei già fottuto, Syd, e lo sai bene, ma lei no non lo è. Portala via da qui!
Il cuore mi martellava nelle tempie mentre correvo lungo il sentie-ro. Avevo già percorso un paio di chilometri, non mancava molto, non poteva essere lontano. Lì avrebbe dovuto esserci la radura.
Non mi farò prendere adesso. Dovranno correre anche quegli stron-zi.
Facevo troppo rumore, per non parlare delle sue strilla, non aveva smesso un minuto. Mi sentivano sicuramente.
Certo che ti hanno sentito, puoi essere veloce di loro se vuoi. Portala via, sei in tempo, portala via da qui.
Attraverso la fitta volta di foglie vedevo un cielo grigio plumbeo, senza elicotteri, rallentai per qualche secondo. Lei continuava a stril-lare, non smetteva.
Perché nessun elicottero ripartiva? Non dovevano restare fermi nello stesso posto, altrimenti diventavano un bersaglio facile; te lo insegnavano il primo giorno: arrivano e ti scaricano, arrivano e ti re-cuperano.
«Dove cazzo siete?!», urlai.
Continuai a correre con il fiato che mi rimaneva; non riuscivo a te-nerla ferma, a ogni passo i suoi movimenti mi sbilanciavano.
Syd, è quasi fatta, lo vedi?
Mentre uscivo dalla penombra la luce mi accecò, rallentai un se-condo, e gli spari di AK-47 lacerarono l'aria, schegge di corteccia vo-larono ovunque.
Quel rumore inconfondibile rimbalzò tra gli alberi, moltiplicandosi in un eco di se stesso.
...rat-tat-rat-tat...
Il primo colpo mi raggiunse alla spalla, girai su di me, ma riuscii a mantenere l'equilibrio.
...rat-tat...
Ti hanno colpito! Ma tu sei uno fottuto a morire, non adesso, Syd!
Un dolore bruciante mi attraversò il ventre, facendomi cadere.
I suoni si affievolirono, come se qualcuno stesse abbassando il vo-lume al mondo. Le mie braccia si strinsero subito intorno a lei: aveva smesso di strillare.
Forse è ferita. Non la mollare!
~
«Monsieur?»
Il dipinto di Rousseau era ancora di fronte a me. Tremavo violen-temente, ero scosso da brividi freddi.
«Monsieur, si sente male?», ripeté la voce.
Era un uomo elegante, sulla cinquantina.
«Venga, forse è meglio se usciamo, ha bisogno d'aria.»
Mi lasciai guidare da lui attraverso le sale: le gambe mi cedevano, non avevano la forza di sorreggermi, la camicia si era intrisa di un sudore acido.
Uscii dalla cupola della “Gare” a pomeriggio inoltrato. Notai che il grande orologio sulla parete di vetro, dorato dal sole, segnava le quat-tro in punto. Quanto ero rimasto di fronte al dipinto?
Raggiunsi una panchina lungo la Senna, mentre la mia mente cer-cava di riconoscere il sogno, ma non funzionava, faceva fatica, era torbido: grumi di immagini e di volti fluttuavano in quel fluido con-fuso di parole e di eventi. E quelle immagini erano così nitide, dan-natamente nitide.
Qualunque cosa fossi venuto a cercare alla “Gare”, mi aveva trova-to.
|
|
Biblioteca
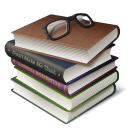
|
Acquista

|
Preferenze

|
Recensione
|
Contatto

|
|
|
|
|