
|
 Writer Officina Blog
Writer Officina Blog 
|
  Manuale di pubblicazione Amazon KDP. Sempre più autori
emergenti decidono di pubblicarse il proprio libro in Self su Amazon KDP,
ma spesso vengono intimoriti dalle possibili complicazioni tecniche. Questo
articolo offre una spiegazione semplice e dettagliata delle procedure da
seguire e permette il download di alcun file di esempio, sia per il testo
già formattato che per la copertina.
Manuale di pubblicazione Amazon KDP. Sempre più autori
emergenti decidono di pubblicarse il proprio libro in Self su Amazon KDP,
ma spesso vengono intimoriti dalle possibili complicazioni tecniche. Questo
articolo offre una spiegazione semplice e dettagliata delle procedure da
seguire e permette il download di alcun file di esempio, sia per il testo
già formattato che per la copertina. |
  Self Publishing. In passato è stato il sogno nascosto
di ogni autore che, allo stesso tempo, lo considerava un ripiego. Se da
un lato poteva essere finalmente la soluzione ai propri sogni artistici,
dall'altro aveva il retrogusto di un accomodamento fatto in casa, un piacere
derivante da una sorta di onanismo disperato, atto a certificare la proprie
capacità senza la necessità di un partner, identificato nella
figura di un Editore.
Self Publishing. In passato è stato il sogno nascosto
di ogni autore che, allo stesso tempo, lo considerava un ripiego. Se da
un lato poteva essere finalmente la soluzione ai propri sogni artistici,
dall'altro aveva il retrogusto di un accomodamento fatto in casa, un piacere
derivante da una sorta di onanismo disperato, atto a certificare la proprie
capacità senza la necessità di un partner, identificato nella
figura di un Editore. |
  Scrittori si nasce. Siamo operai della parola, oratori,
arringatori di folle, tribuni dalla parlantina sciolta, con impresso nel
DNA il dono della chiacchiera e la capacità di assumere le vesti
di ignoti raccontastorie, sbucati misteriosamente dalla foresta. Siamo figli
della dialettica, fratelli dell'ignoto, noi siamo gli agricoltori delle
favole antiche e seminiamo di sogni l'altopiano della fantasia.
Scrittori si nasce. Siamo operai della parola, oratori,
arringatori di folle, tribuni dalla parlantina sciolta, con impresso nel
DNA il dono della chiacchiera e la capacità di assumere le vesti
di ignoti raccontastorie, sbucati misteriosamente dalla foresta. Siamo figli
della dialettica, fratelli dell'ignoto, noi siamo gli agricoltori delle
favole antiche e seminiamo di sogni l'altopiano della fantasia. |
|
|
|
|
|
|
Conc. Letterario
|
|
|
|
Magazine
|
|
|
|
Blog Autori
|
|
|
|
Biblioteca New
|
|
|
|
Biblioteca Gen.
|
|
|
|
Biblioteca Top
|
|
|
|
Autori
|
|
|
|
Recensioni
|
|
|
|
Inser. Estratti
|
|
|
|
@ contatti
|
|
|
Policy Privacy
|
|
 L'Italia postunitaria (1861-1903)
L'Italia postunitaria (1861-1903) 
|
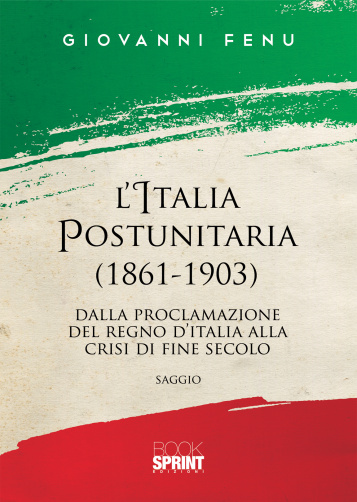
 Dalla proclamazione del regno d'Italia alla crisi di fine secolo
Dalla proclamazione del regno d'Italia alla crisi di fine secolo
La proclamazione del Regno d'Italia nel marzo del 1861, piuttosto che costituire il punto di arrivo del lungo processo risorgimentale, rappresentò l'inizio di una nuova fase unitaria che – seppur incompleta – poneva la classe politica di fronte al difficile compito di dotare il nuovo Stato di appropriate strutture politiche ed amministrative. In tale ottica la classe dirigente sabauda optò ben presto per un'estensione dell'apparato legislativo ed amministrativo del vecchio Regno di Sardegna al nuovo Stato unitario. Una decisione, questa, che di fatto sancì il carattere accentratore del processo politico amministrativo messo in essere dalla compagine politica governativa, e che avrebbe caratterizzato pertanto i primi decenni post-unitari, a scapito di quella opera di decentramento che maggiormente utile ed efficace si sarebbe rivelata, probabilmente, ai fini del perseguimento di una soluzione alle difficili condizioni in cui versava il Mezzogiorno. A ciò si sommava l'arduo compito di fronteggiare, da parte dell'esecutivo, una transizione verso un'effettiva unificazione – territoriale e culturale – tutt'altro che compiuta. Orfana del Veneto, delle terre “irredente” (Trento e Trieste su tutte) e del Lazio con Roma, capitale predestinata del nuovo Stato unitario, la Destra storica che avrebbe guidato le sorti del Paese per un quindicennio, aveva di fronte a sé il difficile compito di porre da un lato in essere una politica estera che garantisse l'acquisizione dei territori ancora mancanti, e dall'altro quello di sedare il malcontento delle plebi meridionali che erano restie ad assecondare quel processo di “piemontesizzazione” e – dal loro punto di vista – di vessazione che il governo centrale andava imponendo loro. Nel Mezzogiorno, infatti, il processo risorgimentale, inizialmente accolto con ampie speranze ed entusiasmo, finì ben presto – una volta andate disilluse le aspettative riposte nell'impresa garibaldina – con l'essere percepito alla stregua di un'occupazione politica e militare da parte dell'invasore piemontese. Una politica economica che finì col colpire i ceti più poveri (si pensi alla “tassa sul macinato”), una connivenza tra poteri statali e grandi proprietari terrieri assenteisti del Sud, unito alla mancata riforma agraria, nonché un governo visto come lontano e oppressivo, concorsero a far nascere il fenomeno del brigantaggio, espressione di un diffuso malcontento. La dura repressione messa in atto dallo Stato contribuì ad aggravare una situazione già tesa; l'uso della forza, infatti, finì col rendere ancora più precarie le nuove istituzioni monarchiche. Assai perspicaci sembravano essere pertanto le parole di Massimo D'Azeglio, secondo il quale “fatta l'Italia, bisogna fare gli italiani”. Nel frattempo con la disastrosa – seppur vittoriosa – Terza guerra d'Indipendenza (1866) che consegnava all'Italia il Veneto, e con la presa di Roma (1870) andava completandosi il processo risorgimentale e territoriale, con l'esclusione di Trento e Trieste; al contempo, inoltre, si acuiva ulteriormente la “questione romana”. Resi già difficili dalla politica apertamente laica messa in atto dai Governi della Destra storica, i rapporti tra Stato e Chiesa si complicarono ulteriormente dopo il 20 settembre 1870, con il Papa Pio IX deciso a ritenersi un prigioniero dello Stato italiano. La formula della “libera Chiesa in libero Stato”, cara a Camillo Benso conte di Cavour, finì col divenire un punto fermo dei governi postunitari, concorrendo così a prolungare per oltre cinquanta anni la situazione di tensione tra le due realtà.
L'esperienza della Destra storica si concluse nel 1876; l'avvento al governo di Agostino Depretis, se da un lato sancì la presa del potere da parte della Sinistra storica, dall'altro inaugurò quella politica del “trasformismo” che, durata sino al 1886, ebbe come effetto quello di immobilizzare l'attività del parlamento, a discapito di quelle riforme ritenute necessarie per affrontare i problemi del Paese. Le difficoltà della società italiana del periodo, infatti, erano numerose e avrebbero richiesto un'adeguata politica sociale; l'Inchiesta in Sicilia (1876) di Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino, e l'Inchiesta Jacini sulla condizione della classe agricola in Italia (resa pubblica nel 1884), portarono all'attenzione della classe politica le difficili condizioni di vita in cui si trovava a vivere ampia parte della popolazione rurale del Paese, soprattutto quella meridionale. L'inchiesta di Pasquale Villari, Scuola e questione sociale in Italia (1872), pose invece all'attenzione dell'opinione pubblica la piaga dell'analfabetismo (17 milioni di analfabeti al momento dell'unificazione) e il ruolo determinante che ciò aveva nel mantenimento delle condizioni di vita assai precarie delle classi sociali più disagiate. L'arrivo al Governo di Francesco Crispi (1887) se da un lato portò ad un sempre minore ricorso alla pratica del “trasformismo”, dall'altro impresse alla vita politica italiana una svolta autoritaria. Determinato a ribadire la supremazia dell'esecutivo sul parlamento, lo statista siciliano espresse tale volontà accentrando in sé la direzione del Ministero degli Interni e degli Esteri. Con la legge sulla pubblica sicurezza (1888) venne attuata una stretta intorno alle libertà di manifestazione e riunione che confermò la nuova tendenza ad un “autoritarismo moderato”. Una politica autoritaria che esplose tra il 1893 e il 1894, quando l'emergere di ampie manifestazioni di dissenso e protesta (i “Fasci siciliani” e le attività anarchiche in Lunigiana) condussero il presidente del Consiglio a inasprire i provvedimenti repressivi tramite la proclamazione dello stato d'assedio nelle regioni più turbolente. In politica estera il Governo Crispi perseguì una politica antifrancese sancita dalla stipula, nel 1882, della Triplice Alleanza; l'ammirazione smodata per Bismarck – al quale lo statista italiano non nascose di ispirarsi – portarono inoltre alla firma, nel 1888, della Convenzione italo-tedesca. La non troppo celata volontà di Crispi di fare dell'Italia una grande Nazione, al pari delle altre potenze mondiali, fu alla base dello sviluppo di una decisa politica coloniale. Ispirato, tra l'altro, da una malcelata volontà civilizzatrice, Crispi orientò ben presto le proprie mira verso l'Africa orientale. Le disfatte dell'Amba Alagi e di Macallè del 1895, e soprattutto la disastrosa sconfitta di Adua del marzo 1896, non solo posero un freno alle velleità coloniali del Paese, ma segnarono la fine politica di Crispi.
La caduta politica di Crispi condusse il Paese ad una crisi politico-istituzionale e all'intensificazione delle tensioni sociali, espressione dei profondi mutamenti in atto nella società italiana di fine Ottocento. L'avvio dello sviluppo industriale, lo svilupparsi di un sempre maggiore movimento operaio, l'influenza socialista, la meccanizzazione delle campagne, produssero profondi mutamenti nei rapporti sociali che uniti alla crisi economica e agraria in atto sin dal 1873-95, contribuirono a generare forti tensioni in ampi strati della società italiana. In tale ottica i moti popolari del 1898, che ebbero il proprio culmine nella sanguinosa repressione ordinata dal generale Fiorenzo Bava Beccaris a Milano nel mese di maggio, non furono altro che l'espressione ultima di un disagio delle classi più povere che, colpite dall'aumento del prezzo del pane, trovarono come ultima possibilità quella di manifestare in forme estreme il proprio disagio. Nel pieno della “crisi di fine secolo”, la miopia politica dei governi che si succedettero in pochi anni (dal 1896 al 1900 almeno) che videro nei moti una più o meno celata tendenza rivoluzionaria atta a sovvertire le istituzioni, portò ad un'involuzione autoritaria di origine crispina che caratterizzò, in particolar modo, gli esecutivi di Antonio Starabba marchese Rudinì prima e di Luigi Pelloux poi. In tale ottica l'uccisione, il 29 luglio 1900, di Umberto I ad opera dell'anarchico Gaetano Bresci, rappresentò il punto massimo della crisi di fine secolo, il compimento di quella parabola autoritaria che, negli ultimi quindici anni del XIX secolo, aveva raggiunto la classe dirigente liberale. Il Governo presieduto da Giuseppe Saracco prima e, soprattutto, l'esecutivo di Giuseppe Zanardelli poi, iniziarono a condurre il Paese verso quella transizione liberale-progressista delle istituzioni che avrebbe trovato il pieno compimento con i governi giolittiani di inizio Novecento. Ciò fu favorito anche dalla lungimiranza del nuovo sovrano Vittorio Emanuele III, che seppe recepire il cambiamento in atto nella politica italiana di fine secolo nonché le trasformazioni sociali in essere e, di conseguenza, affidare il governo a uomini liberali come Saracco prima e Zanardelli poi. Il discorso che Giolitti tenne il 4 febbraio 1901, in tal senso, poteva ritenersi come il “manifesto” di questa transizione; il successivo incarico che lo statista piemontese ricoprì agli Interni nell'esecutivo Zanardelli, rappresentò il punto di inizio di tale svolta, unitamente al decreto del 14 novembre 1901 sulle attribuzioni del Consiglio dei ministri – emanato da Zanardelli – che svincolando l'esecutivo dall'ingerenza della Corona, attuava di fatto quella svolta in senso liberale-progressista “figlia” dei difficili anni della “crisi di fine secolo”. |
|
Biblioteca
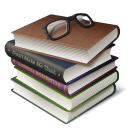
|
Acquista

|
Preferenze

|
Recensione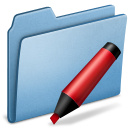
|
Contatto

|
|
|
|
|