
|
 Writer Officina Blog
Writer Officina Blog 
|
  Manuale di pubblicazione Amazon KDP. Sempre più autori
emergenti decidono di pubblicarse il proprio libro in Self su Amazon KDP,
ma spesso vengono intimoriti dalle possibili complicazioni tecniche. Questo
articolo offre una spiegazione semplice e dettagliata delle procedure da
seguire e permette il download di alcun file di esempio, sia per il testo
già formattato che per la copertina.
Manuale di pubblicazione Amazon KDP. Sempre più autori
emergenti decidono di pubblicarse il proprio libro in Self su Amazon KDP,
ma spesso vengono intimoriti dalle possibili complicazioni tecniche. Questo
articolo offre una spiegazione semplice e dettagliata delle procedure da
seguire e permette il download di alcun file di esempio, sia per il testo
già formattato che per la copertina. |
  Self Publishing. In passato è stato il sogno nascosto
di ogni autore che, allo stesso tempo, lo considerava un ripiego. Se da
un lato poteva essere finalmente la soluzione ai propri sogni artistici,
dall'altro aveva il retrogusto di un accomodamento fatto in casa, un piacere
derivante da una sorta di onanismo disperato, atto a certificare la proprie
capacità senza la necessità di un partner, identificato nella
figura di un Editore.
Self Publishing. In passato è stato il sogno nascosto
di ogni autore che, allo stesso tempo, lo considerava un ripiego. Se da
un lato poteva essere finalmente la soluzione ai propri sogni artistici,
dall'altro aveva il retrogusto di un accomodamento fatto in casa, un piacere
derivante da una sorta di onanismo disperato, atto a certificare la proprie
capacità senza la necessità di un partner, identificato nella
figura di un Editore. |
  Scrittori si nasce. Siamo operai della parola, oratori,
arringatori di folle, tribuni dalla parlantina sciolta, con impresso nel
DNA il dono della chiacchiera e la capacità di assumere le vesti
di ignoti raccontastorie, sbucati misteriosamente dalla foresta. Siamo figli
della dialettica, fratelli dell'ignoto, noi siamo gli agricoltori delle
favole antiche e seminiamo di sogni l'altopiano della fantasia.
Scrittori si nasce. Siamo operai della parola, oratori,
arringatori di folle, tribuni dalla parlantina sciolta, con impresso nel
DNA il dono della chiacchiera e la capacità di assumere le vesti
di ignoti raccontastorie, sbucati misteriosamente dalla foresta. Siamo figli
della dialettica, fratelli dell'ignoto, noi siamo gli agricoltori delle
favole antiche e seminiamo di sogni l'altopiano della fantasia. |
|
|
|
|
|
|
Conc. Letterario
|
|
|
|
Magazine
|
|
|
|
Blog Autori
|
|
|
|
Biblioteca New
|
|
|
|
Biblioteca Gen.
|
|
|
|
Biblioteca Top
|
|
|
|
Autori
|
|
|
|
Recensioni
|
|
|
|
Inser. Estratti
|
|
|
|
@ contatti
|
|
|
Policy Privacy
|
|
 Emozioni brevi
Emozioni brevi 
|

 Il sorriso rubato di Barnaby.
Il sorriso rubato di Barnaby.
Il —Circo Splendore— non era il più grande al mondo; era una piccola, dignitosa impresa a conduzione familiare che si muoveva con lentezza e orgoglio lungo la costa adriatica, fermandosi nei piccoli centri dove il grande spettacolo non arrivava. Il tendone, un'imponente cupola rossa e oro, era la loro cattedrale viaggiante. All'interno, l'aria era un denso strato di odori familiari e rassicuranti: zucchero filato vanigliato, segatura umida e un accenno pungente di feci di elefante (un profumo ereditato che persisteva nonostante gli elefanti fossero stati sostituiti anni prima da agili acrobati con costumi appariscenti).
Quella sera di fine estate, però, una pesante cappa grigia sembrava essersi abbattuta sulla magia.
Il proiettore gettava un fascio di luce giallastra e impietoso sul volto truccato di Barnaby, il clown principale. Il suo sorriso dipinto di rosso vivo, solitamente fonte di allegria immediata, sembrava stasera un'antica cicatrice, tirata e innaturale. Il suo costume, un caleidoscopio sbiadito di toppe e lustrini, luccicava tristemente sotto i riflettori. Non era la solita risata, quell'onda contagiosa e fragorosa che Barnaby era solito strappare al pubblico con una maestria quasi ipnotica, a riempire l'aria. Invece, si avvertiva un fastidioso, pesante silenzio, intervallato solo da un imbarazzato brusio di fondo.
Barnaby era un disastro. Un naufragio di goffaggine e insicurezza.
Il suo numero, di solito un vortice impeccabile di energia e gioia controllata, era una serie di errori patetici. Entrando in scena con il suo mini—carrozzino, inciampò sulla motocicletta prima ancora di montarci, provocando un rumore metallico sordo che fece sussultare i presenti. Recuperato il mezzo con un'espressione confusa e vagamente terrorizzata (che il trucco rendeva grottesca), tentò il suo celebre numero di giocoleria con le clave infuocate. Le fiamme si spensero in una nuvola di fumo acre che gli irritò gli occhi, e le clave caddero a terra come pesci morti, rotolando fino al bordo della pista. Il suo respiro era un ansimo irregolare che il microfono amplificava in modo sgradevole. L'imbarazzo e la paura del clown si propagarono fino alle prime file, dove gli spettatori, persino i più scettici, distolsero lo sguardo. I bambini, di solito i suoi più fervidi ammiratori, si guardavano incerti. Persino l'orchestra, guidata dal maestro Arturo, rallentò il ritmo, cercando invano di seguire i movimenti incerti del clown, finendo per produrre una melodia lamentosa.
Mentre cercava disperatamente di recuperare le clave, la sua mente era lontana dal circo, distante mille chilometri e concentrata su una sola stanza di ospedale. Ricordava l'ultima telefonata, pochi minuti prima di entrare in scena: la voce strozzata di Laura, l'unica donna che lo avesse mai amato per ciò che era sotto il trucco, e non per ciò che rappresentava.
—È successo di nuovo, Barnaby. Ho bisogno che tu venga. Subito. —
Quelle parole erano state come il crollo del tendone, eppure lui era rimasto lì, attaccato a un senso del dovere quasi folle. Non potevo, si era detto, il circo non può restare senza il clown. È un giorno di tutto esaurito. Il posto è qui.
Il climax, la gag finale che concludeva sempre il suo segmento, fu l'apoteosi del fallimento, un simbolo della sua angoscia. Barnaby prese il fiore finto all'occhiello, pronto a spruzzare un getto d'acqua in faccia a un volontario nella prima fila (una gag vecchia di decenni, ma sempre apprezzata). Premette il bulbo con la mano tremante. Il fiore fallì miseramente spruzzando solo un rivolo triste e tiepido che gocciolò sul suo papillon come una lacrima finta.
Un membro del pubblico tossicchiò. Poi un altro. Poi, un mormorio si diffuse come un incendio strisciante: delusione.
Dietro le quinte, la tensione era elettrica, palpabile come il filo dell'alta tensione. Il direttore del circo, il corpulento Sig. Petrov, attese che il sipario pesante, vellutato e sporco calasse per esplodere. Le vene sul suo collo taurino pulsavano come corde di violino.
Petrov non era un uomo crudele, ma la sua vita era il Circo Splendore, che aveva ereditato dal padre, un trapezista caduto, ed era stato ricostruito mattone su mattone, spettacolo dopo spettacolo. Viveva secondo una sola, sacra regola:
Lo spettacolo deve andare avanti. Sempre. La debolezza non è ammessa.
Barnaby non era solo il suo clown; era il cuore comico del suo show, l'attrazione di punta che riempiva i tendoni nelle serate estive. Vederlo disintegrarsi in quel modo era come assistere a una catastrofe finanziaria e morale in tempo reale.
Non appena il velluto rosso del sipario toccò il suolo, oscurando le luci della pista, Petrov si lanciò verso Barnaby con una furia primitiva.
— Che diavolo è stato? Barnaby! —ruggì, la sua voce profonda e ruvida come la ghiaia.
Afferrò il clown per il bavero del suo costume sgargiante, un tessuto che sembrava improvvisamente fragile, sollevandolo quasi da terra.
—La peggiore performance della stagione! In trent'anni di circo non ho mai visto una tale mancanza di professionalità! Sembrava che stessi ballando su dei carboni ardenti! Hai fatto affondare l'intero numero! Non l'hai neanche finito con dignità! —
Il colosso continuò a urlare, sputando saliva e frustrazione.
—Hai rovinato la serata! Un'altra performance così e sarai fuori, capito? Fuori dallo Splendore! Ti strappo il naso rosso e lo do in pasto alle capre! Il pubblico ci ride in faccia, Barnaby! Te ne rendi conto?! —
Barnaby, che di solito era un fiume in piena di chiacchiere, giochi di parole e risposte argute, non proferì parola. Di fronte alla furia cieca di Petrov, il clown era una figura svuotata, inerte. Il suo sguardo, nonostante il trucco esagerato, non era rivolto a Petrov, ma a un punto indefinito oltre il muro di tela del tendone, lontano, carico di un'angoscia palpabile che quasi faceva male a guardarla. Non c'era sfida o ribellione nei suoi occhi, solo l'ombra del terrore.
Si divincolò dalla presa di Petrov con una forza inaspettata – la forza della disperazione – e corse via, uscendo dal tendone laterale come un fantasma, senza neanche voltarsi. Petrov rimase lì, ansimando, con il sapore amaro della vittoria rovinata e della rabbia repressa in bocca.
Petrov imprecò, scuotendo la testa con veemenza. Non aveva intenzione di licenziarlo, ma la sfuriata era stata necessaria, un modo per ribadire la sua autorità. Si passò le mani sul volto rubicondo e chiamò la sua segretaria, l'anziana e saggia Signora Fina, chiedendole di preparare un avviso di licenziamento. Forse non l'avrebbe usato, ma la minaccia doveva essere concreta, per il bene del circo.
Mentre si dirigeva al suo ufficio improvvisato, i suoi pensieri erano un turbine di bilanci e lamentele. Fu allora che notò qualcosa di strano: la roulotte di Barnaby, parcheggiata in disparte dietro le gradinate, aveva la porta socchiusa e la luce accesa. Era un'anomalia; Barnaby era maniacale nel chiudere a chiave e riordinare prima di andarsene.
Una punta di curiosità, mescolata a un residuo di rabbia e, forse, a un accenno di preoccupazione che non osava ammettere, spinse Petrov in quella direzione. Si avvicinò e si infilò dentro, sentendosi subito invadente, un intruso.
L'interno era essenziale, un rifugio spartano per un artista. Contrariamente al caos che ci si poteva aspettare, era perfettamente ordinato: un piccolo letto a castello, un fornello a gas, scaffali pieni di libri sulla pantomima e la storia del circo, con volumi ingialliti su Charles Chaplin e Marcel Marceau. Sopra il piccolo tavolo da trucco, accanto a un naso rosso di lattice e a una parrucca arancione spenta, c'era un biglietto ripiegato in quattro. Era chiaro che Barnaby lo avesse dimenticato o lasciato in fretta, forse nel momento in cui la crisi era deflagrata.
Petrov esitò. Non aveva il diritto. Ma il biglietto sembrava quasi implorare di essere letto, la sua stessa forma spiegazzata gridava urgenza. Con un senso di colpa crescente, lo aprì.
La scrittura era una corsa di inchiostro tremolante e quasi indecifrabile. Petrov riconobbe solo la parola 'Laura' e, qualche riga sotto, un breve, straziante appunto:
Minaccia di aborto.
In calce, con un'ulteriore, frettolosa aggiunta a matita: Ospedale Sant'Antonio, Ostetricia, Stanza 301.
Il Sig. Petrov si sentì mancare il fiato. La carta gli cadde dalle mani sul tappeto sottile della roulotte. In quel momento, il suo dispiacere superò ogni rabbia. Non si sentì invadente, si sentì un mostro. Le sue parole cariche di veleno – il tuo sorriso deve restare – acquisivano un significato nuovo, agghiacciante: erano le stesse parole che Barnaby aveva usato per tormentarsi. Barnaby, quel bravo ragazzo, non aveva fatto la performance peggiore della stagione per disinteresse o negligenza; l'aveva fatta con un abisso di angoscia e lealtà nel cuore.
Capì tutto con brutale chiarezza. Barnaby aveva saputo della grave emergenza medica – il rischio che perdessero il bambino, il frutto di anni di sogni e tentativi – pochi istanti prima di andare in scena. Aveva combattuto una battaglia interna, la fedeltà al suo pubblico, la sua unica fonte di stabilità, contro l'amore per sua moglie, e in un gesto quasi eroico, aveva cercato di fare entrambe le cose. Aveva rimandato la corsa in ospedale per non abbandonare il suo posto. L'ansia, la paura per Laura e il bambino, gli avevano bloccato ogni vena comica, ogni barlume di gioia. Non era disinteresse, era terrore puro, la paralisi emotiva di chi affronta una minaccia reale e vitale.
Petrov raccolse il biglietto, le sue mani tremanti ora non per la rabbia, ma per la vergogna. Ripercorse mentalmente ogni insulto, ogni minaccia, e sentì un nodo stringergli la gola, denso e pesante. Il suo clown aveva messo il circo prima della sua famiglia. E lui, Petrov, l'aveva umiliato e punito.
Uscì dalla roulotte e si precipitò al camerino comune. Trovò gli altri artisti che si stavano cambiando, ancora scossi dalla pessima performance e parlavano a bassa voce. C'erano l'acrobata Elena, una donna snella e taciturna, il domatore Marco, grosso e barbuto, e l'illusionista Zoran, vestito in un elegante frac nero.
— Dov'è andato? — chiese Marco con voce sommessa.
— Sembrava che avesse visto un fantasma. —
Petrov sollevò il biglietto con un gesto brusco, quasi fosse una bandiera di resa.
— Silenzio — tuonò, ma la sua voce non aveva più la durezza di prima; era incrinata da un'emozione sconosciuta. Lesse loro il biglietto ad alta voce, ogni parola tremolante che Barnaby aveva scritto era un'accusa.
Un silenzio diverso, stavolta di profonda commozione, scese sul camerino. Elena si portò una mano alla bocca.
— Che incosciente — mormorò Zoran, l'illusionista, che in genere pensava solo ai suoi trucchi. — È andato in scena sapendo questo? Per chi? Per noi? —
— Per il circo — rispose Petrov, la voce rotta. — Per la regola stupida che io gli ho imposto. La stessa regola che mi ha reso cieco. —
Marco si avvicinò e mise una mano sulla spalla di Petrov, un gesto che non si sarebbero mai aspettati dal burbero domatore.
— Capo, l'uomo prima del tendone. Dobbiamo stargli vicino. —
— Dobbiamo andare — disse Petrov, la decisione chiara e urgente nei suoi occhi lucidi. — Barnaby ha bisogno di noi. E Laura ha bisogno di sapere che la sua famiglia è lì, non solo il suo clown. —
Elena fu la prima a muoversi.
— Prendo la macchina, la mia è una station wagon. È più veloce e spaziosa. —
Marco e Zoran annuirono. La critica per la performance di Barnaby era dimenticata, sostituita da una lealtà antica come la polvere del circo. In cinque minuti erano in strada, in una corsa folle verso l'Ospedale, un convoglio di personaggi eccentrici che sfidavano la notte.
Il viaggio fu un turbine di silenzio e ansia. Petrov guidava la vecchia station wagon di Elena, ignorando ogni limite di velocità. Le luci dei lampioni filavano via come astri impazziti, e le insegne al neon delle città si fondevano in scie rosse e blu. Per la prima volta da anni, Petrov non pensava al bilancio del circo, né alla prossima piazza. Pensava solo a Barnaby, l'uomo, il marito, non il personaggio.
Arrivati all'Ospedale, l'aria sterile e il profumo di disinfettante erano in netto contrasto con l'odore terroso e selvaggio del circo. Trovarono la stanza 301 al reparto di ostetricia. Laura era nel letto, pallida e stanca, ma il suo sorriso fragile e vero rassicurò tutti.
— È tutto a posto — sussurrò. — Mi hanno stabilizzata. La minaccia è passata. Abbiamo avuto paura, molta, ma il bambino è salvo. Sarà un bel maschietto, mi hanno detto. —
Il sollievo inondò Petrov e gli altri. Laura spiegò che Barnaby aveva fatto una scelta impossibile. Le aveva detto che non poteva mancare, aveva dovuto correre in scena, sentendosi un traditore. Poi, subito dopo il numero fallimentare, era corso da lei.
— Ma dov'è adesso? — chiese Petrov, sentendosi ancora in colpa, desideroso di chiedere perdono.
Laura sorrise. — È andato a prendere un caffè. Era troppo agitato per stare fermo qui. Mi ha detto che aveva bisogno di 'fare qualcosa di utile' mentre io riposavo. —
Ma la scena che attirò l'attenzione di Petrov non era lì, nella calma rassicurante della stanza 301.
Pochi metri più in là, nel corridoio del reparto pediatrico, le risate erano fragorose, quasi sfacciate. Non risate di circo, indotte da gag preparate, ma risate vere, gioiose, cristalline, che risuonavano nel corridoio freddo.
Barnaby era lì. Non aveva più il costume, ma solo una camicia stropicciata e i pantaloni larghi. Le lacrime avevano sciolto il trucco rimasto, lasciandogli il viso macchiato di rosso e bianco, quasi un volto in negativo. Stava parlando e gesticolando a un piccolo gruppo di bambini malati, alcuni su sedie a rotelle, altri nei loro letti. Li stava intrattenendo con una serie di magie improvvisate: un fazzoletto che svaniva, monete che apparivano e, in particolare, la sua celebre gag del pollice —staccato—.
I bambini ridevano a crepapelle, le loro piccole mani battevano con gioia. Quelle erano le risate più vere e gioiose che Petrov avesse mai sentito, perché non erano provocate da un personaggio, ma da un uomo che aveva bisogno di dare gioia per ritrovare la sua. Barnaby, nudo dal trucco e dal costume, stava curando sé stesso curando gli altri, trasformando l'ansia in una piccola, effimera meraviglia.
Petrov si avvicinò lentamente. I suoi colleghi si fermarono in rispettoso silenzio.
Petrov si tolse il cappello, un gesto che non faceva da decenni, il gesto formale di un uomo che ammette la sua inferiorità.
— Barnaby — mormorò, con la voce incrinata dall'emozione. — Mi dispiace. Mi dispiace di non averti chiesto perché. Mi dispiace per le mie minacce. Sei un clown fantastico, uno dei migliori. Ma soprattutto... sei un brav'uomo. —
Barnaby si voltò. Le lacrime avevano sciolto del tutto il suo trucco, rivelando l'uomo dietro la maschera. Guardò i suoi colleghi e il suo capo lì, con lui. L'angoscia era finalmente dissipata, sostituita da una calma gioia e dal sollievo.
— Grazie, capo — rispose, la sua voce solida. — Il 'Circo Splendore' è la mia famiglia. Sono sollevato. Ora posso tornare a farli ridere veramente. —
E con un inchino improvvisato, non al pubblico, ma ai bambini, si preparò a raccontare la sua gag del fiore che spruzza acqua. Questa volta, era sicuro, l'acqua sarebbe schizzata nel modo giusto, regalando un sorriso vero, un sorriso che, a differenza del trucco, non sarebbe mai svanito. Il sorriso ritrovato di Barnaby.
Il silenzio del carillon.
Elia Rossi non riparava orologi; riparava il tempo perduto. La sua bottega, in un angolo dimenticato del centro storico, era un labirinto di lancette rotte, molle arrugginite e carillon zoppicanti, dove l'aria profumava densamente di ottone lucidato, olio di macchina e anni trascorsi. A settant'anni suonati, Elia era diventato un relitto quanto gli oggetti che trattava, ancorato al suo bancone e, soprattutto, a un dolore sordo e persistente: la scomparsa della moglie, Anna. Da cinque anni, il tempo per Elia si era fermato al momento in cui aveva chiuso il loro armadio, lasciando intatti i suoi vestiti.
Il mondo di Elia aveva i ritmi metodici e implacabili del ticchettio. Tutto era misurato, logico, riparabile con pazienza e precisione. Tutto, tranne l'assenza di Anna. La sua mente, abituata a calcolare la tensione di una molla maestra al micron, non sapeva calcolare il vuoto lasciato dalla persona che era stata il suo centro di gravità. Ogni giorno era identico al precedente, una successione di minuti spesi a riportare l'ordine in meccanismi che avevano ceduto. Era una vita precisa e disperatamente in bianco e nero.
La routine si spezzò un martedì uggioso. Un corriere lasciò sul bancone una scatola di legno di mogano scuro, senza alcuna interazione. Non c'era mittente, solo il suo nome vergato in una calligrafia elegante, eppure sconosciuta. Elia la osservò per un tempo insolitamente lungo, la sua mano che sfiorava il legno freddo. All'interno, avvolto in un panno di velluto liso e sottile come una pelle antica, c'era un carillon.
Non un carillon qualunque, e Elia lo seppe un istante prima di vederlo completamente.
Era un pezzo antico, scolpito con intricati motivi floreali, identico, in ogni fessura e curva, a quello che Anna aveva amato e poi smarrito decenni prima, poco dopo la nascita della loro unica figlia, Sofia. Elia ricordava la disperazione silenziosa di Anna per quella perdita, un piccolo oggetto che per lei racchiudeva tutta la promessa della loro vita insieme. Per Anna, quel carillon era la melodia di un futuro felice. La sollevò, e la trama del legno era familiare sotto le sue dita ruvide. Era pesante, muto.
—Un pezzo stupendo, Elia, —lo interruppe la voce di Marcello, il suo socio quarantenne, l'unica persona che tollerava in bottega. Marcello era il pragmatismo, la modernità, l'approccio orientato al profitto. Elia era il passato, il valore sentimentale che superava quello monetario.
—Ma è completamente bloccato. E la consegna è strana. Niente bolla, niente nome... non mi piace. —
Elia non lo ascoltò, e per la prima volta da anni, ignorò la logica del commercio, la curiosità. C'era solo il carillon, e il fantasma di Anna che tornava a guardarlo, un'ombra dolce che lo fissava da dietro le sue spalle. Lo appoggiò con cura sulla sua tovaglietta di feltro verde, quasi fosse un cuore fragile che aveva appena smesso di battere.
Elia prese i suoi strumenti più delicati, una lente d'ingrandimento fissata sulla fronte e un bisturi sottile come il sorriso di Anna. Mentre studiava il meccanismo, il dito sfiorò accidentalmente il coperchio liscio e invecchiato.
Non ci fu musica. Ci fu un suono secco e inatteso.
Tum... tum... tum... (una pausa lunga un battito) tum... tum.
Un ticchettio meccanico, debole, quasi impercettibile, che squarciò l'aria densa della bottega. Una sequenza ritmica, non melodica, che sferragliò nell'aria. Tre colpi secchi, un attimo di silenzio, e poi due colpi rapidi.
Il bisturi cadde con un tintinnio sul bancone di ottone. Il cuore di Elia mancò un battito e riprese a correre all'impazzata, pompando sangue freddo nelle vene. Quella non era una melodia difettosa o un ingranaggio rotto. Era una bussata.
La loro bussata.
Quando Anna dimenticava le chiavi, cosa che accadeva spesso con la sua mente sempre occupata dai sogni, non suonava il campanello. Bussava tre volte sulla porta, si allontanava di un passo per la pausa rituale, e poi bussava due volte, in un'impazienza giocosa. Era un loro segreto, un dettaglio così intimo e irripetibile da non essere mai stato condiviso con nessuno. Era il loro codice d'amore, il loro segnale di accesso alla vita condivisa.
—Elia, cosa succede? Cos'era quel rumore? Hai rotto il meccanismo? — chiese Marcello, allarmato dal tintinnio e dal silenzio improvviso del socio.
—Niente, —mormorò Elia, la voce un raschio secco e quasi irriconoscibile.
—È il... il percussore che si è appena bloccato. Lasciami solo, Marcello. —
Una bugia, l'ultima delle quali aveva bisogno. Il ticchettio si era fermato subito dopo i cinque colpi. Elia non aveva dubbi: non poteva essere una coincidenza. Qualcuno, in qualche modo, conosceva il segreto. Qualcuno stava cercando di comunicare con lui, di svegliarlo. Ma chi? E perché usare l'oggetto più caro e doloroso del suo passato per un'operazione così misteriosa?
Nei giorni successivi, Elia si immerse completamente nell'oggetto, ignorando il mondo esterno. Il sonno divenne un lusso, il cibo una distrazione. Non lavorò più agli orologi dei clienti; il carillon era la sua unica ossessione, il suo unico scopo. Ogni pezzo che smontava era un passo indietro, un tentativo disperato di aggrapparsi all'illusione che Anna in qualche modo gli stesse parlando.
—Elia, devi smetterla, —lo ammonì Marcello, sempre più irritato dalla deriva mistica e professionale del socio.
—Quello è un pezzo unico, probabilmente vale una fortuna, e tu lo stai distruggendo! Sei troppo vecchio per farti ossessionare da un ricordo, e troppo bravo per buttare via il tuo mestiere per questo fantasma. —
—Non è un ricordo, Marcello, —replicò Elia, i suoi occhi color miele che brillavano di una luce febbrile che lo faceva sembrare più giovane e più pericoloso.
—È un indizio. Quella sequenza di battiti è... unica. Se qualcuno l'ha replicata, c'è un motivo. Un messaggio, non per la bottega, ma per me. —
Con un microscopio ad alta risoluzione e l'abilità accumulata in cinquant'anni di mestiere, Elia iniziò a smontare il carillon, ignorando la sua stessa regola fondamentale: mai riparare senza una previsione di successo. Rimuovendo strati di patina e metallo, trovò il meccanismo dei battiti. Non era un meccanismo a molla difettoso, come aveva fatto credere a Marcello, ma una piccola camma programmata.
Ma il mistero si infittì con una domanda più fredda: perché l'avevano nascosta così bene? E perché la busta non conteneva mittente? Se era un messaggio, chi ne aveva l'intenzione?
Sotto il rivestimento di feltro sul fondo della scatola di risonanza, Elia sentì una minuscola sporgenza. Non era una bolla dell'incollaggio, ma qualcosa di solido. Con il bisturi, sollevò con cautela uno strato di legno apparentemente incollato. Sotto di esso, incastonata e saldata al telaio in modo quasi chirurgico, non c'era un antico percussore in ottone, ma una microscheda moderna. Un circuito stampato, minuscolo, alimentato da una batteria a bottone.
Elia si sentì gelare. Il carillon non era antico. Era un falso, costruito con cura meticolosa per assomigliare al tesoro perduto di sua moglie. Tutta la patina, l'odore di vecchio, la sensazione di storia che lo aveva rassicurato e intrappolato per giorni... erano una menzogna elaborata.
Questa scoperta fu il suo punto di non ritorno, il momento in cui la rabbia sostituì il lutto. Qualcuno aveva speso tempo e denaro per ingannarlo, usando la sua perdita più profonda come strumento per attirarlo.
Il messaggio di Anna era un falso straziante, ma l'inganno era reale, e la precisione con cui era stato congegnato era una provocazione. Elia sentì l'amarezza svanire, sostituita da una feroce e inaspettata determinazione. Non c'era più spazio per la nostalgia languida. C'era solo la necessità di trovare l'autore di quella macchinazione, e di guardarlo negli occhi.
Con mani che, nonostante il tremore iniziale, ritrovarono l'antica precisione dell'orologiaio, Elia individuò un microinterruttore sulla scheda. Era un pulsante di attivazione, ben nascosto. Lo premette.
Un minuscolo raggio laser verde si proiettò dal carillon sul soffitto polveroso della bottega. Non mostrava immagini, ma una serie di caratteri alfanumerici: coordinate GPS.
Marcello, che stava facendo l'inventario degli oli lubrificanti, si avvicinò e lesse i numeri, visibilmente sconcertato.
—È un vecchio magazzino alla periferia della città, vicino al fiume, —disse, aggrottando la fronte.
—Abbandonato da anni. Cosa diavolo stai combinando, Elia? Ti ho detto di buttarlo via! —
—Lo scoprirò, —rispose Elia.
Afferrò il suo vecchio cappotto di lana, impolverato, e le chiavi della sua Fiat Uno, che aveva gli stessi anni di ruggine e saggezza di lui.
La suspense cresceva in lui, un misto di paura e adrenalina che non provava da decenni. La sua mente, abituata a calcolare il tempo, ora calcolava il rischio. Chi lo aveva attirato fin lì? Un ladro? Un truffatore che voleva estorcergli denaro? O qualcosa di peggio, legato davvero alla scomparsa di Anna, qualcosa che aveva deliberatamente ignorato? Ogni chilometro che percorreva, allontanandosi dalle luci rassicuranti del centro storico, era un passo più profondo nel mistero, e nel futuro che aveva evitato.
Elia trovò il magazzino, una struttura di cemento anonima e fatiscente, proprio come descritto. Le coordinate erano precise. Parcheggiò e si avvicinò alla porta di metallo arrugginita. Il lucchetto era assente.
Non era chiusa a chiave.
Entrò. L'interno era freddo, il vuoto amplificato dall'eco dei suoi passi. L'aria sapeva di polvere e muffa, un odore di morte industriale. Il luogo era illuminato solo da uno sprazzo di luce lunare, quasi chirurgica, che filtrava da una finestra alta. Al centro esatto del pavimento di cemento, c'era solo una cosa: una busta di carta semplice, posizionata con cura quasi fosse un'offerta.
A Elia Rossi.
La prese. L'aprì in fretta, il battito cardiaco che gli martellava nelle orecchie con la forza di un martello pneumatico.
All'interno c'era un unico foglio, ed un messaggio:
—Il tempo non è tornato indietro, Elia. Ma tu sì. Il carillon non ti ha guidato al passato, ma a ciò che ti manca, ciò che hai lasciato andare per la tua ossessione.—
Elia lesse la frase tre volte, poi una quarta. Ciò che gli manca... Il passato, per lui, era Anna, ma lei non poteva essere lì. Ciò che gli mancava, la sua assenza più grande, era solo sua figlia, Sofia, con cui aveva rotto ogni rapporto anni prima. Dopo la scomparsa di Anna, il loro legame si era lacerato, fino a rompersi completamente quando Sofia aveva deciso di lasciare la città, stanca della sua costante, ossessiva e immobile adorazione per la moglie perduta. Sofia aveva accusato il padre di aver imbalsamato la madre nella bottega, e lui non aveva avuto la forza di negare.
Elia era perplesso. L'amore per Anna l'aveva spinto, l'aveva sedotto, ma la destinazione reale era sua figlia?
Mentre Elia teneva in mano la lettera, i suoi occhi caddero su un piccolo oggetto che spuntava dalla busta. Era una vecchia fotografia, ingiallita dal tempo, piegata in un angolo. C'era lui, Anna e una Sofia bambina, seduta sulle gambe del padre, proprio davanti al carillon originale, sorridenti.
Ma sul retro della foto c'era un indirizzo, un altro indirizzo, scritto a penna con una freccia. Era un indirizzo di quella stessa zona, a un paio di isolati di distanza.
Elia capì. Il magazzino era solo una fermata intermedia, un test, un punto di svolta per farlo uscire dalla sua bottega e costringerlo a —vedere— la città, a guardare al di fuori della sua bottega.
Guidò per gli ultimi due isolati. L'indirizzo corrispondeva a un edificio moderno, ristrutturato di recente, un contrasto stridente con la fatiscenza del magazzino. Non una fabbrica abbandonata, ma un centro di accoglienza, con una grande targa lucida all'ingresso: —Il Centro Ritorno – Nuovi Inizi—.
Mentre Elia leggeva la targa, tutto si chiarì con una dolorosa e improvvisa lucidità.
Il carillon non era stato costruito per Anna. Era stato costruito da Sofia.
Sua figlia aveva dovuto usare il ricordo più potente e doloroso di suo padre (il carillon e il loro codice segreto) per spingerlo a muoversi. Sapeva che nient'altro avrebbe funzionato contro la sua riluttanza testarda a lasciare il passato. Il carillon non era la riparazione di un oggetto meccanico; era la riparazione di un uomo, un artificio d'amore disperato e preciso come un orologio di alta gamma.
Elia si ritrovò immobile davanti all'ingresso. Non c'era più suspense, non c'era più rabbia o paura. Solo la vertigine della verità e il peso del suo fallimento come padre.
In quell'istante, come se fosse stato programmato, le luci interne del Centro Ritorno si accesero, rivelando una figura in piedi nel corridoio. Era Sofia. Più matura, con le labbra serrate e un'espressione stanca ma risoluta che le tendeva gli angoli della bocca, una somiglianza improvvisa con Anna. Lo aveva aspettato, sapendo, sperando, che l'esca avrebbe funzionato.
Sofia uscì e si fermò sull'ultimo gradino. I loro occhi si incontrarono per la prima volta da cinque anni.
—Sei venuto, papà, —disse Sofia, la voce rotta da un'emozione che cercava di nascondere, ma che le sfuggiva negli occhi lucidi.
—Il carillon... la bussata... —mormorò Elia, la sua voce da raschio trasformata in un filo.
—Tua madre e io... —
—Lo so, —lo interruppe lei dolcemente, facendo un passo in avanti.
—Lo so che è il vostro segreto. E so anche che è l'unica cosa che ti avrebbe fatto uscire dalla bottega. Sono qui da un anno. Ho aperto questo centro e... ho una figlia, papà. Tua nipote, la tua copia in miniatura. Mi mancavi troppo per lasciarti lì a riparare il vuoto. —
Elia si avvicinò lentamente al gradino. Non era il climax di un film d'azione, ma di un dramma interiore che si scioglieva in un silenzio pacifico. Il silenzio tra loro era più eloquente di qualsiasi accusa o giustificazione.
Si abbracciarono. Un abbraccio goffo all'inizio, dovuto agli anni di distanza, che si strinse rapidamente in qualcosa di solido e duraturo, il vero ingranaggio rotto della sua vita. Il rapporto con sua figlia, l'assenza più dolorosa e autoimposta, era stato finalmente riparato.
Il mattino dopo, Elia tornò in bottega. Marcello era lì, più curioso che mai, che puliva l'olio da un cronometro da tasca.
—Allora? Cosa c'era in quel magazzino? —chiese, non tanto per sapere, ma per rompere il silenzio teso.
Elia sorrise, un sorriso che gli tirava la pelle in modo quasi doloroso per la mancanza di pratica. Prese il carillon falso, estrasse la microscheda di plastica e metallo e la gettò con disinteresse nel cestino.
—Non c'era niente, —rispose, allacciandosi il grembiule di cuoio sul bancone.
—Niente di riparabile, intendo. Era un ingranaggio rotto che è servito a far ripartire qualcos'altro. Qualcosa di più importante. —
Poi si sedette al bancone. Mise da parte gli orologi dei clienti per un attimo, gli oggetti in attesa di guarigione. Iniziò a lavorare su un nuovo pezzo, non per restaurare il passato, ma per costruire un nuovo futuro, una nuova melodia. Un piccolo carillon di legno chiaro, con la scatola di risonanza perfetta. Non conteneva il meccanismo per la melodia segreta di Anna, ma uno nuovo, luminoso e funzionante.
Il destinatario era la sua nipotina, e per lei, Elia avrebbe creato una nuova, bellissima melodia, un ticchettio di gioia anziché di assenza. Il tempo perduto era andato, ma il tempo futuro era appena iniziato.
|
|
Biblioteca
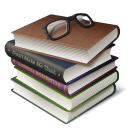
|
Acquista

|
Preferenze

|
Recensione
|
Contatto

|
|
|
|
|