
|
 Writer Officina Blog
Writer Officina Blog 
|
  Manuale di pubblicazione Amazon KDP. Sempre più autori
emergenti decidono di pubblicarse il proprio libro in Self su Amazon KDP,
ma spesso vengono intimoriti dalle possibili complicazioni tecniche. Questo
articolo offre una spiegazione semplice e dettagliata delle procedure da
seguire e permette il download di alcun file di esempio, sia per il testo
già formattato che per la copertina.
Manuale di pubblicazione Amazon KDP. Sempre più autori
emergenti decidono di pubblicarse il proprio libro in Self su Amazon KDP,
ma spesso vengono intimoriti dalle possibili complicazioni tecniche. Questo
articolo offre una spiegazione semplice e dettagliata delle procedure da
seguire e permette il download di alcun file di esempio, sia per il testo
già formattato che per la copertina. |
  Self Publishing. In passato è stato il sogno nascosto
di ogni autore che, allo stesso tempo, lo considerava un ripiego. Se da
un lato poteva essere finalmente la soluzione ai propri sogni artistici,
dall'altro aveva il retrogusto di un accomodamento fatto in casa, un piacere
derivante da una sorta di onanismo disperato, atto a certificare la proprie
capacità senza la necessità di un partner, identificato nella
figura di un Editore.
Self Publishing. In passato è stato il sogno nascosto
di ogni autore che, allo stesso tempo, lo considerava un ripiego. Se da
un lato poteva essere finalmente la soluzione ai propri sogni artistici,
dall'altro aveva il retrogusto di un accomodamento fatto in casa, un piacere
derivante da una sorta di onanismo disperato, atto a certificare la proprie
capacità senza la necessità di un partner, identificato nella
figura di un Editore. |
  Scrittori si nasce. Siamo operai della parola, oratori,
arringatori di folle, tribuni dalla parlantina sciolta, con impresso nel
DNA il dono della chiacchiera e la capacità di assumere le vesti
di ignoti raccontastorie, sbucati misteriosamente dalla foresta. Siamo figli
della dialettica, fratelli dell'ignoto, noi siamo gli agricoltori delle
favole antiche e seminiamo di sogni l'altopiano della fantasia.
Scrittori si nasce. Siamo operai della parola, oratori,
arringatori di folle, tribuni dalla parlantina sciolta, con impresso nel
DNA il dono della chiacchiera e la capacità di assumere le vesti
di ignoti raccontastorie, sbucati misteriosamente dalla foresta. Siamo figli
della dialettica, fratelli dell'ignoto, noi siamo gli agricoltori delle
favole antiche e seminiamo di sogni l'altopiano della fantasia. |
|
|
|
|
|
|
Conc. Letterario
|
|
|
|
Magazine
|
|
|
|
Blog Autori
|
|
|
|
Biblioteca New
|
|
|
|
Biblioteca Gen.
|
|
|
|
Biblioteca Top
|
|
|
|
Autori
|
|
|
|
Recensioni
|
|
|
|
Inser. Estratti
|
|
|
|
@ contatti
|
|
|
Policy Privacy
|
|
 Porto Vecchio
Porto Vecchio 
|

 Conobbi il signor Radović per caso. Curavo una rubrica di turismo per il giornale con cui collaboravo e, durante un giro nei paesi della Venezia Giulia, giunsi a Trieste. La città aveva sempre esercitato su di me un fascino particolare: avevo preso ad amarla da quando mio padre me ne aveva parlato la prima volta. Mi ci aveva anche portata, ma ero troppo piccola per conservare ricordi nitidi di quella visita. Eppure affioravano ogni tanto alla mia mente immagini di persone senza nome e nomi senza facce, mentre il mio legame con quel luogo si andava rafforzando col tempo. Per questo, una volta adulta, trovai il modo di recarmi lì ogni anno e, dopo che mio padre se ne fu andato, volli scrivere di Trieste e del segno che lui aveva lasciato su questa Terra, cercando di ricongiungere, in questo modo, il suo ricordo con il luogo natio, che aveva abbandonato nel lontano 1955 per vivere a Napoli. Da allora non ho più smesso.
Conobbi il signor Radović per caso. Curavo una rubrica di turismo per il giornale con cui collaboravo e, durante un giro nei paesi della Venezia Giulia, giunsi a Trieste. La città aveva sempre esercitato su di me un fascino particolare: avevo preso ad amarla da quando mio padre me ne aveva parlato la prima volta. Mi ci aveva anche portata, ma ero troppo piccola per conservare ricordi nitidi di quella visita. Eppure affioravano ogni tanto alla mia mente immagini di persone senza nome e nomi senza facce, mentre il mio legame con quel luogo si andava rafforzando col tempo. Per questo, una volta adulta, trovai il modo di recarmi lì ogni anno e, dopo che mio padre se ne fu andato, volli scrivere di Trieste e del segno che lui aveva lasciato su questa Terra, cercando di ricongiungere, in questo modo, il suo ricordo con il luogo natio, che aveva abbandonato nel lontano 1955 per vivere a Napoli. Da allora non ho più smesso.
▪●▪
Conobbi Radović tre anni fa. Me lo indicarono persone che avevano capito cosa stavo cercando. Forse più di quanto fosse chiaro a me stessa. Aveva 97 anni, ma mi sorprese la lucidità dei suoi ragionamenti. Ebbi subito l'impressione di avere scoperto un portale temporale, che apriva nuove pagine di storia a ogni racconto. Ci intendemmo subito e si mostrò addirittura entusiasta alla mia proposta di intervistarlo per pubblicare sulla mia rivista le sue storie. Decidemmo di intraprendere insieme questa avventura. Ci sarebbe voluto del tempo, ma lui mi dava l'impressione di aspettarsene ancora molto da vivere.
E ora sono qui a raccontarvi la sua storia, le verità di Radović.
▪●▪
Può cominciare dall'inizio? Che ne dice?
«Vuole sapere se ho raggiunto risultati nella mia ricerca della verità? L'unica cosa che sono riuscito a capire alla mia veneranda età è che nessuna mente umana è strutturata per concepire la verità, intendo nel suo insieme. Perciò nella storia che le racconterò non proverò a trarre conclusioni su dove essa si nasconda. E comunque si tratta della mia storia, ma anche su questo ho dei seri dubbi.
Sono nato il 9 marzo del 1925, III anno dell'era fascista, a Trieste, a casa dei miei nonni, nella parte alta della città. Mi hanno chiamato Italo e mi hanno detto che questo nome avrebbe radicato le mie origini. Ma so che è stata mia madre ad avere insistito, sicuramente a causa del mio cognome. Per un periodo eravamo la famiglia Radini, ma poi ne parleremo.
Mio padre, Ivan Radović, pescatore, era nato a Capodistria, viveva in una casa vicino al mare e si alzava di notte per uscire con la sua barca. Mia madre, Giustina Rossetti, era nata a Trieste, a San Giusto, proprio sul colle. Le avevano dato quel nome per devozione al patrono e anche per assolvere a un voto fatto in occasione del difficile parto di mia nonna. I miei si incontrarono sulla spiaggia in una giornata di bora ciara (Bora chiara, non tempestosa), mentre lei scrutava l'orizzonte e lui tirava in secca la barca. Da bambino ero affascinato da quell'incontro, che sapeva di favola e di destino, anche se credo che loro abbiano romanzato il racconto per renderlo un avvenimento epico, e così nel tempo ho conservato quell'immagine nella mia mente come fossi stato presente nel momento in cui lui si avvicinò e le chiese: “Come sta, signorina?”
Lei lo guardò senza vederlo, assorta nei suoi pensieri, poi lo mise a fuoco e accolse il suo sorriso sincero, premuroso, solido, questa era l'espressione che usava mia madre per descrivere il suo ricordo e poi sospirava ogni volta. Chissà perché aveva scelto proprio questo aggettivo, “solido”, che non è per niente adatto a un sorriso. Qualche volta ho pensato che l'importanza che entrambi dettero sempre a quell'incontro abbia lasciato un segno nel mio modo di relazionarmi con gli altri, senza riserve, lasciando aperte le porte del mio cuore. Ma più probabilmente è stato frutto dell'abitudine familiare di accogliere tutti con naturalezza.»
Ricorda quando ci siamo conosciuti? Io ero in visita al Magazzino 18, al Porto Vecchio, dove avevamo concordato di incontrarci. Capii che, al di là della mostra sulle masserizie dei profughi istriani, che avevano dovuto allontanarsi dalle loro case a causa della persecuzione di Tito, per lei quel luogo doveva significare qualcosa.
«Ha ragione. Ed è in questo che sta il motivo della scelta. Il Porto Vecchio è rimasto nella mia mente, come se mi appartenesse, come se qualcosa di me fosse nato lì. Ma forse, nella mia immaginazione di ragazzo, rappresentava sia un punto di partenza che di arrivo, un luogo circolare. E forse anche il passaggio, il transito, l'iniziazione alla vita adulta. Oggi quel luogo conserva la storia di tutto ciò, perché a tutti gli effetti è un porto vecchio, custodisce le memorie di chi vi è passato, rimaste incastrate tra quelle sedie accatastate del Magazzino 18, tra gli armadi ordinati, catalogati, nei cassetti che mimano la vita quotidiana della famiglia, con le posate, gli utensili, i taccuini dimenticati.
Cosa avranno pensato le persone, che avevano faticato tanto a portarle con sé, dovendo dire addio anche all'ultimo brandello di quella casa lasciata laggiù, in Istria, in Dalmazia, a Fiume!
Qualcuno avrà creduto di poter tornare a prenderle, per metter su una nuova vita, con quell'armadio al centro di una stanza nuova, con quella credenza in una cucina più bella. Il futuro ha portato lontano molti di loro, anche molto lontano. Oltreoceano. Chissà quante volte avranno ripensato a quel quadernino con le pagine vergate con cura, con i voti del maestro! A quella foto della madre che forse manca non solo al cuore ma anche al ricordo!
Se non fosse stato per quel geniale cantautore, molti italiani non saprebbero neanche che esiste questo luogo. È stato molto bravo a raccontare l'esodo di questi poveretti, a raccontarlo a tutti.
Ma ho voluto chiedere in giro per conoscere la vera storia di quello che noi a Trieste chiamiamo Porto vecio, il Porto Vecchio. Già, perché il nuovo è dall'altra parte, dove non si parla più di guerre, profughi e paura, ma di commercio fiorente, di viaggi. Da qualche anno Trieste è anche meta dei crocieristi e le imbarcazioni, superaccessoriate per offrire il massimo comfort ai passeggeri, sfidano con le loro prue orgogliose Piazza dell'Unità e la grandezza dei palazzi storici che la coronano, quasi volessero dire “Siete roba vecia, ora semo noi a comandar”.
Ma oggi Porto Vecchio sta diventando un polo museale, dove si trovano anche palazzi per convegni. Secondo me, questo investimento permetterà di preservare parte della nostra storia, evitando di radere al suolo tutto per costruire un qualche centro commerciale.
Quell'ampia area, che si estendeva dal Canal Grande fino a Barcola, isolata dalla strada costiera da barriere di cemento, nel periodo asburgico era divenuta il centro dei commerci triestini.
Ovviamente cercherò di mettere insieme i ricordi, scavando nella mia vacillante memoria.
Per cominciare, ero bambino e papà lavorava ai cantieri navali di Monfalcone, a pochi chilometri da Trieste. Proverò a partire da questo.
La Società Austriaca di Navigazione, di proprietà della famiglia Cosulich, che inizialmente aveva acquistato navi dalla Gran Bretagna, all'inizio del secolo aveva deciso di mettersi in proprio. Così, con il favore del governo austriaco, acquistò a Monfalcone alcuni bacini ricavati per estrarre materiali, dalle società impegnate nella costruzione del porto di Trieste. Mettendo su un'impresa che fece la storia, i Cosulich nel 1908 fondarono i Cantieri Navali Triestini. Furono furbi questi signori e neanche immaginavano allora quanta fortuna avrebbe portato a Monfalcone questa decisione. Fatto sta che, nel tempo, ai cantieri venne affiancato un vero e proprio villaggio industriale, Panzano, dove alloggiarono i dipendenti. La cittadella presto divenne un modello, proprio a causa dell'organizzazione interna. Una palazzina era riservata agli scapoli e una serie di costruzioni erano formate da appartamenti, ospitanti otto nuclei familiari, con gabinetto indipendente. Per quei tempi un lusso. Me li ricordo bene, ci abbiamo vissuto per anni in quel posto. Ovviamente i dirigenti alloggiavano in veri e propri villini. E, pensi, il villaggio era dotato di una mensa comune, scuole, giardini, spazi per lo sport e anche di un teatro. Purtroppo la prima guerra mondiale aveva assestato un duro colpo a tutto questo. Io non ero ancora nato, ma so che diversi macchinari, dopo che l'Italia si era schierata contro l'Austria, furono portati a Budapest per evitarne la distruzione, che arrivò per Monfalcone e per i cantieri proprio per mano dell'aviazione austriaca.
Quando ci lavorava mio padre si chiamavano Cantieri Riuniti dell'Adriatico e comprendevano anche i cantieri di Trieste e Muggia. Si iniziò a produrre anche aerei, che portavano il marchio CANT, la sigla di Cantieri Aeronautici e Navali Triestini, attività che fu potenziata dopo il 1933 e a cui fu affiancata la costruzione dell'Aeroporto di Ronchi dei Legionari.»
Se non mi sbaglio, ai Cosulich apparteneva anche la prima compagnia aerea italiana, la S.I.S.A. Società Italiana Servizi Aerei, fondata nel 1925. Mi pare che gli idrovolanti CANT 10ter si resero protagonisti di un evento di portata storica: inaugurando la prima linea commerciale italiana Trieste-Torino-Trieste.
«Non si sbaglia, vedo che si è preparata bene.»
Questa storia mi affascina. Ma continui a raccontare.
«Nel 1926 fu inaugurato il primo idroscalo di Trieste a fianco al Molo Audace, con una biglietteria in muratura, che è ancora esistente. Man mano che l'impresa fondata dai Cosulich entrava sotto il controllo statale, la famiglia di imprenditori vide sminuito il proprio ruolo, pur mantenendo una posizione di privilegio nella società.
Ora, per conoscere queste cose, basta andare al Museo della Cantieristica di Monfalcone, unico di questo genere in Italia, lo chiamano MuCa, ci sono anche diverse foto dei tempi in cui ci lavorava mio padre. Molti morirono a causa dell'amianto che era utilizzato nelle lavorazioni. Allora non si conoscevano i rischi dell'asbesto, questo il suo nome scientifico.»
Già, è vero, quanti danni ha prodotto l'uso dell'amianto.
«Mio padre, ricordo che tossiva sempre. Sì, nei miei ricordi è una delle sue caratteristiche che mi sono rimaste più impresse, come il fatto che, prima di entrare in casa dal lavoro, si toglieva la tuta e le scarpe e mia madre metteva subito tutto a lavare. Io credevo che fosse solo un gesto di abitudine e di pulizia. Tuttavia lui tornava sempre sorridente. Tossiva e sorrideva e, dopo aver mangiato quello che la mamma aveva preparato per tutti noi, mi prendeva in braccio e mi raccontava storie, le più strane, alcune non le capivo affatto, ma fingevo di sì perché me ne raccontasse ancora.
Ma, tornando al Porto Vecchio, che una volta era Porto nuovo, era stato costruito a metà dell'Ottocento dagli austriaci, che lo avevano collegato a Vienna con la ferrovia e lo avevano designato come porto franco. Poi era stato ampliato quando l'apertura del canale di Suez aveva disegnato nuove rotte commerciali per l'Europa. Dopo la guerra sappiamo che perse la sua centralità, perché la città non era più il porto dell'Impero, ormai sgretolatosi in diversi stati indipendenti. L'Italia, dopotutto, aveva altri porti nel Mediterraneo.
Il Porto Vecchio era il cuore di Trieste, l'anima di questa città che, pure nel suo aspetto architettonico, è diversa dalle altre in Italia, anche nella sua essenza, perché qui nessuno è straniero. Non dobbiamo dimenticare che qui ci sono sette cimiteri di altrettante confessioni religiose: oltre a quello cattolico, c'è il cimitero ebraico, quello greco-orientale e, dal 1849, quello mussulmano, solo per nominarne qualcuno.»
▪●▪
Mentre lui parlava, pensavo al legame di Radović con il mare: il padre pescatore, la storia marittima della sua città. Immaginai il senso di infinito radicato in quell'uomo e, da come mi parlava, intuivo che cento anni non dovevano essere per lui un traguardo ma un transito. La luce nei suoi occhi sembrava avvalorare questo mio pensiero e ciò mi affascinava.
▪●▪
Mi dica, signor Radović, a me non è mai capitato di sentirla, tranne d'estate e solo in qualche raffica, ma lei cosa mi dice della bora?
«La bora mi è stata sempre cara. A lei ho urlato nei momenti più duri il mio dolore, mentre portava via le mie parole di rabbia e mi lasciava credere di non essere solo. Ho pianto, glielo confesso. Ho calato la testa e ho pianto. Con quel vento qualche volta tornano da me le persone che ho perduto, mi sfiorano, mi parlano. Forse lì, nella bora, si nasconde la mia anima inquieta, quando sto troppo male. È lei che mi accarezza da quando non ho altro che me stesso, soprattutto da quando sono costretto a sopportare questo uomo vecchio, pesante, pessimista. È lei a schiaffeggiarmi quando sto per mollare, quando la depressione sale a rubarmi lo spirito.
Bora, chiara o scura che tu sia, mi sei compagna di vita, narratrice di storie lontane, che trasporti con il tuo odore di nuovo.
Della bora potrei dirle tante cose, lasciando stare le leggende che attribuiscono la sua origine al dolore di una fanciulla che soffriva per l'amore perduto. Se ne trovano a bizzeffe. Per esempio, ho sempre avuto la sensazione che l'aria a Trieste sia più pulita che altrove, nonostante non manchino le fabbriche o le automobili rilascino come ovunque i loro fumi tossici. E io credo che il motivo di questa sensazione sia proprio il vento, che spazza via i veleni, rinnovando l'aria. E così immagino porti via anche i brutti pensieri, quelli che fanno male se fermentano dentro la nostra testa, abbrutendo la nostra già animalesca natura.
Poi, è naturale per tutti gli altri, durante le giornate ventose, temere che dall'alto voli giù ciò che è rimasto incustodito o che non era fissato saldamente. Ma a Trieste ciò non può accadere, o almeno non ce lo aspettiamo, perché sappiamo che ciò che doveva cadere sicuramente è già caduto e, quando mettiamo fuori qualcosa, la fissiamo per bene. È per questo motivo che il triestino può pensare alle sue cose anche nel bel mezzo di una raffica di Bora. Si aggancia ai corrimano, si bilancia sulle gambe, che ha bene allenate, e va avanti felice.»
È nato nel ‘925, in periodo fascista. Cosa mi racconta della sua gioventù durante il regime?
«Avevo otto anni ed ero un Balilla, non mi ricordo come fu, ma lo erano tutti i bambini della mia età. Nel X anno dell'era fascista lo erano tutti. Calzoncini corti, fascia nera in vita, camicia nera, fazzoletto bianco, tenuto da una spilla al collo, e in testa un fez con tanto di fiocco e stemma con fascio al centro. Questa era la nostra divisa, un'appartenenza, l'orgoglio della Patria. Ordine e disciplina. Mio padre non aveva partecipato alla Marcia su Roma e non aveva nessun incarico nel Partito, era di idee diverse, in realtà, ma non si era mai dichiarato antifascista, tantomeno comunista. Eppure non voleva che noi avessimo problemi, quindi non obiettò neanche quando gli imposero la modifica del cognome in Radini, in nome dell'italianizzazione di ogni cosa che ricadesse nel territorio patrio. Una vera fesseria. Ancora non me la spiego. Fatto sta che andavo a scuola vestito in quel modo in tutte le stagioni. E sì che da noi d'inverno faceva freddo e le gambe scoperte diventavano livide. Un po' ci ero anche abituato, un po' mi congelavo lo stesso. Tuttavia l'Opera Nazionale Balilla ci aveva fornito di un giocattolo ambitissimo: il moschetto Balilla, un Carcano Mod.91 in miniatura con cartucce a salve per l'addestramento militare della gioventù fascista.
L'indottrinamento, quindi, non finiva a scuola, ma ci veniva praticato accompagnandolo con esercitazioni ginniche. Mens sana in corpore sano: un motto senza tempo. E di motti in quel periodo dovevi impararne molti, grazie anche al buon D'Annunzio, che ne aveva coniati di fantasiosi, buoni per ogni occasione della storia fascista.
Per cui, alla fin della fiera, si diventava fascisti così, un giorno dopo l'altro. Mio padre però, e credo anche mia madre, erano fiumi carsici, fluivano di nascosto e per tanti anni non seppi quali fossero in realtà le loro idee. Eppure crebbi con un certo senso critico, diciamo, con una solida morale, che prescinde dal credo ideologico. E di questo vado fiero ancora oggi.
“Fischia il sasso, il nome squilla dell'intrepido Balilla”: ancora oggi mi torna in mente come un ricordo della mia infanzia. E quanti ci hanno creduto davvero! Ma poi si scoprì che i sassi non fischiano, ma quando arrivano fanno male. Già, perché Balilla o non Balilla a scuola si era risaputo che il cognome originale di mio padre non era Radini e qualcuno avanzò che fossi slavo e, quindi, volarono le botte e anche le pietre. Non che ci fosse razzismo tra i due popoli, a meno dei soliti fanatici, ma già aver promulgato leggi che avevano imposto la “restituzione” o la “riduzione”, come la chiamarono loro, dei cognomi slavi a Trieste per qualcuno voleva significare che ci fosse differenza tra di noi. Quando si presentarono i veri problemi, dopo la guerra, mi tornarono in mente queste cose.»...
|
|
Biblioteca
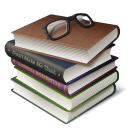
|
Acquista

|
Preferenze

|
Recensione
|
Contatto

|
|
|
|
|